Come si trasformano città e lavoro nell’era digitale
 Marco Castrignanò … [et al.], Riconfigurazione dell’azione pubblica e trasformazioni socio-territoriali, in Sociologia urbana e rurale, a. 45, n. 132 (2023), pp. 7-149
Marco Castrignanò … [et al.], Riconfigurazione dell’azione pubblica e trasformazioni socio-territoriali, in Sociologia urbana e rurale, a. 45, n. 132 (2023), pp. 7-149
Il dossier si compone dei seguenti contributi: “Neighborhood effect. Riflessioni a partire dall’esperimento Moving to Opportunity” di M. Castrignanò et al.; “Un’ecologia politica della transizione ecologica. Democrazia dei dati e monitoraggio civico del PNRR” di V. Martone; “Lo stakeholder mapping nelle politiche di turismo culturale. Sostenibilità e partecipazione: un’esperienza di ricerca” di G. Branca et al.; “De los conflictos mineros hacia la appropriacion del teritorio para su ordenamento” di I. Rodriguez; “Automobile e rassegnazione” di S. Pilotti; “La differenziazione delle identità dei luoghi e dei consumi nella città verticale” di F. Smania, L. Daconto; “Come rigenerare la città attraverso la tecnologia partecipata” di F. Corbisiero, F. Napoletano.
A cura di Carlotta Jesi, Intelligenza speciale, in Vita, a. 30, n.11 (nov. 2023), pp. 19-69
Il dossier tratta l’argomento della neurodivergenza cioè persone che hanno un funzionamento neurologico atipico e del loro inserimento lavorativo. Le aziende altamente tecnologiche cercano persone neuro divergenti, che hanno competenze particolari. Un fenomeno che rivoluzionerà il mercato del lavoro. Il dossier si compone di 3 capitoli che raccolgono diversi articoli: 1) “Mai stati così abili”; 2) “Noi disabili in carriera”; 3) “Noi che lavoriamo coi disabili”.
Antonina Zhelenkova, Teleworking, family, and income. A comparative study on five Western European countries, in Polis, a. 37, n 1 (apr. 2023), pp. 5-36
Lo studio analizza le interconnessioni tra il telelavoro, la famiglia e il reddito in cinque paesi europei (Italia, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito), su dati del periodo 2009-2015. I dati provengono dalle rilevazioni statistiche dell’Unione europea sulla partecipazione al mercato del lavoro delle persone con più di 15 anni d’età (European Labour Force Survey, EU-LFS). Scopo dell’indagine è capire se il telelavoro attenua lo svantaggio delle donne nel mercato del lavoro e come varia l’impatto del telelavoro sul reddito a seconda del livello di istruzione e della classe sociale. L’autrice discute i risultati ottenuti.
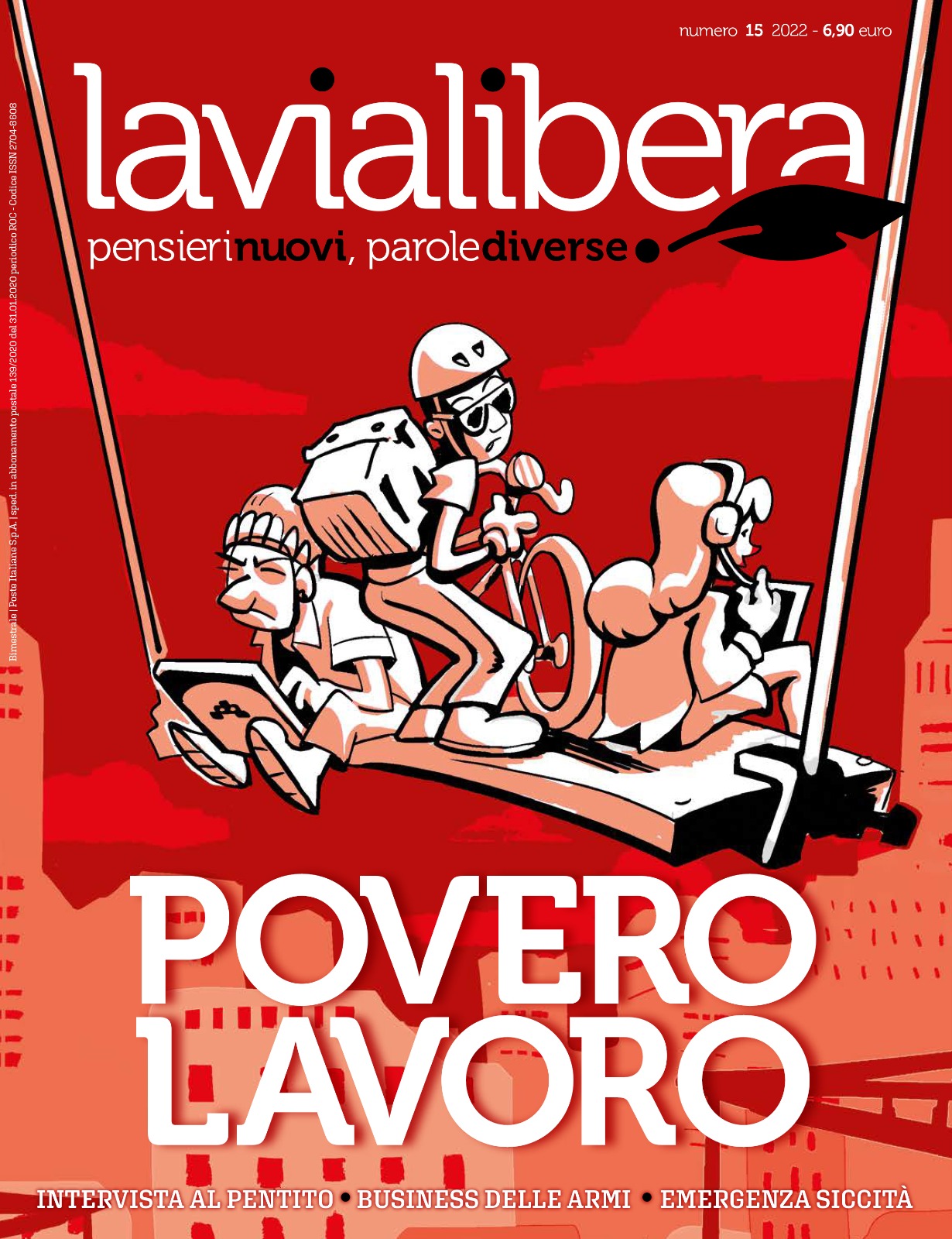 Andrea Dotti … [et al.], Povero lavoro, lavialibera, n. 15 (2022), pp. 23-44
Andrea Dotti … [et al.], Povero lavoro, lavialibera, n. 15 (2022), pp. 23-44
Il dossier di copertina di questo numero è un focus sul mondo del lavoro al giorno d’oggi, sempre meno pagato, con meno garanzie e più rischi. Si segnalano in particolare seguenti articoli: “Il futuro passa dai diritti digitali”, intervista al ministro del Lavoro Andrea Orlando sui diritti dei lavoratori riguardo a come i loro dati e prestazioni sono usati dalle aziende per monitorarli, e sui prossimi passi legislativi a riguardo; “La società delle performance soffre e non sa più sognare”, su come il nostro rapporto con il lavoro, che detta i ritmi della nostra vita, abbia effetti deleteri sulla salute fisica e psichica dei lavoratori, e su come le aspettative della società rendano complesso uscire da questo circolo vizioso; 7) “Dimissioni volontarie, è davvero una rivoluzione culturale?”, articolo sul fenomeno della “Great Resignation”, un grande aumento delle dimissioni negli ultimi anni, e su quali siano le cause, tra la scelta di mollare tutto per stare meglio, la “yolo economy” del salto nel buio, gli effetti dell’esplosione dello smart working nella pandemia, ma anche un promemoria che la “dimissione volontaria” non è una scelta che tutti i lavoratori possono fare.
Maria Francesca Murru, Intersezioni tra politica e logica dei social media, in Aggiornamenti Sociali, a. 73, n. 5 (mag. 2022), pp. 311-318
La narrazione di eventi di rilevanza collettiva, come la pandemia o la guerra in Ucraina, passa sempre di più sui social media, che vengono usati, secondo l’autrice, senza essere pienamente consapevoli delle logiche su cui reggono e delle implicazioni che ne derivano per la vita pubblica. L’autrice riflette sull’impatto dei social media sulla dimensione politica del modo in cui si realizza l’interazione tra i cittadini e su quali scelte possono essere assunte dalla classe politica al riguardo.
International Labour Organization (ILO), Global Employment Trends for Youth 2022. Investing in transforming futures for young people, ILO, Ginevra, 2022, 295 pp.
L’edizione 2022 analizza l’impatto della pandemia COVID-19 sui giovani e sulle loro prospettive rispetto al lavoro. I mercati del lavoro giovanili sono stati fortemente condizionati dagli effetti persistenti della pandemia, dai rischi geopolitici e dai rischi macroeconomici. Ad essi si aggiunge il potenziale danno permanente provocato da queste crisi sul meccanismo di funzionamento dei mercati del lavoro. Nel tentativo di affrontare queste molteplici sfide, i Paesi non devono perdere di vista le priorità a lungo termine. In particolare, investimenti mirati nelle economie verde, blu (oceano), digitale, creativa e dell’assistenza hanno un grande potenziale per fornire posti di lavoro dignitosi ai giovani e avviano, al contempo, le economie verso una maggiore sostenibilità, inclusività e resilienza.
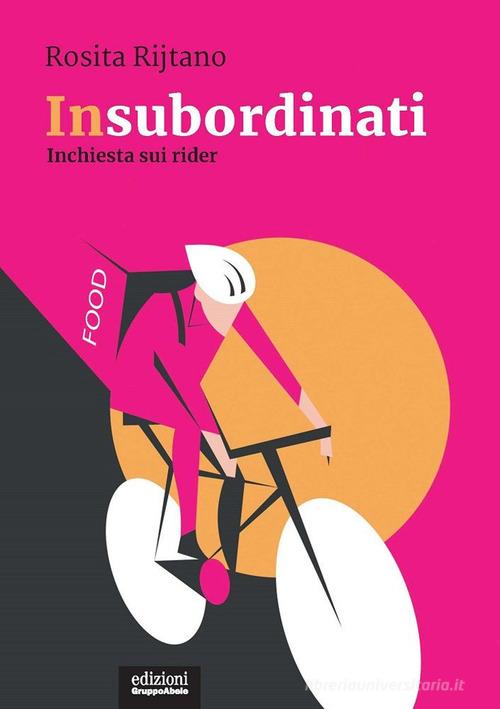 Rosita Rijtano, Insubordinati. Inchiesta sui rider, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022, 127 pp.
Rosita Rijtano, Insubordinati. Inchiesta sui rider, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022, 127 pp.
Il libro si basa sulla descrizione, tramite un’inchiesta condotta dalla giornalista autrice del testo, di tutto ciò che accade prima che ci venga consegnato del cibo a domicilio di cui i rider sono i protagonisti. Gli algoritmi che vengono usati dalle aziende del food delivery elaborano migliaia di dati e finiscono per essere responsabili di decisioni automatiche e importanti per la vita dei fattorini. Nel mercato del lavoro la lotta dei rider per ottenere riconoscimento dei diritti e delle tutele per un impiego sicuro e dignitoso diventa un banco di prova che coinvolge tutti noi. Sul tema si veda anche il testo di Valentina De Nevi, Uneasy rider. La storia nascosta del food delivery, Novalogos, Aprilia, 2022, 129 pp. (Coll. Bibl.: 20270) e quello di Marco Marrone ; prefazione di Federico Chicchi, Rights against the machines! Il lavoro digitale e le lotte dei rider, Mimesis, Milano ; Udine, 2021, 209 pp. (Coll. Bibl.: 19641).
Collocazione Biblioteca: 19437
Antonio Opromolla, L’esigenza di formare e sensibilizzare i decisori pubblici a una progettazione human-centered dei servizi pubblici, in RPS : La rivista delle politiche sociali, n. 3/4 (lug.-dic. 2021) – on line, pp. 267-287
Il contributo intende dimostrare l’esigenza di applicazione da parte dei decisori pubblici di modalità più innovative di interazione con i cittadini, considerati i numerosi cambiamenti della società negli ultimi decenni. Nell’era della trasformazione digitale, infatti, le nostre reti socio-tecniche diventano sempre più aperte, portando all’aumento della (auto)consapevolezza della centralità e del ruolo potenziale delle persone e dei cittadini. Per questo le pubbliche amministrazioni dovrebbero dotarsi di strumenti adeguati per affrontare la complessità che emerge da tale condizione, rendendosi disponibili a ripensare il rapporto con i cittadini. In particolare, il contributo intende mostrare da un lato come l’approccio del design thinking possa offrire strumenti e metodi preziosi ai decisori per raggiungere questi obiettivi e dall’altro come sia necessario un aggiornamento delle loro competenze e conoscenze. Nel paper vengono identificati i principali bisogni dei decisori in questo campo, insieme alla descrizione di un corso di formazione per decisori focalizzato sull’approccio del design thinking, strutturato sulla base di questi bisogni.
Fausto Durante, Lavorare meno, lavorare meglio. Appunti sulla riduzione dell’orario di lavoro per una società migliore e una diversa economia, Futura, Roma, 2022, 100 pp.
Fin dalla sua nascita, il sindacato ha avuto tra i propri obiettivi il controllo degli orari di lavoro per migliorare le condizioni di lavoratrici e lavoratori. Questo libro mette in relazione il tema dell’orario di lavoro con la crisi provocata dal Covid19, le sfide poste dal cambiamento climatico e da digitalizzazione e nuove tecnologie industriali, la necessità di costruire una società e un’economia diverse dal passato. L’insieme di questi elementi spinge in direzione di un nuovo impegno per la riduzione dell’orario di lavoro, con vantaggi per la produttività, l’economia, l’equilibrio tra vita e lavoro. Lo dimostrano le tante esperienze che nel mondo si stanno realizzando su spinta di governi e sindacati, così come gli accordi in tante imprese, di cui questo testo dà conto.
Collocazione Biblioteca: 19186
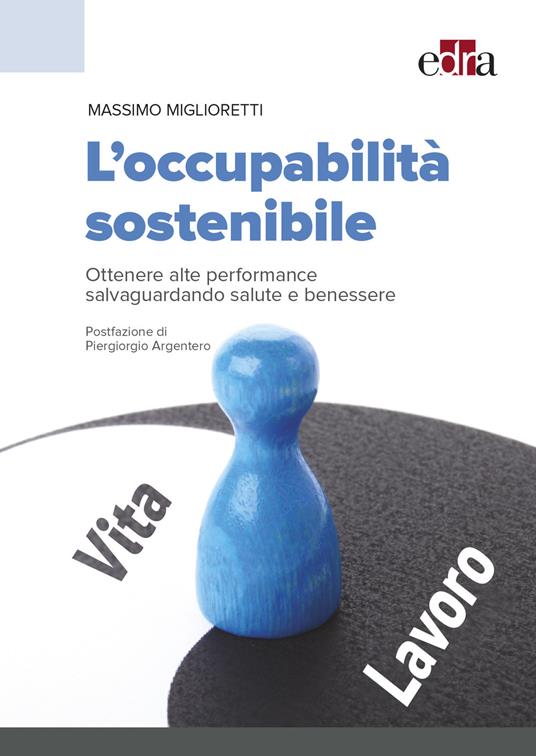 Massimo Miglioretti, L’occupabilità sostenibile. Ottenere alte performance salvaguardando salute e benessere, Edra, Milano, 2021, 137 pp.
Massimo Miglioretti, L’occupabilità sostenibile. Ottenere alte performance salvaguardando salute e benessere, Edra, Milano, 2021, 137 pp.
Il mondo del lavoro sta cambiando sulla scia delle tendenze demografiche e del progresso tecnologico. L’età dei lavoratori continua ad aumentare. Nel 2050, secondo le stime, il venti per cento della popolazione mondiale avrà più di sessant’anni. Lo sviluppo della tecnologia influenza il modo di lavorare e si parla sempre di più di industra 4.0, smart working e ‘internet delle cose’. In questo scenario bisogna interrogarsi su nuovi modelli organizzativi ispirati al paradigma dell’occupabilità sostenibile, per conciliare la competitività con la salute e la sicurezza. L’autore è docente di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l’Università di Milano Bicocca.
Collocazione Biblioteca: 19368
Angelo Mastrandrea, L’ultimo miglio. Viaggio nel mondo della logistica e dell’e-commerce in Italia tra Amazon, rider, portacontainer, magazzinieri e criminalità organizzata, Manni, San Cesario di Lecce, 2021, 169 pp.
L’Autore, scrittore e giornalista, indaga dietro le quinte nel mondo della logistica e dell’e-commerce – settori sempre più cruciali nell’economia capitalistica – su chi ci lavora, e a quali condizioni, e che costi sociali, economici e ambientali hanno le infrastrutture del commercio, sia quelle virtuali di internet e quelle materiali del trasporto di merci. In particolare sono descritti alcuni casi emblematici: l’assenza di tutele nel mondo di Amazon, le condizioni dei magazzinieri alla Città del Libro di Stradella, la ribellione alla mafia dei trasportatori di frutta della Geotrans in Sicilia, i viaggi intercontinentali delle navi portacontainer con i loro carichi di monnezza, e l’ultimo miglio dei rider, i ragazzi in bicicletta che consegnano il cibo nelle nostre case.
Collocazione Biblioteca: 19531
Ezio Manzini, Abitare la prossimità. Idee per la città dei 15 minuti, Egea, Milano, 2021, 178 pp.
La “città delle prossimità” di cui parla l’autore, specializzato nel campo del design per la sostenibilità e Professore onorario al Politecnico di Milano, è una città a scala umana, densa e diversificata nelle funzioni, caratterizzata da spazi pubblici e da un mix di attività residenziali e produttive. Una città in cui il valore della prossimità è evidente sia nella sua dimensione funzionale sia in quella relazionale. Una città che è vivibile perchè la prossimità che vi si trova è ampiamente diversificata, in quanto tutto ciò che si può volere – e si può volere fare – è vicino. Molte città nel mondo, tra cui Parigi, Barcellona, Milano, hanno preso degli impegni e stanno facendo dei passi in questa direzione. Così facendo ci mostrano delle anticipazioni concrete di ciò che questa città delle prossimità potrebbe essere: una città in cui innovazione sociale, beni comuni, comunità locali, cura e lavoro di cura diventano parole chiave di una progettualità che, grazie a infrastrutture coerenti (ivi comprese le piattaforme digitali il cui ruolo è oggi imprescindibile), accorcia le distanze, intrecciando costruzione e rigenerazione.
Collocazione Biblioteca: 20203
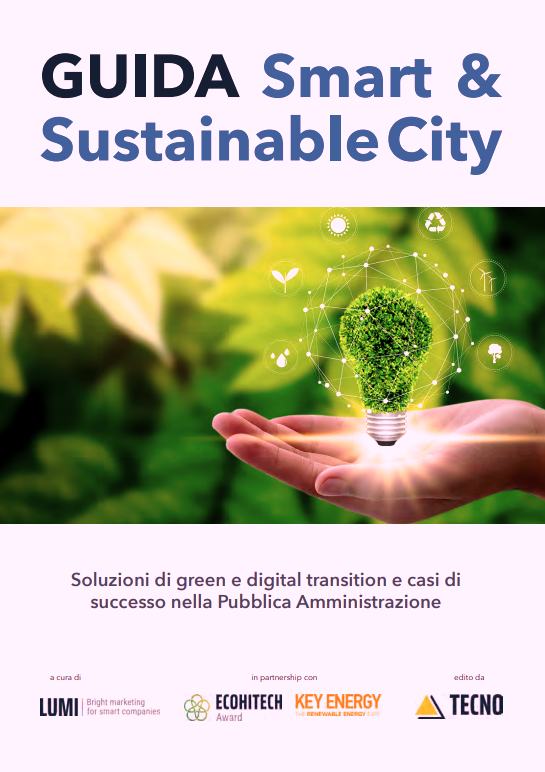 A cura di LUMI in partnership con Echohitec e Key Energy, Smart & Sustainable City. Guida 2022. Soluzioni di green e digital transition e casi di successo nella Pubblica Amministrazione, Tecno, Guanzate (CO), 2021, 60 pp.
A cura di LUMI in partnership con Echohitec e Key Energy, Smart & Sustainable City. Guida 2022. Soluzioni di green e digital transition e casi di successo nella Pubblica Amministrazione, Tecno, Guanzate (CO), 2021, 60 pp.
Oggi, parlare di smart city significa fare riferimento a un modello di città in cui si sono modificati i rapporti tra i vari soggetti (come cittadini e istituzioni) e soprattutto le dimensioni sociale, economica e ambientale con l’uso delle nuove tecnologie. La complessità di tecnologie digitali richiede prima di tutto conoscenza e l’utilizzo di un linguaggio comune per la raccolta e l’analisi dei dati. Le parole d’ordine sono quindi know how e interoperabilità. Oggi non si parla più soltanto di smart city, ma piuttosto di nuovi modelli di città sostenibile e digitale nei quali gli enti pubblici sono impegnati verso il raggiungimento di precisi obiettivi di sostenibilità, ottimizzazione, efficienza, digitalizzazione. Gli approcci sono diversi, ma hanno in comune tre principali obbiettivi: 1 – l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale; 2 – la digitalizzazione; 3 – il benessere, la salute e la sicurezza dei cittadini. In questa guida sono stati selezionati e illustrati alcuni casi guida di Pubbliche Amministrazioni e loro partner tecnologici che, attraverso politiche green e investimenti orientati allo sviluppo sostenibile e alla digital transformation, hanno raggiunto precisi obiettivi di efficienza energetica, basso impatto ambientale, utilizzo di fonti rinnovabili, utilizzo di dati per l’utilità e l’inclusione sociale, sistemi di monitoraggio ambientale. Sul sito di Lumi si trovano anche due articoli di Laura Baronchielli particolarmente interessanti su questo tema: IoT al servizio della Smart City: l’esempio di Torino e Smart Cities in Europa: 6 esempi a cui ispirarsi .
Nunzia Carbonara, Roberta Pellegrino, Lo smart working. Da pratica sperimentale a nuova normalità, Franco Angeli, Milano, 2021, 126 pp.
Le autrici, in questo libro, analizzano il fenomeno dello Smart Working in Italia e riportano i risultati dell’indagine empirica condotta a livello nazionale con l’obiettivo di fornire indicazioni ad imprese ed enti pubblici per una più efficace adozione dello stesso. Attraverso l’analisi dei dati, vengono evidenziati alcuni interessanti insight: non solo benefici per l’individuo, per la comunità e per l’impresa, ma anche un alert per le organizzazioni che vogliano compiere un primo passo verso uno Smart Working meno emergenziale e più efficace. Le autrici, docenti presso il Politecnico di Bari, inoltre delineano le opportunità derivanti dalla digitalizzazione nella trasformazione delle organizzazioni, sia pubbliche che private, e del mondo del lavoro dopo la pandemia, caratterizzando un fenomeno già in atto, il nomadismo digitale.
Collocazione Biblioteca: 19010
Annalisa Tonarelli, Digitalizzazione del lavoro e occupazione femminile, in La ricerca, a. 9, n. 19 (gen. 2021), pp. 25-28
L’autrice indaga sugli effetti del processo di smaterializzazione dell’economia, in atto da anni, sul lavoro delle donne e che, nel contesto eccezionale determinato dall’emergenza Covid-19, ha subito in pochi mesi una brusca accelerazione. In particolare, si domanda se la diffusione del lavoro agile, o comunque da remoto, prima osteggiato e oggi non solo previsto dai DPCM ma anche più appetito dalle imprese interessate a ridurre i costi di gestione, contribuisca o meno a ridurre le asimmetrie che ancora persistono tra le due componenti di genere.
 A cura di Paola Borz e Maura.De Bon, Il futuro già presente dello smart working. Strategie formative, ruoli e opportunità per il management, Franco Angeli, Milano, 2021, 155 pp.
A cura di Paola Borz e Maura.De Bon, Il futuro già presente dello smart working. Strategie formative, ruoli e opportunità per il management, Franco Angeli, Milano, 2021, 155 pp.
Fino a solo poco tempo fa, lo smart working, o lavoro agile, era un’esperienza che riguardava pochi nel nostro Paese. Allo stesso tempo, a livello internazionale, contributi autorevoli delineavano scenari di forte crescita a breve termine. Già nel 2016 il World Economic Forum lo individuava come il più potente fattore di cambiamento negli anni successivi e – in maniera quasi profetica – si riteneva che il lavoro da remoto avrebbe caratterizzato l’immediato futuro. L’anno 2020 ha decisamente accelerato questi processi, coinvolgendo anche soggetti che sarebbero forse arrivati a questo risultato in termini e tempi differenti. Il libro tratta di quali opportunità, quali complessità, quale leadership si possono delineare per Human Resource manager impegnati nella gestione degli smart worker e dei gruppi, sempre più misti, in cui le modalità di lavoro in presenza e a distanza, convivono; presenta inoltre alcune chiavi di lettura, che possono essere stimoli all’innovazione, alla luce dei risultati di monitoraggio e valutazione di alcune esperienze presentate dagli stessi protagonisti. Il testo raccoglie le rielaborazioni degli interventi del workshop “Il futuro già presente dello smart working. Quali strategie, quale ruolo per il managment” organizzato da Trentino School of Management e dalla Provincia di Trento il 13 aprile 2018 nel contesto della Trento Smart City Week.
Collocazione Biblioteca: 19016
