Alcol e alcolismo
Aggiornata a luglio 2023 – a cura di Paola Moriondo
I materiali elencati sono in ordine decrescente per anno di pubblicazione e sono disponibili presso la Biblioteca del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità previste dal regolamento della Biblioteca. L’elenco proposto non esaurisce quanto posseduto in biblioteca sul tema in oggetto. Ulteriori ricerche sono possibili sul nostro catalogo bibliografico. Sono anche presenti documenti scaricabili on line.
I percorsi tematici proposti sono i seguenti:
- Dati di contesto
- Comportamenti e problemi alcol-correlati
- Abuso, dipendenza e trattamento
- Comunità terapeutiche e gruppi di auto-aiuto
- La prevenzione, la riduzione del danno e le politiche
- I giovani, l’alcol, il binge drinking
- L’alcol, le donne, la gravidanza
- Alcol e anziani
- Sitografia
Dati di contesto
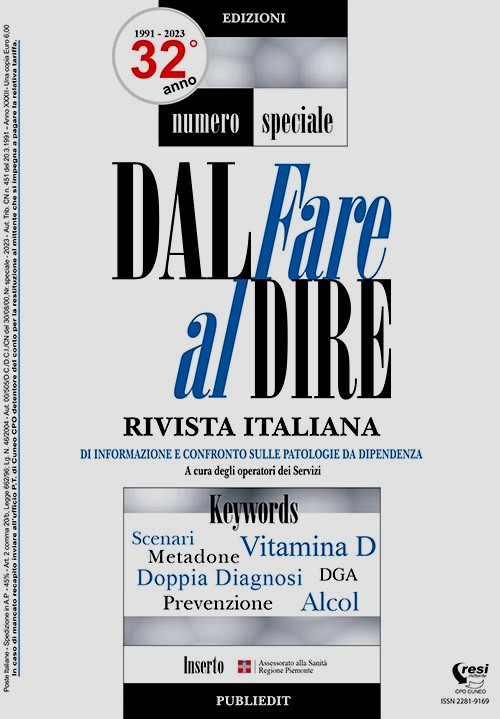 Claudio Leonardi … [et al.], Impatto Covid-19 su consumo di alcol e sostanze. Indagine breve su impatto della pandemia da Covid-19 rispetto alle abitudini di consumo di alcol e sostanze stupefacenti, in Dal fare al dire, a. 32, numero speciale (2023), pp. 44-51
Claudio Leonardi … [et al.], Impatto Covid-19 su consumo di alcol e sostanze. Indagine breve su impatto della pandemia da Covid-19 rispetto alle abitudini di consumo di alcol e sostanze stupefacenti, in Dal fare al dire, a. 32, numero speciale (2023), pp. 44-51
La ricerca ha indagato sull’impatto della pandemia da Covid-19 rispetto alle abitudini di consumo di alcol e sostanze stupefacenti. L’emergenza sanitaria era data dalla problematicità di gestione di pazienti già affetti da disturbo da uso di alcol (DUA) e sostanze (DUS), aumento del consumo di alcolici e sostanze nella popolazione generale con relativi danni psico-fisici, fragilità dei pazienti DUA e DUS in caso di malattia da Covid-19. Il campione dell’indagine è costituito da 135 soggetti, utenti del Ser.D. Roma Distretto 9, che hanno compilato un questionario self-report.
A cura di Raimondo Maria Pavarin … [et al.], Dopo il Covid. Rapporto 2022 su consumi problematici e dipendenze nell’area metropolitana di Bologna, AUSL di Bologna, Bologna, 2022, 52 pp.
Il documento presenta un quadro epidemiologico del consumo di sostanze, alcol e gioco problematico nell’area metropolitana di Bologna per l’anno 2021. Descrive le caratteristiche delle persone con problemi dovuti a questi comportamenti e le attività dei servizi che se ne occupano. Ad esempio, nel corso del 2021, complessivamente diminuiscono i consumatori problematici (CP) di sostanze, ma aumentano i CP di cocaina, i poli assuntori di cocaina+alcol e di cannabis+alcol. Tra le persone che si rivolgono ai servizi, aumenta il numero di donne e di non nativi, diminuisce l’età media e aumenta il numero di persone senza fissa dimora.
Claudia Gandin … [et al.], Il monitoraggio dell’alcoldipendenza e dei disturbi da uso di alcol in Italia, in Alcologia, n. 49 (2022) – on line, pp. 36-45
L’articolo riassume le problematiche principali emerse dalle elaborazioni del SIStema di Monitoraggio Alcolcorrelato – SISMA a cura dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute sui dati trasmessi dai servizi di alcologia per quanto concerne l’alcoldipendenza, anche in funzione dei nuovi scenari epidemiologici ridisegnati dall’emergenza COVID-19. Ne emerge il peggioramento della capacità d’intercettazione da parte dei servizi del SSN e del sistema di diagnosi e cura. Secondo gli autori, è urgente avviare programmi sistematici per l’identificazione precoce e l’intervento breve nella popolazione generale e attuare la formazione specifica dei professionisti sanitari, garantendo il principio di equità a supporto delle persone e delle famiglie che combattono con la dipendenza da alcol.
 Yuanwei Xu … [et al.], The socioeconomic gradient of alcohol use: an analysis of nationally representative survey data from 55 low-income and middle-income countries, in The Lancet Glob Health, vol. 10, n. 9 (set. 2022) – on line, pp. 1-13
Yuanwei Xu … [et al.], The socioeconomic gradient of alcohol use: an analysis of nationally representative survey data from 55 low-income and middle-income countries, in The Lancet Glob Health, vol. 10, n. 9 (set. 2022) – on line, pp. 1-13
L’alcol è uno dei principali fattori di rischio per oltre 200 patologie e contribuisce significativamente alle disuguaglianze socioeconomiche in materia di salute. Tuttavia, poco si sa sulle associazioni tra le condizioni socioeconomiche degli individui e il consumo di alcol, specialmente il consumo episodico pesante (HED; ≥5 drink in un’occasione) nei Paesi a basso o medio reddito. I ricercatori hanno indagato l’associazione tra lo status socioeconomico a livello individuale e familiare e le abitudini di consumo di alcol in questi contesti. I modelli di regressione logistica che controllano l’età, il Paese e l’anno dell’indagine, stratificati per sesso e gruppi di reddito del Paese, sono stati utilizzati per studiare le associazioni tra due indicatori di status socioeconomico (livello di istruzione individuale e ricchezza familiare) e il consumo di alcol (consumo attuale di alcol e HED tra i bevitori attuali). Nell’articolo sono riportati e commentati i risultati dell’indagine.
GBD 2020 Alcohol Collaborators, Population-level risks of alcohol consumption by amount, geography, age, sex, and year: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2020, in The Lancet, vol. 400, n. 10347 (lug. 2022) – on line, pp. 185–235
I rischi per la salute associati al consumo moderato di alcol sono oggetto di dibattito. Questo studio ha comportato una revisione sistematica della letteratura scientifica sull’argomento. Ne emerge che il rischio per la salute dipende dal tasso di malattie preesistenti, che a loro volta variano nelle diverse popolazioni considerate, nelle diverse regioni ed età. Per esempio, il rischio aumenta per le popolazioni più giovani, mentre non appare legato al genere. Sono necessari interventi per ridurre il rischio per la salute associato al consumo di alcol, soprattutto verso i più giovani
Lluís Mangot-Sala … [et al.], The impact of the COVID lockdown on alcohol consumption in the Netherlands. The role of living arrangements and social isolation, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 233, art. 109349 (apr. 2022) – on line, pp. 1-8
Nel presente articolo viene analizzato l’impatto della pandemia da COVID-19 e il conseguente lockdown sulla salute e sui comportamenti degli individui, in particolare per quanto riguarda il consumo di alcol. La rivista riporta molti altri studi simili effettuati: nei Paesi Bassi: Inna Levy, Keren Cohen-Louck, Hagit Bonny-Noach, Gender, employment, and continuous pandemic as predictors of alcohol and drug consumption during the COVID-19, vol. 228, art. 109029 (nov. 2021) – on line, pp. 1-8; in Francia: Laurent Karila … [et al.], Effects of the 2020 health crisis on acute alcohol intoxication: A nationwide retrospective observational study, (vol. 228, art. 109062 (nov. 2021) – on line, pp. 1-10; negli U.S.A.: Judith J. Prochaska … [et al.], A randomized controlled trial of a therapeutic relational agent for reducing substance misuse during the COVID-19 pandemic, vol. 227, art. 108986 (ott. 2021) – on line, pp. 1-10 e Courtney D. Nordeck … [et al.], Changes in drinking days among United States adults during the COVID-19 pandemic, in Addiction, vol. 117, n. 2 (feb. 2022) – on line, pp. 331-340; in Canada: Rose A. Schmidt … [et al.], Early impact of COVID-19 on the incidence, prevalence, and severity of alcohol use and other drugs: A systematic review, vol. 228, art. 109065 (nov. 2021) – on line, pp. 1-17 e nel Regno Unito: Amanda Roberts … [et al.], Alcohol and other substance use during the COVID-19 pandemic: A systematic review, vol. 229, art. 109150, Part. A (dic. 2021) – on line, pp. 1-35 Patricia Irizar … [et al.], Longitudinal associations with alcohol consumption during the first COVID-19 lockdown. Associations with mood, drinking motives, context of drinking, and mental health, vol. 226, art.108913 (set. 2021) – on line, pp. 1-10, e Claire Garnett …[et al.], Factors associated with drinking behaviour during COVID-19 social distancing and lockdown among adults in the UK , vol. 219, art. 108461 (feb. 2021) – on line, pp. 1-9.
A cura di Federica Vigna-Taglianti, Luca Acierno, L’utenza piemontese dei Servizi per le Dipendenze Patologiche durante la pandemia da Covid-19. Report sull’utenza dei servizi pubblici per le dipendenze patologiche in Piemonte nel 2020 e 2021 rispetto al 2019: analisi dei dati di sorveglianza epidemiologica dell’OED Piemonte e sintesi dei dati nazionali e internazionali, OED, Grugliasco, 2022, 33 pp.
Gli obiettivi principali del report proposto sono: 1) Fornire una panoramica di sintesi dei dati internazionali e nazionali sull’uso di sostanze e sull’assistenza sanitaria fornita ai soggetti dipendenti da sostanze e comportamenti durante la pandemia da SARS CoV-2; 2) Sintetizzare i dati relativi all’assistenza dei soggetti dipendenti da sostanze e comportamenti sul territorio nazionale nel 2020 e 2021, e confrontarli con quelli del 2019, con particolare attenzione per la regione Lazio e l’AUSL Toscana Centro per le quali è reperibile reportistica specifica; 3) Analizzare i dati relativi all’assistenza dei soggetti dipendenti da sostanze e comportamenti in Piemonte nel 2020 e 2021, confrontarli con quelli del 2019 e fornire possibili interpretazioni e raccomandazioni.
 Emanuele Scafato… [et al.], Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell’Osservatorio Nazionale Alcol sull’impatto del consumo di alcol ai fini dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute. Rapporto 2022, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 2022, 81 pp.
Emanuele Scafato… [et al.], Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell’Osservatorio Nazionale Alcol sull’impatto del consumo di alcol ai fini dell’implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute. Rapporto 2022, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 2022, 81 pp.
Il consumo di alcol è un importante problema di salute pubblica, classificato in Europa come terzo fattore di rischio di malattia e morte prematura dopo il fumo e l’ipertensione arteriosa. L’Osservatorio Nazionale Alcol (ONA) elabora e analizza ogni anno le basi di dati nazionali svolgendo attività di monitoraggio su mandato del Ministero della Salute e in base a quanto previsto dal Piano Statistico Nazionale e alle attività del “SIStema di Monitoraggio Alcol-correlato – SISMA” previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017 e dalla recente attivazione in ISS dell’azione centrale SIAS-SISTIMAL “International SIstema e Azione di Supporto a SISTIMAL” per la valutazione dell’implementazione delle politiche nazionale e regionali sull’alcol che il Ministero della Salute provvede a trasmettere alla World Health Organization (WHO). L’ONA è l’organismo indipendente di raccordo tra Ministeri, Presidenza del Consiglio, Commissione Europea e WHO per le attività tecnico-scientifiche di rilievo nazionale, europeo e internazionale. Il presente rapporto si riferisce al 2020, anno della pandemia da COVID-19 e illustra la problematica alcol in funzione dei nuovi scenari epidemiologici ridisegnati dall’emergenza COVID-19. A proposito di questo monitoraggio si consulti anche gli articoli di Silvia Ghirini … [et al.], L’aumento dei consumatori a rischio durante la pandemia e di Claudia Gandin … [et al.], Il monitoraggio dell’alcoldipendenza e dei disturbi da uso di alcol in Italia, in Alcologia, n. 49 (2022), pp. 17-25 e 36-45.
Alberto Arnaudo, Seconda conferenza nazionale alcol. Prime considerazioni tra il dire e il fare, in Dal fare al dire, vol. 31, a. 31, n. 1 (2022), pp. 5-7
La seconda conferenza nazionale sull’alcol si è aperta a Roma, dopo 14 anni dall’ultima, con statistiche che attestano un consumo significativo di alcol fuori dai pasti tra i giovani, come ha detto in apertura il ministro della Salute Speranza. Viene anche messa in rilievo la necessità di aggiornare la legislazione italiana allineandola con gli obiettivi dell’Oms. Altri temi discussi sono stati, tra gli altri: la scarsa percentuale di alcoldipendenti che si rivolgono ai servizi e l’organizzazione degli stessi, un approccio vecchio, superato e stigmatizzante al problema da parte delle politiche, la prevenzione nelle scuole e sul tema alcol e guida, la formazione degli operatori, la collaborazione tra servizi sanitari diversi, anche per quanto riguarda i trapianti di fegato. A tal proposito si consulti anche l’articolo di Valentino Patussi … [et al.], Documento della Società Italiana di Alcologia: analisi delle principali tematiche affrontate nella Seconda conferenza nazionale alcol, in Alcologia, n. 49 (2022), pp. 157-183.
Observatoire francais des drogues et des tendances addictives, Drugs and Addictions Key Data, OFDT, Parigi, 2022, 8 pp.
La pubblicazione riporta, periodicamente, gli indicatori statistici più recenti per quantificare e descrivere il fenomeno del consumo di sostanze psicoattive (droghe e farmaci) e delle dipendenze in Francia. Il documento si basa sul lavoro dell’Osservatorio francese delle droghe e delle dipendenze e altre organizzazioni che raccolgono dati sul fenomeno.
Collocazione Biblioteca: A1102
European Observatory on Health Systems and Policies, Organisation for Economic Co-operation and Development, Companion report 2021, State of Health in the EUl, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, 67 pp.
Questo rapporto traccia, a partire da un profilo sullo stato di salute di ciascun Paese europeo, cinque punti chiave riguardo alla resilienza dei sistemi sanitari europei di fronte alla Pandemia di covid-19: 1. Comprendere gli impatti di vasta portata della pandemia da COVID-19 sulla salute ; 2. I vantaggi dell’innovazione digitale nell’erogazione dell’assistenza sanitaria e salute pubblica; 3. Ripensare le strategie del personale sanitario e la pianificazione dopo la Pandemia; 4. Osservazioni conclusive. Verso la costruzione di sistemi sanitari più resilienti. La relazione accompagna i report tracciati per ogni paese europeo. La relazione sull’Italia si trova anche in italiano.
A cura di Mauro Ceccanti, Gemma Battagliese, Giuseppe, La pandemia invisibile. Riflessioni su alcol e salute in Italia e nel Lazio, A.L.E., Roma, [2021?], 155 pp.
Attraverso una serie di analisi e discussioni gli autori riassumono le varie problematiche legate all’uso eccessivo di alcol. Il fine è quello di dare delle indicazioni generali sui problemi che l’alcol può generare, evidenziando e utilizzando i dati disponibili. I contenuti del libro dimostrano in maniera inequivocabile come i problemi sanitari ed economici legati all’uso inadeguato di alcol riguardano non solo la singola persona, non solo medici e pazienti, ma l’intera società a livello globale.
Collocazione Biblioteca: 19795
 Gianni Testino … [et al.], Alcohol use disorder in the COVID-19 era: Position paper of the Italian Society on Alcohol (SIA), in Addiction Biology, art. e13090 (2021) – on line, pp. 1-10
Gianni Testino … [et al.], Alcohol use disorder in the COVID-19 era: Position paper of the Italian Society on Alcohol (SIA), in Addiction Biology, art. e13090 (2021) – on line, pp. 1-10
Alcuni dati suggeriscono che il periodo di isolamento durante la pandemia di Covid-19 possa aver portato a un impennata nell’abuso di alcol e, nel caso di pazienti con disturbo da abuso di alcol, l’isolamento sociale può favorire errori e ricadute. Scopo di questo articolo è fornire agli specialisti nel campo della dipendenza da alcol degli strumenti per meglio gestire i pazienti con disturbo da abuso di alcol e Covid-19.
Paolo Jarre … [et al.], COVID-19 e dipendenze – 2, in MDD : Medicina delle Dipendenze, a. 10, n. 40 (set. 2020), pp. 4-52
Questa seconda monografia della rivista sugli effetti del COVID-19 nell’ambito delle dipendenze (la prima si trova sul n. precedente della rivista, pp. 4-56) si apre con una revisione sistematica delle evidenze disponibili tra COVID e dipendenze, che ben rappresenta in modo analitico tutte le possibili rotte di incrocio tra pandemia e dipendenza. Seguono due contributi relativi a USA e UK dove l’impatto della pandemia ha messo in luce la farraginosità e l’arretratezza dei sistemi normativi e dei dispositivi per la riduzione del danno dei consumi per via inalatoria e relativi alla dispensazione di farmaci oppio antagonisti. Altri contributi ritornano sul lavoro di prevenzione dell’uso problematico del web, sui consumi di alcol durante il lockdown e sugli effetti sui consumi addittivi determinati dalle restrizioni alla mobilità. Viene infine illustrato il razionale e il disegno di ricerca su un sorprendente potenziale effetto protettivo dell’infezione COVID del disulfiram e l’impatto del COVID sui pazienti HIV e sui servizi loro dedicati nell’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino.
Alfio Lucchini, Felice Nava, Newsletter “Clinica dell’Alcolismo”. I Servizi di Alcologia. Le caratteristiche, gli operatori, i pazienti e i trattamenti in Italia, in Mission, a. 14, n. 54 (nov. 2020), pp. 29-42
La malattia alcolica rappresenta una delle patologie più impattanti sui sistemi sanitari per le sue conseguenze sulla salute e sulla società. I Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) sono i presidi del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) che hanno il compito istituzionale e le capacità professionali per accogliere e curare in maniera appropriata gli alcolisti. Tuttavia si conoscono poco le pricipali modalità di organizzazione clinica, trattamento e valutazione dei soggetti alcolisti che sono presi in carico dai Ser.D. Sussistono, inoltre, problemi connessi al trattamento dell’alcolismo, fra cui l’accesso alle cure, le modalità di valutazione e di trattamento, l’integrazione dei programmi terapeutici e riabilitativi. Per questa ragione FeDerSerD e il Centro studi e ricerche CeRCo hanno sottoposto 20 domande ai clinici dei Ser.D. e Servizi Alcologici italiani, per capire come attualmente gli alcolisti vengono presi in carico territorialmente, quali sono le caratteristiche dei servizi, degli operatori e dei pazienti che sono in trattamento e quali sono gli approcci terapeutici maggiormente utilizzati. In questo numero della Newsletter “Clinica dell’Alcolismo” sono riportati i dati dell’indagine. A tal proposito si veda anche l’articolo di Paolo Ugolini … [et al.], Dipendenze patologiche a 30 anni dalla 309/90. Vol. 2 Best Practices e innovazioni, in Sestante, n. 09/2 (giu.2020) – on line, pp. 1-84
Gianni Testino … [et al.], Speciale Covid-19, in Alcologia, n. 40 (2020) – online, pp. 5-45
Il lockdown imposto dai decreti ministeriali a causa del Covid-19, se pur necessario, ha indotto nella popolazione generale effetti collaterali psicologici anche gravi. I pazienti affetti da disturbo da uso di alcol (DUA) e/o sostanze (DUS) e pazienti psichiatrici hanno subito negativamente gli effetti collaterali di questa emergenza anche a breve termine. Questo numero monografico affronta gli effetti della pandemia sulle persone con DUA e le misure necessarie per affrontarlo. Gli articoli sono i seguenti: “Disturbi da uso di alcol e pandemia da Sars-COV2″ di Gianni Testino; “Alcol e Coronavirus Disease-19: la prevenzione che manca. Necessità e urgenza di rinnovamento organizzativo e funzionale della rete di cura del Sistema Sanitario Nazionale” di Emanuele Scafato [et al.]; “Management dei disturbi da uso di alcool in era covid-19: raccomandazioni della Società Italiana di Alcologia” di Gianni Testino e altri. Chiude la rivista una serie di Infografiche: Alcoholand and Covid -19: What you need to know.
Comportamenti e problemi alcol-correlati
Paola Giraudo, Livia Racca, Cristina O. Mosso, Gli effetti dell’alcol su strada. Un’indagine esplorativa tra i millennials, in Dal fare al dire, a. 32, numero speciale (2023), pp. 37-43
522 iscritti a un corso di guida hanno partecipato a un’indagine in cui si esploravano credenze e opinioni sul consumo di alcolici e relative conseguenze sulla guida. I risultati hanno mostrato che, tra i rispondenti al questionario, i più giovani (minori di 21 anni) sono più consapevoli delle conseguenze e dei rischi dell’abuso di alcol per la guida. Avvertono inoltre la necessità di un approfondimento sul tema, riconoscendo l’importanza di assumere stili di vita più sani attraverso una comunicazione efficace.
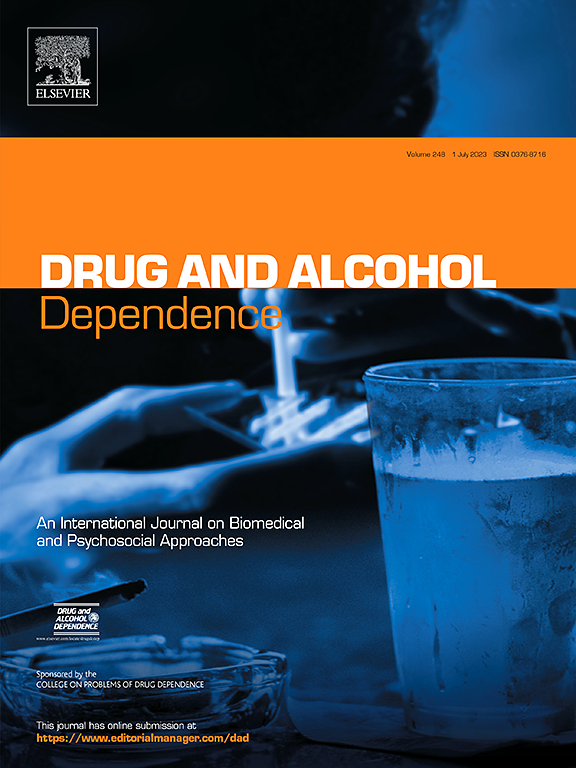 Heta Moustgaard … [et al.], The contribution of alcohol-related deaths to the life-expectancy gap between people with and without depression – a cross-country comparison, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 238, (set. 2022) – on line, pp. 1-8
Heta Moustgaard … [et al.], The contribution of alcohol-related deaths to the life-expectancy gap between people with and without depression – a cross-country comparison, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 238, (set. 2022) – on line, pp. 1-8
I decessi legati all’alcol possono essere tra le ragioni più importanti della minore aspettativa di vita delle persone affette da depressione, ma nessuno studio ha quantificato il loro contributo. Nel presente studio i ricercatori hanno quantificato il contributo dei decessi legati all’alcol al divario di aspettativa di vita nella depressione in quattro Paesi europei con diversi livelli di mortalità legata all’alcol. Sono stati utilizzati dati di coorte che collegano i registri di popolazione con le cartelle cliniche e di morte di Danimarca, Finlandia, Svezia e Torino, Italia, nel periodo 1993-2007. Sono stati identificati i pazienti psichiatrici ricoverati con depressione dai registri delle dimissioni ospedaliere in Danimarca, Finlandia e Svezia e i pazienti ambulatoriali con prescrizioni di antidepressivi dai registri delle prescrizioni in Finlandia e a Torino. Nell’articolo sono riportati e commentati i risultati dell’indagine.
Michael P. Cameron, The relationship between alcohol outlets and crime is not an artefact of retail geography, in Addiction, vol. 117, n. 8 (ago. 2022) – on line, pp. 2215-2224
Nelle ricerche precedenti, la distribuzione spaziale degli outlet di alcolici ha dimostrato di essere collegata alla distribuzione spaziale del crimine. Tuttavia, la distribuzione spaziale degli outlet di alcolici è anche collegata alla distribuzione spaziale di altre attività al dettaglio (e non al dettaglio). Questo studio ha misurato se una relazione residuale fra gli outlet di alcolici e il crimine rimane statisticamente significativa dopo aver considerato la densità del commercio al dettaglio. Si è effettivamente trovato che esiste una relazione positiva fra la distribuzione spaziale degli outlet di alcolici e la distribuzione spaziale del crimine che sembra persistere, anche dopo avere considerato la densità di esercizi al dettaglio non per alcolici. La relazione fra gli outlet degli alcolici e il crimine non è semplicemente un artefatto della geografia del commercio al dettaglio.
Chengyi Ding, Dara O’Neill, Annie Britton, Trajectories of alcohol consumption in relation to all-cause mortality in patients with cardiovascular disease. A 35-year prospective cohort study, in Addiction, vol. 117, n. 7 (lug. 2022) – on line, pp. 1920-1930
La ricerca relativa alla prognosi di consumo di alcol e malattia cardio vascolare (cardiovascular disease = CVD) dei pazienti ha ampiamente ignorato la dinamica longitudinale nel comportamento del consumo alcolico. Questo studio prospettico di coorte ha misurato l’associazione fra le traiettorie del consumo alcolico e il rischio di mortalità in un totale di 1306 partecipanti con episodi cardiovascolari non fatali (malattia coronarica/ictus, CVD)CVD del Regno Unito. Dalla ricerca emerge che pazienti con malattie cardiovascolari che bevono costantemente ≤ 14 unità la settimana sembrano avere un rischio di mortalità simile agli astinenti di lungo periodo, il che non va a sostegno dell’effetto protettivo del consumo moderato sulla mortalità totale. I pazienti con malattie cardiovascolari che smettono di bere sembra abbiano un maggiore rischio di mortalità rispetto ai bevitori moderati continui, ma questo può essere collegato a una scarsa autovalutazione della propria salute prima dell’insorgenza della malattia cardiovascolare.
Julie Brummer … [et al.], Hazardous drinking and violence-related hospitalizations in the Danish general population: A historical cohort study, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 233, art. 109338 (apr. 2022) – on line, pp. 1-9
È ben documentato da studi caso-controllo e caso-crossover che il bere pericoloso e il rischio di subire lesioni legate alla violenza sono correlati. Il presente studio ha analizzato questa relazione in una coorte di intervistati di una ricerca sulla popolazione generale in Danimarca, utilizzando i successivi ricoveri ospedalieri per violenza. La coorte era costituita dai partecipanti alla ricerca nazionale danese del 2011 su alcol e droghe (N = 5126). Le risposte sono state utilizzate per identificare i soggetti con un consumo pericoloso di alcol. I dati del registro sui ricoveri ospedalieri della coorte per violenza dal 2010 al 2018 sono serviti come esito. La relazione tra il consumo pericoloso di alcol degli intervistati e il numero di ricoveri ospedalieri successivi è stata analizzata utilizzando un modello di regressione di Poisson. Nell’articolo sono riportati e commentati i risultati della ricerca.
Gianni Testino, Patrizia Balbinot, Rapporto consumo di alcol e cancro: la posizione della Società Italiana di Alcologia (SIA), in Alcologia, n. 48 (2022) – on line, pp. 8-15
L’articolo prende spunto dalla votazione all’Europarlamento che ha approvato gli emendamenti al piano di lotta contro il cancro presentato dalla Commissione speciale sulla lotta contro il cancro (Special Committee on Beating Cancer, Beca). Il documento così approvato sostiene come sicuro per la salute un consumo moderato di alcol. L’articolo elenca i dati scientifici che contrastano con tali affermazioni, ritenendole scientificamente scorrette e dannose. La posizione della Società è che non esista una soglia di sicurezza per il consumo di alcol. Si consulti inoltre la ricerca di Roberta Agabio … [et al.], Alcol e tumore alla mammella, n. 48 (2022) – on line, pp. 60-70
Sandra Siria … [et al.], Treatment effectiveness for male intimate partner violence perpetrators depending on problematic alcohol use, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 232, art. 109301 (mar. 2022) – on line, pp. 1-6
L’uso problematico di alcol (PAU) è altamente correlato alla perpetrazione di violenza da parte del partner nelle relazioni di intimità (IPV). Tuttavia, quando vengono valutati i trattamenti per gli autori di IPV di sesso maschile che riguardano il consumo di alcol, i risultati sono diversi. Pertanto, l’obiettivo principale di questo studio è quello di valutare l’efficacia differenziale a lungo termine di un programma di trattamento individuale standard per gli autori di IPV di sesso maschile a seconda della presenza di PAU. Il campione esaminato è composto da 641 autori di IPV maschi che hanno completato un programma di trattamento individuale per autori di violenza di genere. Tutti i partecipanti sono stati seguiti per un anno dopo il completamento del trattamento. Nell’articolo sono riportati e commentati i risultati dell’indagine.
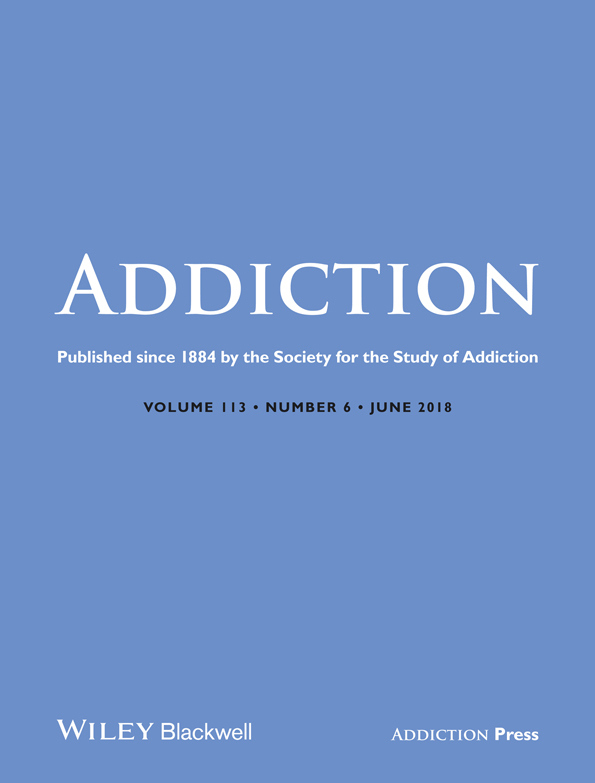 Mareike Augsburger … [et al.], Effects of a minimal-guided on-line intervention for alcohol misuse in Estonia. A randomized controlled trial, in Addiction, vol. 117, n. 1 (gen. 2022) – on line, pp. 108-117
Mareike Augsburger … [et al.], Effects of a minimal-guided on-line intervention for alcohol misuse in Estonia. A randomized controlled trial, in Addiction, vol. 117, n. 1 (gen. 2022) – on line, pp. 108-117
L’Estonia ha uno dei più alti tassi di mortalità attribuibili all’alcol all’interno dell’Unione Europea. Lo scopo di questo studio era di stimare l’efficacia di un intervento di auto-aiuto online nell’ambito di una campagna di prevenzione a livello nazionale per ridurre il problema del consumo di alcol nella popolazione. L’intervento consisteva in 10 moduli basati sui principi della terapia cognitivo-comportamentale e del colloquio motivazionale. Il gruppo di controllo attivo ha ricevuto l’accesso a un sito Web con un autotest che includeva feedback normativo personalizzato e informazioni per il trattamento standard dell’alcol. La ricerca ha rilevato che un intervento di auto-aiuto online con una guida minima è stato efficace nel ridurre il problema del consumo di alcol in Estonia.
Silvia Clementi, Marzia Tosi, La giustizia riparativa nel lavoro di gruppo: analisi di un progetto con gli imputati in messa alla prova all’Uepe di Mantova, in Studi sulla questione criminale, a. 16, n. 1 (2021), pp. 49-82
L’articolo presenta i risultati della valutazione di un progetto di responsabilizzazione e giustizia riparativa rivolto a persone in messa alla prova, imputate in un procedimento penale per guida sotto l’effetto di alcool o sostanze. Caratteristiche del progetto sono l’approccio relazionale al lavoro sociale, il coinvolgimento di diversi attori del territorio, l’adozione di un modello di giustizia di comunità. I dati qualitativi e quantitativi raccolti mostrano gli aspetti positivi del progetto, secondo gli autori meritevole di continuazione.
Fabio Caputo … [et al.], Identification of harmful drinking in subjects who have had their driving license suspended due to alcohol use: a retrospective Italian study, in European Review for Medical and Pharmacological Sciences, n. 24 (2020) – on line, pp. 10720-10728
L’identificazione precoce del consumo dannoso di alcol è difficile. Scopo dello studio è indagarne la presenza in un gruppo di persone che hanno avuto la sospensione della patente a causa del consumo di alcol. L’indagine è stata condotta attraverso un questionario somministrato a 979 persone, che ha permesso alcune diagnosi di consumo dannoso o di disturbo da consumo di alcol. Queste persone sono poi state inserite in un programma di controllo del consumo di alcol, da cui hanno tratto beneficio. Secondo gli autori, la stretta sorveglianza dei soggetti trovati alla guida sotto l’influenza dell’alcol, con il coinvolgimento di figure professionali diverse (dalle forze dell’ordine agli specialisti nel trattamento dell’alcolismo) può aiutare a identificare e trattare queste persone.
Annie Britton… [et al.], Sustained heavy drinking over 25 years is associated with increased N-terminal-pro-B-type natriuretic peptides in early old age. Population-based cohort study, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 212, art.108048 (lug. 2020) – on line, pp. 1-4
Il consumo pesante di alcol è associato a un aumento del rischio di insufficienza cardiaca. Si è cercato di indagare se i livelli di NT-proBNP (un biomarcatore dell’insufficienza cardiaca) differiscono in base ai profili di consumo alcolico, sia riguardo al consumo attuale che all’esposizione cumulativa al bere in un campione di popolazione generale. I dati dei 2054 partecipanti (49% maschi) sono stati ricavati dal UK Medical Research Council NationalSurvey for Health and Development, uno studio longitudinale di coorte basato su un campione rappresentativo nazionale di nascite del 1946. Categorie di consumo alcolico a lungo termine sono state create sulla base del consumo in 25 anni di osservazioni e sono state confrontate con i livelli di NT-proBNP misurati all’età media di 63 anni. I risultati indicano che si potrebbero sottoporre i forti bevitori a screening per i livelli di NT-proBNP per individuare quelli ad alto rischio nelle fasi cliniche iniziali dell’insufficienza cardiaca e indirizzare a loro strategie di riduzione del rischio.
Abuso, dipendenza, trattamento
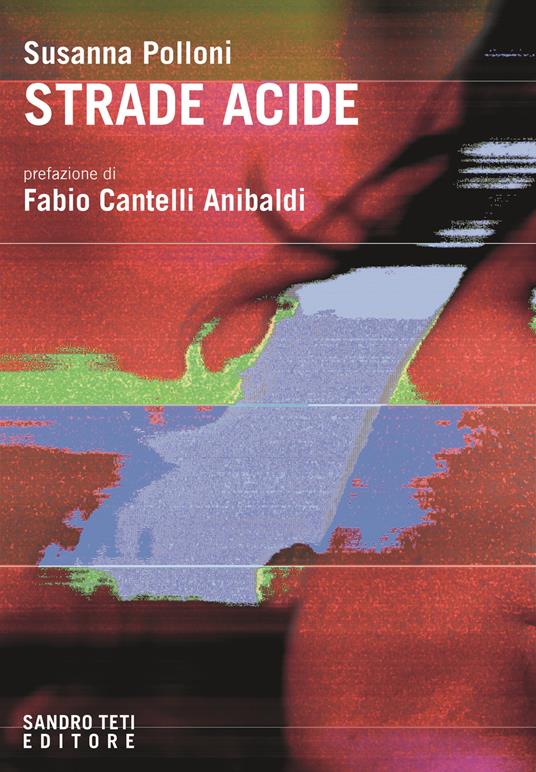 Susanna Polloni, Strade acide, Sandro Teti, Roma, 2023, 163 pp.
Susanna Polloni, Strade acide, Sandro Teti, Roma, 2023, 163 pp.
Il testo è l’autobiografia dell’autrice, archivista e medievalista, che dopo aver vissuto un’adolescenza burrascosa, caratterizzata da abuso di alcol e droghe, ha diretto per molti anni un’associazione culturale internazionale che si occupa di filosofia comparata. Nel luglio 1984, a Madrid, Susanna, che vive per strada ormai da molti mesi, viene sconvolta da un ‘bad trip’ da Lsd. Un’esperienza spaventosa, uno spartiacque che segnerà un prima e un dopo nella sua vita, trasformandola in una continua ricerca di sé stessa. Il libro affronta il disagio rifuggendo il luogo comune dell’“esperienza alterata” come degenerazione patologica di soggetti privi di volontà. Nelle pagine di questo moderno romanzo di formazione lo stato mentale modificato e la percezione dilatata sono considerati dall’autrice bisogni insopprimibili della psiche umana. Nel viaggio attraverso sé stessi, l’oppio è una tappa del percorso, così come lo sono l’amore e l’arte. Prefazione di Fabio Cantelli Anibaldi, già vicepresidente del Gruppo Abele.
Collocazione Biblioteca: 20116
Paola Damiano, Disturbo da uso di alcol (DUA). Il trattamento farmacologico oggi: le criticità e le nuove sfide, in Dal fare al dire, n. 1 (2023), pp. 29-38
Il consumo di alcol è un importante problema di salute pubblica, che causa circa 3 milioni di morti ogni anno a livello globale, nonché disabilità e cattive condizioni di salute di milioni di persone. Nel trattamento del DUA la prima fase è rappresentata dalla disintossicazione, ma successivamente la maggior parte dei pazienti presenta ricadute alcoliche, per cui il miglioramento dei risultati può essere raggiunto combinando interventi psicosociali e farmacologici. La farmacoterapia è generalmente raccomandata per mantenere l’astinenza alcolica.
Elisa Zamagni … [et al.], Da doppie diagnosi a doppi servizi? Riflessioni per un’ibridazione tra servizi di salute mentale e dipendenze patologiche, in Dal fare al dire, a. 32, numero speciale (2023), pp. 25-36
Gli autori affermano che la presenza di due setting autonomi di diagnosi e di trattamento nella presa in carico di pazienti che presentano sintomi di natura psichiatrica e problematiche legate all’uso, abuso e dipendenza da sostanze è uno dei nodi critici, che richiede una riorganizzazione dei servizi. Per approfondire è stata svolta un’indagine sui dati raccolti nel 2020 dal sistema informativo del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Rimini per analizzare i ricoveri che hanno necessitato di ospedalizzazione dopo consulto psichiatrico, con attenzione all’uso di sostanze rilevato negli esami urinari.
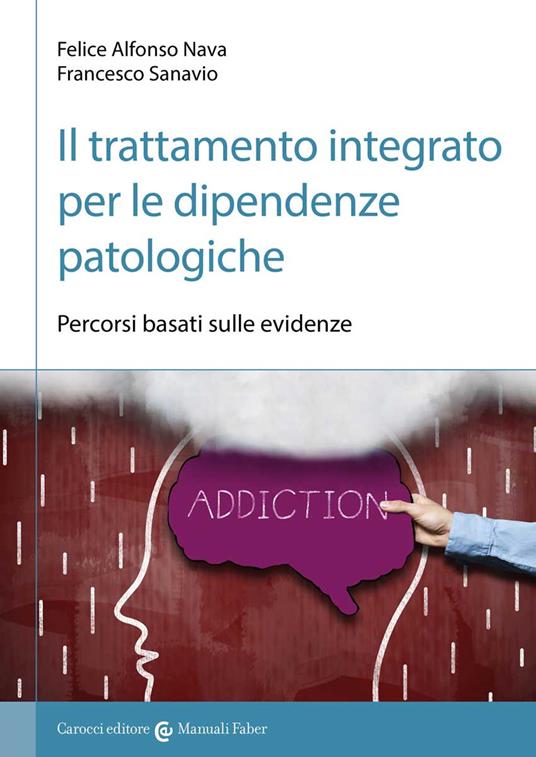 Felice Alfonso Nava, Francesco Sanavio, Il trattamento integrato per le dipendenze patologiche. Percorsi basati sulle evidenze, Carocci, Roma 2022, 177 pp.
Felice Alfonso Nava, Francesco Sanavio, Il trattamento integrato per le dipendenze patologiche. Percorsi basati sulle evidenze, Carocci, Roma 2022, 177 pp.
Il volume presenta le più aggiornate basi neurobiologiche delle dipendenze patologiche, degli interventi psicoterapeutici e delle cure farmacologiche. I moderni orientamenti diagnostico-terapeutici fondati sulle evidenze scientifiche sono descritti seguendo la storia dell’evoluzione del trattamento cognitivo e comportamentale a partire dalla comprensione delle tecniche di base (di prima e seconda generazione) per arrivare agli attuali approcci processuali (di terza generazione). Tra le terapie di terza generazione troviamo anche l’utilizzo della metacognizione e della Mindfulness e la Schema Therapy. Ampie esemplificazioni operative permettono di tradurre in maniera efficace i contenuti teorici nella pratica clinica. Il testo propone un punto di vista unitario sulla presa in carico della persona con dipendenza patologica offrendo una metodologia efficace e flessibile per le fasi di valutazione, diagnosi e scelta del percorso terapeutico. Infine, sono compendiate le più autorevoli linee guida internazionali sul trattamento dei consumatori di sostanze e con dipendenza comportamentale.
Collocazione Biblioteca: 20107
Paul Welford … [et al.], Effects of physical activity on symptoms of depression and anxiety in adults with alcohol use disorder (FitForChange): Secondary outcomes of a randomised controlled trial, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 239, (ott. 2022) – on line, pp. 1-9
L’obiettivo dello studio proposto è quello di analizzare gli effetti dello yoga, dell’esercizio aerobico e delle cure abituali sui sintomi ansiosi e depressivi in adulti con AUD non in cerca di trattamento. E’ stato effettuato, a tal scopo, uno studio controllato parallelo, a tre gruppi, randomizzato in aperto (1:1:1) con valutazione di follow-up in cieco. Tutti i partecipanti avevano una diagnosi clinica di AUD prima della randomizzazione. I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a 12 settimane di esercizio aerobico, yoga o cure abituali (consulenza telefonica). L’esito secondario di interesse è stato la Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), valutata al basale e al follow-up di 12 settimane. Nell’articolo sono riportati e commentati i risultati della ricerca.
Stephanie S. Merkouris … [et al.], Affected other interventions. A systematic review and meta-analysis across addictions, in Addiction, vol. 117, n. 9 (sett. 2022) – on line, pp. 2393 – 2414
Le persone colpite dai problemi di alcol, droghe illecite, gioco d’azzardo, dipendenza da videogiochi, in quanto coinvolte con persone che hanno questi disturbi (terzi interessati) soffrono di danni estesi. Questa è probabilmente la prima rassegna sistematica e meta-analisi a determinare l’efficacia di interventi psicosociali erogati a terzi interessati per tutte le dipendenze. Sono stati esaminati esiti relativi a depressione, soddisfazione nella vita e coping dei terzi coinvolti, gli esiti del trattamento delle persone dipendenti e il funzionamento relazionale (discordia coniugale) tra dipendenti e terzi e si è rilevato che gli interventi possono essere efficaci nel migliorare alcuni, ma non tutti. La conclusione rimane incerta a causa della scarsità di studi e delle limitazioni metodologiche
James R. McKay… [et al.], Efficacy and comparative effectiveness of telephone and smartphone remote continuing care interventions for alcohol use disorder. A randomized controlled trial, in Addiction, vol. 117, n. 5 (mag. 2023) – on line, pp. 1326-1337
La gestione del disturbo da consumo alcolico (alcohol use disorder = AUD) potrebbe essere migliorata da trattamenti efficaci da remoto. Questo studio ha verificato se integrando i programmi ambulatoriali intensivi (intensive outpatient programs = IOPs) con una cura continua erogata attraverso (1) il telefono, (2) lo smartphone, o (3) la loro combinazione migliora i risultati rispetto ai soli programmi ambulatoriali intensivi (4). Sono state anche confrontate le condizioni di cura continua. La ricerca ha evidenziato che un intervento al telefono e un intervento al cellulare, da soli o in combinazione, fornivano una cura continua da remoto efficace per il disturbo da consumo alcolico. La combinazione di entrambi gli interventi non era superiore a nessuno dei due da solo e gli effetti non persistevano dopo il trattamento.
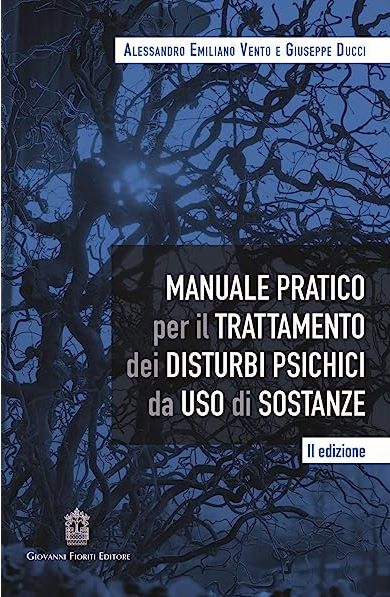 Alessandro Emiliano Vento, Giuseppe Ducci, Manuale pratico per il trattamento dei disturbi psichici da uso di sostanze, 2. ed., Giovanni Fioriti, Roma, 2022, 441 pp.
Alessandro Emiliano Vento, Giuseppe Ducci, Manuale pratico per il trattamento dei disturbi psichici da uso di sostanze, 2. ed., Giovanni Fioriti, Roma, 2022, 441 pp.
Il manuale è rivolto agli operatori dell’area della salute mentale e delle dipendenze e rappresenta uno strumento di aggiornamento utile a tutte le figure che hanno un ruolo in ambito sociosanitario e forense. In questa seconda edizione (la prima ha collocazione 19602) i dati epidemiologici e le più recenti innovazioni in tema di strumenti di trattamento dei disturbi psichici da uso di sostanze e dell’addiction sono stati aggiornati; il capitolo sull’alcool è stato riscritto, aggiungendo una rilevante sezione sulla sindrome feto-alcolica; il capitolo sulle condizioni particolari è stato arricchito di un importante contributo di psichiatria forense.
Collocazione Biblioteca: 19734
Solveig Glestad Christiansen, Inger Synnøve Moan, Employment trajectories among those treated for alcohol use disorder. A register-based cohort study, in Addiction, vol. 117, n. 4 (apr. 2022) – on line, pp. 913-924
L’occupazione durante e a seguito del trattamento per il disturbo da consumo alcolico (alcohol use disorder = AUD) è importante per la salute e il benessere della persona e per ridurre i costi della società. Tuttavia, questo è un argomento poco studiato. Questo studio ha inteso individuare le traiettorie della partecipazione alla forza lavoro nelle persone iscritte al trattamento AUD e descrivere le caratteristiche di coloro che seguono percorsi contrastanti. I risultati della ricerca indicano che i pazienti norvegesi curati per il disturbo da consumo di alcol nel 2009 e 2010 hanno seguito sei traiettorie di occupazione nei 5 anni seguiti all’ingresso al trattamento e hanno avuto una minore partecipazione alla forza lavoro rispetto alla popolazione generale. Tuttavia quasi un quarto ha avuto un alto attaccamento alla forza lavoro per tutto il trattamento, che era positivamente associato all’essere di sesso maschile, avere un livello scolastico superiore e un numero minore di disturbi concomitanti di salute mentale e da consumo di sostanze.
Mauro Cibin … [et al], ICF e Riabilitazione psicosociale: promuovere la Recovery nei Disturbi da Uso di Alcol, in Alcologia, n. 48 (2022) – on line, pp. 71-88
La richiesta riabilitativa nei Disturbi da Uso di Alcol (DUA) è in crescita ed è legata alle caratteristiche della malattia alcolica, alla comorbilità organica e psichiatrica e all’invecchiamento della popolazione in trattamento. L’articolo riguarda l’introduzione della Riabilitazione Psicosociale nei programmi di trattamento, allo scopo di orientarli verso il recupero di una condizione di funzionamento personale e sociale soddisfacente. La riabilitazione psicosociale si occupa non solo consumo di alcol o sostanze, ma anche di salute e stile di vita, delle condizioni abitative, di lavoro e tempo libero, di relazioni e rete sociale e del benessere psicofisico attraverso la riabilitazione al piacere. Per la definizione del percorso riabilitativo è necessario valutare i diversi fattori, personali e ambientali, e il loro cambiamento a seguito degli interventi introdotti. A questo scopo è stato costruito il set di strumenti denominato ICF, descritto nell’articolo.
Victoria Gunillasdotter … [et al.], Effects of exercise in non-treatment seeking adults with alcohol use disorder: A three-armed randomized controlled trial (FitForChange), in Drug and Alcohol Dependence, vol. 232, art. 109266 (mar. 2022) – on line, pp. 1-9
La maggior parte delle persone affette da disturbo da uso di alcol (AUD) non fa richiesta di trattamento. Lo stigma e il desiderio di autogestire il problema sono le probabili spiegazioni. L’esercizio fisico è un’opzione terapeutica emergente, ma mancano studi su individui non in cerca di trattamento. I ricercatori hanno confrontato gli effetti dell’esercizio aerobico, dello yoga e del trattamento come di prassi (supporto telefonico) sul consumo di alcol in adulti con AUD non in cerca di trattamento. L’articolo presenta uno studio parallelo a tre gruppi, in singolo cieco, randomizzato e controllato: 140 adulti fisicamente inattivi di età compresa tra i 18 e i 75 anni con diagnosi di AUD sono stati inclusi in questo studio basato sulla comunità. I partecipanti sono stati randomizzati all’esercizio aerobico (n = 49), allo yoga (n = 46) o al trattamento come di prassi (n = 45) per 12 settimane. L’esito primario dello studio era il consumo settimanale di alcol alla settimana 13 (Timeline Follow-back). Nell’articolo sono riportati e commentati i risultati della ricerca. Uno studio analogo è descritto nell’articolo di Mats Hallgren …[et al.], Effects of acute exercise on craving, mood and anxiety in non-treatment seeking adults with alcohol use disorder, An exploratory study, vol. 220, art.:108506 (mar. 2021), pp. 1-9
 A cura di Ludovica Lugli, Le droghe, in sostanza. Una guida per capire perché ci sono sempre state e ci saranno sempre, e perché la parola vuol dire tante cose diverse, Iperborea ; Il Post, Milano, 2022, 256 pp.
A cura di Ludovica Lugli, Le droghe, in sostanza. Una guida per capire perché ci sono sempre state e ci saranno sempre, e perché la parola vuol dire tante cose diverse, Iperborea ; Il Post, Milano, 2022, 256 pp.
Le sostanze che chiamiamo «droghe» sono tante e diverse, e i loro effetti variano molto a seconda delle dosi, delle caratteristiche di chi le assume e delle ragioni per cui lo fa. Per questo parlare delle droghe come se fossero tutte uguali è riduttivo e fuorviante. Inoltre ignora il fatto che la stessa sostanza che qualcuno usa per provare piacere e divertirsi, può essere utile a qualcun altro per i suoi effetti terapeutici: il confine tra «droghe», per come abitualmente usiamo questo termine, e «farmaci» è meno netto di quanto si pensi. In molte parti del mondo si mette in discussione la cosiddetta «guerra alle droghe» e si tentano nuovi approcci, con depenalizzazioni e legalizzazioni, conservando l’attenzione necessaria sui rischi. Per capire quale direzione prendere bisogna prima di tutto capire di cosa parliamo. Segnaliamo in particolare il capitolo: Dalla A di alcol alla S di spice.
Collocazione Biblioteca: 19403
Victor J. Schneider … [et al.], A virtual reality platform for the measurement of drinking topography, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 231, Art. 109246 (feb. 2022) – on line, pp. 1-8
La valutazione del consumo di alcol durante un incontro di alcol, nota come topografia del bere, può contribuire a migliorare la comprensione dei meccanismi biopsicosociali alla base del consumo di alcol. Tuttavia, in passato gli studi sono stati limitati da processi impegnativi, dispendiosi in termini di tempo e soggetti a errori coinvolti nel raccogliere, organizzare e standardizzare i dati della topografia del bere. Tecnologie recenti che consentono la raccolta integrata dei dati e un maggiore controllo ambientale, come la realtà virtuale (VR), potrebbero risolvere questi problemi. Studi futuri dovrebbero sfruttare il notevole valore traslazionale di questa tecnologia per migliorare la comprensione del rischio associato agli attacchi individuali di alcolismo e sviluppare nuovi interventi per ridurre il consumo pericoloso.
Claudia Gandin … [et al.], La formazione sull’identificazione precoce e l’intervento breve e le attività per la creazione di una rete aziendale per i disturbi da uso di alcol e altre addiction: il progetto collaborativo ISS-OMS per la rete IPIB dell’ASL di Salerno, in Nuova alcologia, n. 46 (2021) – on line, pp. 20-32
Nell’articolo viene descritto il progetto “Rete I.P.I.B. – Rete Aziendale per l’Identificazione Precoce e l’Intervento Breve su alcol, gioco d’azzardo e altre addiction”, promosso dal Dipartimento Dipendenze della ASL Salerno, ed implementato in partnership con l’Osservatorio Nazionale Alcol, Centro Collaborativo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la promozione della salute e la ricerca sull’alcol e le problematiche alcol-correlate dell’Istituto Superiore di Sanità. L’identificazione precoce e l’intervento tempestivo su disturbi da uso di alcol e altre dipendenze rappresenta un’opportunità per comunicare ai consumatori i rischi e identificare con gli stessi stili di consumo compatibili con uno stato di buona salute. A tal proposito si veda anche: Claudia Gandin … [et al.], Identificazione Precoce e Intervento Breve (IPIB) per i disturbi da uso di alcol e da gioco d’azzardo: il progetto di formazione e di attivazione aziendale e istituzionale della rete IPIB della ASL Salerno, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 2021, 91 p.
Roberta Agabio … [et al.], Alcol: nuove e vecchie frontiere, in MDD : Medicina delle Dipendenze, a. 11, n. 42 (giu. 2021), pp. 3-72
L’intero numero della rivista è dedicato all’approfondimento di alcune tematiche di particolare rilevanza per il trattamento del disturbo da uso di alcol (DUA) affrontate da medici italiani attualmente attivi nella ricerca su questi argomenti.
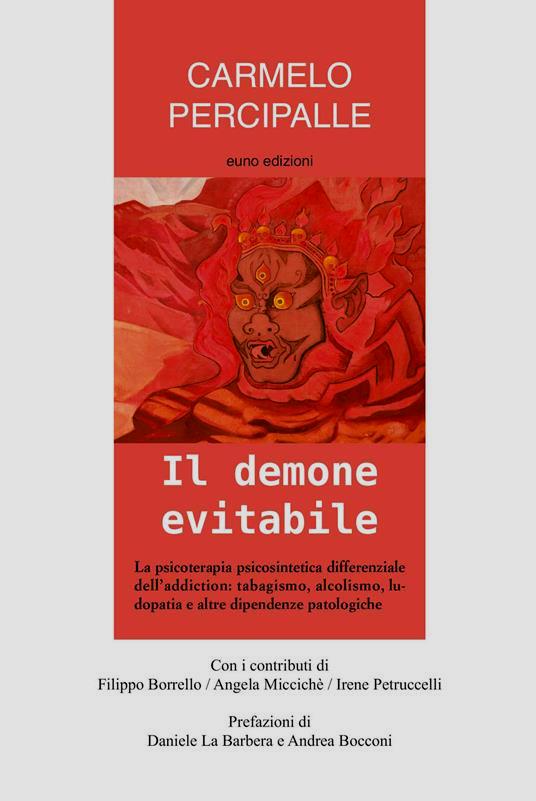 Carmelo Percipalle, Il demone evitabile. La psicoterapia psicosintetica differenziale dell’addiction: tabagismo, alcolismo, ludopatia e altre dipendenze patologiche, Euno, Leonforte (En), 2020, 231 pp.
Carmelo Percipalle, Il demone evitabile. La psicoterapia psicosintetica differenziale dell’addiction: tabagismo, alcolismo, ludopatia e altre dipendenze patologiche, Euno, Leonforte (En), 2020, 231 pp.
L’autore del libro offre un approccio teorico e clinico originale alla complessità del problema delle varie forme di dipendenza, basato su due aspetti centrali: da un lato la descrizione dei tipi psicologici che definiscono differenti motivazioni e modalità di approccio alle esperienze additive, dall’altro l’approfondimento delle sub-personalità correlate alle varie forme di dipendenza. Lo scopo del libro è offrire a terapeuti e operatori delle patologie da dipendenze uno strumento pratico che fa riferimento ai sette tipi umani individuati dalla psicosintesi.
Collocazione Biblioteca: 18953
Giuliano Cuntò, Paolo Peretti, Angelo Pulini, Terapia di gruppo con zoom. Un intervento del centro pre serale “Libera il tempo”, in Dal fare al dire, a. 30, n. 2 (2021), pp. 27 – 35
In questo articolo viene presentato l’intervento di terapia di gruppo on-line, effettuato dagli operatori del centro pre-serale, “Libera il tempo”, attuato dal Dipartimento per le dipendenze Città di Torino in collaborazione con la cooperativa “G. Frassati”. Il progetto, nato nel 2006, è rivolto a dipendenti da alcol, droghe e/o gioco d’azzardo che per la loro patologia hanno compromesso la maggior parte delle relazioni amicali e familiari; ha la finalità di far riflettere i pazienti sulle loro modalità relazionali, apprendendo dall’esperienza emotiva e di offrire loro nuove modalità di contatto e relazione. Durante la pandemia le attività in presenza sono state sospese e la terapia di gruppo si è svolta on line, dimostrando anche nell’emergenza la sua efficacia nell’aiutare a gestire le emozioni. Nel medesimo numero viene descritto anche un servizio di prossimità del Dipartimento per le Dipendenze dell’Asl Città di Torino, collocato nell’Area Bassa Soglia e attivo dal 2009: Simona Borazzo … [et al.], Il servizio PIN ai tempi della pandemia, pp. 15-20.
Dangerous data: drinking after dependance, Drug and alcohol finding, London, 2020, 21 pp.
Incrinata per la prima volta nella Londra degli anni ’60, l’ortodossia secondo cui l’astinenza è l’unico obiettivo terapeutico possibile per gli “alcolisti”, sembrò infranta nel 1973 dall’evidenza che anche i pazienti fisicamente dipendenti potevano imparare a bere con moderazione. La polemica fu feroce, raggiungendo il Congresso degli Stati Uniti, le reti televisive e i tribunali. Questo documento esplora la storia e la ricerca sul controverso problema che deve affrontare ogni alcolista che inizia il trattamento.
Leonardo Dell’Accio, L’alcol e il simbolico secondo l’approccio sistemico-relazionale, in Nuova alcologia, n. 44 (2021) – on line, pp. 65-70
Molte persone utilizzano l’alcol come una sorta di anestetico per mettere a tacere una loro sofferenza interna che spesso ha forti radici nel passato e che si inserisce, secondo la prospettiva sistemica-relazionale, nella propria trama di relazioni familiari. Il Disturbo da Uso di Alcol, dunque, segnala la disfunzionalità del sistema in cui è inserito l’alcolista che, tramite la sostanza, non solo trasmette messaggi ma anche assume e fa assumere ruoli patologici agli altri membri. Pertanto, diventa imprescindibile conoscere a fondo il simbolico e i giochi patologici che caratterizzano una famiglia alcolica per costruire un programma di trattamento adeguato per l’alcolista.
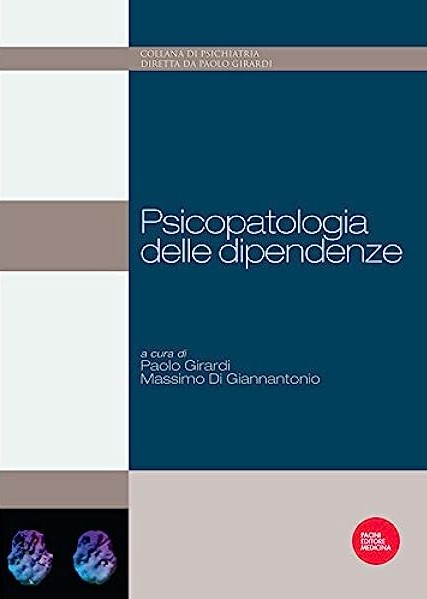 A cura di Paolo Girardi, Massimo Di Giannantonio, Psicopatologia delle dipendenze, Pacini, Pisa, 2020, 323 pp.
A cura di Paolo Girardi, Massimo Di Giannantonio, Psicopatologia delle dipendenze, Pacini, Pisa, 2020, 323 pp.
Da almeno venti anni si è diffusa una precisa consapevolezza sull’importanza della comorbidità psichiatrica nelle tossicodipendenze, ovvero la copresenza di disturbi psichici e di disagio psicologico in questi pazienti. L’abuso di sostanze può essere alla base di patologie e disturbi psichiatrici. La dipendenza, sovrapponendosi ad altri disturbi, può compromettere il quadro psichiatrico rendendo difficile la valutazione del paziente. Scopo di questo manuale è fornire, attraverso i contributi di autori impegnati da tempo nella ricerca e nella clinica, gli strumenti e le conoscenze utili per individuare un disturbo da abuso di sostanze e facilitare la diagnosi clinica. In quest’ottica il volume costituisce una guida pratica e concisa rivolta a studenti, medici e ad altre figure professionali.
Collocazione Biblioteca: 19014
Laurel Parnell, Il trattamento basato sull’EMDR per le dipendenze, Cortina, Milano, 2020, 326 pp.
L’autrice, psicologa clinica specializzata nel trattamento del trauma, applica la propria competenza nell’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) focalizzato sull’attaccamento e nel Resource Tapping alla sfida clinica del trattamento delle dipendenze. Il testo descrive tecniche basate sulle neuroscienze, fondate sulla compassione e volte ad aumentare la resilienza, che possono facilmente essere integrate in qualunque livello del trattamento delle dipendenze. Il volume rappresenta un’utile guida per orientarsi nel complesso territorio del trattamento della dipendenza, in modo da riconoscere e affrontare il trauma e integrare nella pratica interventi riparativi sui deficit di attaccamento. Il volume riporta numerosi esempi clinici e, alla fine, alcuni capitoli dedicati specificatamente a resoconti clinici che illustrano le tecniche descritte nel libro.
Collocazione Biblioteca: 19050
Tiziana Cassese, Paola Lattanzio, Ambulatorio “On-line” in emergenza Covid-19, in Dal fare al dire, a. 29, n. speciale (2020), pp. 16-21
L’associazione Aliseo è nata all’interno del Gruppo Abele nel 1987 e si occupa di prevenzione e cura delle patologie da alcol. L’articolo descrive come si siano declinate le attività dell’ambulatorio di alcologia dell’associazione Aliseo durante le prime fasi della pandemia da Covid-19: il confinamento e l’utilizzo delle risorse on line per colloqui con l’utenza e riunioni tra operatori; il rientro in presenza nel maggio 2020; la ripresa dei gruppi terapeutici nell’estate. Si veda anche l’articolo di Elena Zumaglino, Alessandra Vallino, Angela De Bernardis, A distanza si-cura. Telemedicina e teleassistenza nel Dipartimento Patologia Dipendenze Asl TO4 (Torino), in Dal fare al dire, a. 30, n. 2 (2021), pp. 36-40
Comunità terapeutiche e gruppi di auto-aiuto
Placido La Rosa, Le cure e gli approcci farmacologici sostituitivi nelle comunità terapeutiche, in Dal fare al dire, a. 31, n. 2 (2022), pp. 38-40
A partire dagli anni ’80, si è assistito ad un cambiamento del fenomeno delle tossicodipendenze: si è registrato un aumento di consumo di cocaina e crack, associate ad alcol, e di Nuove Sostanze Psicoattive; sono cambiate le modalità di assunzione ed è cambiata la tipologia di consumatori. Di fronte a tali cambiamenti si è reso necessario un adeguamento dei sistemi di cura nelle comunità terapeutiche.
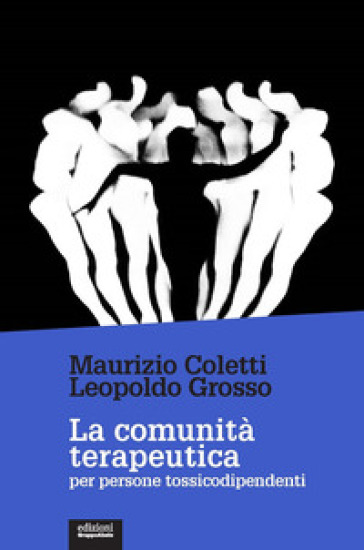 Maurizio Coletti e Leopoldo Grosso, Comunità terapeutica per persone tossicodipendenti, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022, 461 pp.
Maurizio Coletti e Leopoldo Grosso, Comunità terapeutica per persone tossicodipendenti, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022, 461 pp.
In occasione di un rinnovato interesse per l’argomento, dovuto ad un docufilm sulla comunità di San Patrignano che ha fatto scalpore e riaperto il dibattito, a dieci anni dalla prima edizione, Coletti e Grosso rivedono il loro scritto del 2011 sulle comunità terapeutiche. Si tratta di un classico imprescindibile per operatori e operatrici del settore (e non solo): un’analisi unica in Italia, fondata su una lunga esperienza, completa e documentata, con uno sguardo complessivo e trasversale che va oltre i miti, i luoghi comuni e le posizioni preconcette. Sono approfondite, nel testo, la storia delle comunità, le speranze e le delusioni che le hanno accompagnate, i diversi metodi di intervento praticati, i problemi emersi nella vita quotidiana tra gli ospiti e nei rapporti con gli operatori e con il territorio. Negli ultimi dieci anni la situazione delle dipendenze e degli strumenti per affrontarle è molto cambiata, da qui la necessità di un aggiornamento per una guida su potenzialità e limiti del trattamento residenziale nella cura di vecchie e nuove dipendenze. Uno strumento per le giovani generazioni di operatori e operatrici, con solidi riferimenti a pratiche ed esperienze, ma anche spunti per affrontare nuove sfide. Uno stimolo a riportare l’attenzione e a riaprire un dibattito serio e consapevole, da troppo tempo accantonato, sulla complessa e delicata questione della cura delle persone tossicodipendenti. Si segnala in particolare il paragrafo 7.7: Le comunità per persone alcoldipendenti.
Collocazione Biblioteca:19434
Valeriya Mefodeva … [et al.], Polysubstance use in young people accessing residential and day-treatment services for substance use. Substance use profiles, psychiatric comorbidity and treatment completion, in Addiction, vol. 117, n. 12 (dic. 2022) – on line, pp. 3110-3120
Le persone con disturbo da consumo di sostanze (substance use disorders =SUDs) si presentano spesso al trattamento con un policonsumo e problemi di salute mentale concomitanti. Combinazioni diverse di consumo di sostanze e problemi di salute mentale richiedono approcci di trattamento diversi. Questo studio trasversale prospettico ha utilizzato i dati dei servizi e gli esiti dei trattamenti di 744 utenti di età compresa tra 18 e 35 anni (48% maschi), ammessi a sette programmi residenziali e quattro programmi di trattamento diurno. La ricerca ha inteso: (i) individuare le classi di consumo di sostanze all’atto di ammissione al trattamento, (ii) stabilire quali sintomi di salute mentale, qualità della vita (quality of life = QoL) e tipi di servizio erano associati alle classi di consumo di sostanze individuate, e (iii) stabilire in prospettiva quali classi di consumo di sostanze e tipi di servizio avevano maggiori probabilità di completare il trattamento. Le sostanze consumate erano: tabacco, alcol, cannabis, cocaina, stimolanti del tipo amfetamina, oppiacei, sedativi e inalanti. Le problematiche prese in considerazione erano: depressione, ansia, stress post-traumatico e sintomi psicotici, come pure la qualità della vita.
Patrizia Balbinot, Gianni Testino, Disturbi da uso di alcol: e all'”Addiction” chi ci pensa?, in Nuova alcologia, n. 46 (2021) – on line, pp. 33-53
È noto che i disturbi da uso di alcol rappresentano un problema socio-sanitario significativo. Ad oggi le percentuali di successo clinico non sono soddisfacenti. L’ associazione di psicopatologia o fenomeni traumatici stressanti trovano validi trattamenti, tuttavia la rinuncia in autonomia di alcol e altre sostanze rappresenta la regola e difficilmente in questo modo si risolve il problema di dipendenza. Le evidenze scientifiche dimostrano che la vera innovazione, in questo ambito, è il concreto e diffuso coinvolgimento dei gruppi di AMA attraverso un’attività di “facilitazione”. Questo strumento è l’unico che affronta direttamente la dipendenza con risultati significativi a breve e lungo termine.
Douglas L. Polcin … [et al.], Understanding challenges for recovery homes during COVID-19, in The International Journal of Drug Policy, vol. 93, art. 102986 (lug. 2021) – on line, pp. 1-4
Capire gli effetti dell’attenuazione del COVID-19 per le persone che conducono vita di gruppo è di fondamentale importanza per limitare la diffusione del virus. Negli Stati Uniti le strutture residenziali di recupero per persone con disturbi da alcol e droga sono ambienti ad alto rischio dove le procedure per la limitazione del contagio sono essenziali. La National Alliance for Recovery Residences (NARR) ha ripreso le raccomandazioni elaborate dal Center for Disease Control (CDC) e le ha applicate agli ambienti delle strutture residenziali di recupero. Questo documento descrive come gli sforzi di attenuazione del COVID-19 in tali strutture possono essere influenzati da due fattori: alcune strutture sono autorizzate dagli stati con rigorosi standard di salute e sicurezza, altre non sono autorizzate e sono soggette a minore vigilanza; a vari livelli, le strutture residenziali di recupero utilizzano un approccio di modello sociale che contrasta con le misure di attenuazione quali il distanziamento sociale e gli ordini di rimanere a casa. Questo documento descrive come tali strutture sono state costrette ad adeguarsi alle opposte esigenze degli sforzi di attenuazione e del recupero del modello sociale.
 Laura Angelica Berni, Giuseppe Roberto Troisi, Paola Trotta, La psicoterapia del trauma in comunità terapeutica: uno studio su utenti tossicodipendenti e alcol dipendenti, in Nuova alcologia, n. 44 (2021) – on line, pp. 71-86
Laura Angelica Berni, Giuseppe Roberto Troisi, Paola Trotta, La psicoterapia del trauma in comunità terapeutica: uno studio su utenti tossicodipendenti e alcol dipendenti, in Nuova alcologia, n. 44 (2021) – on line, pp. 71-86
Il presente studio si prefigge di esaminare gli effetti di un intervento psicoterapeutico sistemico-relazionale integrato con la tecnica di rinegoziazione del trauma basata sui fondamenti neurofisiologici delle emozioni, dell’attaccamento, della comunicazione e dell’autoregolazione di Stephen W. Porges, sugli approcci sul corpo di Peter Levine e sulle esperienze senso-motorie raccolte e discusse da Bessel A. Van Der Kolk, effettuato su tre utenti inseriti nella Comunità Terapeutica pubblica di Poggio Asciutto dell’Azienda USL Toscana Centro in un periodo di circa tre anni. Siamo partiti dal presupposto che il paziente sopravvissuto al trauma abbia un sistema nervoso autonomo disregolato e una capacità di autocura compromessa.
Chiara Ferrari, Psico Alcolisti Anonimi e Al-Anon: quale legame?, in Narrare i gruppi, vol. 15, n. 2 (dic. 2020) – on line, pp. 239-258
Dopo aver esposto storia e funzionamento degli Alcolisti Anonimi, l’articolo descrive i principali meccanismi di cambiamento del comportamento agenti nel gruppo. Si intende mostrare come gli Alcolisti Anonimi siano efficaci nel ridurre la tendenza al consumo di sostanza attraverso l’attivazione di reti sociali adattive. Si passerà a descrivere come fa-miglie supportate da gruppi di auto aiuto specifici (Al-Anon) possano essere preparate a gestire meglio la relazione con il loro caro aiutandolo nel recupero. Si rifletterà, infine, sulla sinergia possibile tra gli Alcolisti Anonimi e gli Al-Anon, mostrando l’interdipendenza dei soggetti coinvolti e la potenzialità della partecipazione attiva al proprio disagio.
Patrizia Balbinot, Gianni Testino, Introduzione del facilitatore ai gruppi di auto-mutuo-aiuto e di caregivers informali. Risultati preliminari, in Nuova alcologia, n. 42 (2020) – on line, pp. 30-37
Il trattamento dei pazienti affetti da disturbo da uso di alcol (DUA) prevede l’astensione come risultato principale, attraverso le terapie farmacologica e psicoterapica. Attualmente lo strumento più efficace per il mantenimento dell’astensione è la frequenza ai gruppi di auto-mutuo-aiuto (SHGs). Nonostante ciò, ad oggi pochi pazienti frequentano tali gruppi. Per questa ragione abbiamo deciso di introdurre il facilitatore ai gruppi di auto-mutuo- aiuto (SHGF). I risultati preliminari indicano che la presenza di tale figura ha incrementato il numero di pazienti che frequentano ed inoltre si è rilevata una riduzione del consumo alcolico. È suggestivo immaginare che un operatore sociale possa migliorare l’andamento clinico a costi presumibilmente inferiori.
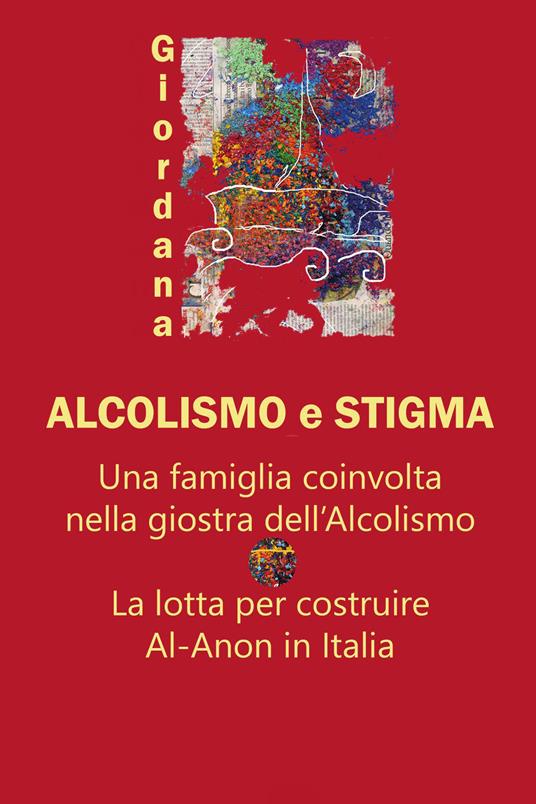 Giordana, Alcolismo e stigma. Una famiglia coinvolta nella giostra dell’alcolismo. La lotta per costruire Al-Anon in Italia, Youcanprint, Lecce, 2020, 157 pp.
Giordana, Alcolismo e stigma. Una famiglia coinvolta nella giostra dell’alcolismo. La lotta per costruire Al-Anon in Italia, Youcanprint, Lecce, 2020, 157 pp.
Due vite, quelle di Leonella e della figlia Laura, si legano ad un’associazione di mutuo aiuto che si occupa di alcolismo. È il periodo in cui l’Associazione sta sorgendo. Mario, il gemello di Laura, giovanissimo, è travolto da problemi di alcool e droga. Leonella e Laura cercano ogni strada per poterlo aiutare. Volutamente si alternano, nel libro, le vicende personali a quelle di Al-Anon (Associazione Familiari e Amici di Alcolisti Anonimi), divenendo inscindibili, così come è stato nella realtà. I problemi verranno superati grazie ai principi-guida postulati dall’Associazione stessa. Giordana è una giornalista e fotografa.
Collocazione Biblioteca: 19361
Antonio Simula, Laura Lunesu, L’efficacia del trattamento comunitario delle dipendenze. Analisi di follow-up nella comunità “Casa di Giano” di Trento, in Mission, a. 14, n. 54 (nov. 2020), pp. 50-55
In questo studio vengono presentati i risultati del follow-up realizzato a “Casa di Giano”, una comunità terapeutica con sede a Santa Massenza nella Valle dei Laghi (TN), gestita dal Centro Trentino di Solidarietà Onlus, rivolta a soggetti con disturbi psichici coesistenti con disturbi correlati a sostanze. Sono proposti due percorsi di cura: il modulo “Doppia Diagnosi”, caratterizzato da una forte impronta terapeutica in senso clinico, in cui è possibile accedere previa diagnosi di disturbo da uso di sostanze e concomitante disturbo psichico primario o secondario all’uso di sostanze; il modulo “Sobrietà”, un modulo specifico per persone con diagnosi di disturbo alcol-correlato, cocainismo e gioco d’azzardo. L’indagine per valutare l’efficacia dei programmi terapeutici è stata effettuata su un campione di 48 soggetti che hanno svolto un percorso terapeutico nel periodo tra il 2014 e il 2018, ai quali è stato sottoposto un questionario composto da 44 domande, tramite intervista telefonica.
Mauro Cibin … [et al.], Ricerca e innovazione in comunità terapeutica, in MDD : Medicina delle Dipendenze, n. 38 (giu. 2020), pp. 4-56
Questo numero monografico di MDD, nasce dalla sessione “Sistema dei Servizi per l’Addiction” tenutasi nell’ambito del Congresso Nazionale della Società Italiana Tossicodipendenze (SITD) a Catanzaro nell’ottobre 2019 . Gli articoli hanno la caratteristica di essere nel contempo esempi di ricerca su vari aspetti delle comunità terapeutiche (CT) e proposte di cambiamento e innovazione in questo ambito: la situazione e le prospettive delle CT in Europa, con un focus sulla loro efficacia (W.Vanderplasschen, S. Vandevelde), il ruolo della riabilitazione psicosociale centrata sul recovery nel rinnovamento dei programmi in CT (M. Cibin), le problematiche connesse allo squilibrio delle normative regionali nei processi di accreditamento (G. Grillo, L.Squillaci), l’impatto della psicopatologia sulla permanenza in CT (Maremmani et al.), l’ambiente arricchito come prospettiva di benessere (Chiamulera et al.), il trattamento in CT della dipendenza da analgesici (Semenzato et al.) e per concludere i programmi di gestione delle contingenze nelle dipendenze (Cenedese e Canali).
La prevenzione, la riduzione del danno e le politiche
Franca Beccaria, Al lupo al lupo. Bevande alcoliche, linee guida e allert sanitari, Fuoriluogo.it, [s.l.], 2023, 6 pp.
La sociologa Franca Beccaria è intervenuta sul tema delle warning labels: le etichette che la Commissione Europea vuole introdurre al fine di avvertire i consumatori sui rischi legati al consumo di bevande alcoliche. Una riflessione sociologica sui contenuti e le modalità di comunicazione dei rischi che, a volte, non tengono conto dei significati fortemente sociali che caratterizzano il bere e i contesti di consumo. L’articolo è la trascrizione del podcast.
Brienna N. Rutherford … [et al.], #TurntTrending. A systematic review of substance use portrayals on social media platforms, in Addiction, vol. 118, n. 2 (feb. 2023) – on line, pp. 206-217
C’è un corpus crescente di letteratura che esplora i tipi di contenuti relativi alle sostanze e le loro rappresentazioni su varie piattaforme di social media. In questa ricerca su database si è cercato di riassumere come i contenuti relativi alle sostanze siano rappresentati su varie piattaforme di social media. Vengono discussi i risultati. In conclusione si rileva che i contenuti relativi a sostanze che promuovono l’uso di sostanze o lo descrivono attivamente sembrano essere ampiamente disponibili sui social media. La presenza di questo contenuto può avere influenze preoccupanti su atteggiamenti, comportamenti e percezioni relative all’uso di sostanze da parte del grande pubblico e in particolare tra gli utenti più vulnerabili e presenti sui social media: adolescenti e giovani adulti.
 World Health Organization, Reducing the harm from alcohol by regulating cross-border alcohol marketing, advertising and promotion. A technical report, World Health Organization, Ginevra, 2022, 168 p.
World Health Organization, Reducing the harm from alcohol by regulating cross-border alcohol marketing, advertising and promotion. A technical report, World Health Organization, Ginevra, 2022, 168 p.
Questo rapporto approfondisce il tema di come l’alcool sta venendo pubblicizzato oltre i confini nazionali – spesso tramite mezzi digitali – e frequentemente senza alcuna considerazione del contesto sociale, economico o culturale dei paesi riceventi. Il report mette in evidenza come tecniche di promozione sempre più sofisticate, tecniche che includono il correlare marche di alcolici ad attività sportive e culturali, l’uso di sponsor e l’utilizzo di e-mail, SMS e social media, stanno venendo utilizzate per aumentare la ricorrenza dei compratori e raggiungere nuovi clienti. Inoltre mostra che giovani e “forti bevitori” sono sempre più presi di mira dalle pubblicità degli alcolici, spesso a danno della loro salute, e mette in evidenza la necessità di leggi più efficaci e migliore collaborazione internazionale sul tema.
Emmanuel Guindon … [et al.], Prices, taxes and alcohol use. A systematic umbrella review, in Addiction, n. 12 (dic. 2022) – on line, pp. 3004-3023
Questo studio si proponeva di misurare l’impatto delle tasse e dei prezzi sul consumo di alcol con particolare attenzione al diverso contesto nei paesi a basso e medio reddito. Le ricerche prese in esame generalmente concludevano che le tasse e i prezzi più elevati erano associati a minore consumo pesante sia episodico che continuativo, benché l’ampiezza di queste associazioni non fosse generalmente chiara. Gli studi non hanno fornito nessuna prova che la risposta al prezzo dell’alcol differisse in base alla condizione socio-economica. Questa ricerca dunque attesta che le tasse sono efficaci nel ridurre il consumo di alcol. Inoltre, aumentare il prezzo dell’alcol con l’aumento delle tasse può anche presumibilmente aumentare il gettito fiscale, poiché la domanda di alcol è certamente non elastica. Nel medesimo numero della rivista si segnalano anche l’articolo di Eleni Mantzari … [et al.], Impact of wine bottle and glass sizes on wine consumption at home. A within- and between- households randomized controlled trial, pp. 3037-3048 e lo studio di Lauren Halsall … [et al.], The impact of alcohol priming on craving and motivation to drink. A meta-analysis, pp. 2967-3178.
Simon Foster, Gerhard Gmel, Meichun Mohler-Kuo, Young Swiss men’s risky single-occasion drinking: Identifying those who do not respond to stricter alcohol policy environments, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 235, art. 109383 (mag. 2022) – on line, pp. 1-8
L’obiettivo del presente studio è esaminare le relazioni tra la severità delle politiche in materia di alcol e il consumo pesante di alcol e di identificare gli elementi di tale relazione. Sono stati analizzati i dati trasversali di 5986 giovani uomini svizzeri partecipanti allo studio di coorte sui fattori di rischio dell’uso di sostanze (C-SURF). L’esito primario è stato il consumo rischioso di alcolici in un’unica occasione negli ultimi 12 mesi (RSOD, definito come 6 drink standard o più in un’unica occasione almeno mensilmente). È stato analizzato un indice precedentemente utilizzato di severità dell’ambiente delle politiche sull’alcol nei cantoni svizzeri, insieme a 21 potenziali variabili moderatrici. Nell’articolo sono riportati e commentati i risultati dell’indagine.
Siri Thor … [et al.], Fathers’ alcohol consumption and risk of substance-related disorders in offspring, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 233, art. 109354 (apr. 2022) – on line, pp. 1-7
Pochi studi hanno valutato come i figli siano influenzati dal consumo di alcol dei genitori senza problemi alcolici clinicamente diagnosticati. L’obiettivo della ricerca è indagare come il consumo di alcol dei padri sia correlato al rischio di disturbi correlati alle sostanze per i figli. Nell’articolo è presentato uno studio prospettico di coorte su 64.710 cittadini svedesi, i cui padri sono stati arruolati per l’addestramento militare obbligatorio all’età di 18-20 anni negli anni 1969/70. I ricercatori hanno raccolto informazioni sul consumo di alcol dei padri, sulla frequenza delle ubriacature e dei fermi per ubriachezza, durante il loro servizio di leva e hanno seguito e valutato i figli per i disturbi correlati alle sostanze, dall’età di 12 anni fino alla fine del follow-up nel 2009. Nell’articolo sono riportati e commentati i risultati dell’indagine. Si segnala inoltre la ricerca di Jasmina Burdzovic Andreas, Fartein Ask Torvik, Ingunn Olea Lund, Parental binge drinking and offspring’s high school non-completion. A prospective HUNT survey and educational registry study, vol. 230, Art.109189 (gen. 2021) – on line, pp. 1-9, che indaga se forme di consumo di alcol da parte dei genitori come il binge drinking possono essere un fattore di rischio per i figli, ed in particolare per il mancato completamento delle scuole superiori.
Zoe E. Reed, Robyn E. Wootton, Marcus R. Munafò, Using Mendelian randomization to explore the gateway hypothesis: possible causal effects of smoking initiation and alcohol consumption on substance use outcomes, in Addiction, vol. 117, n. 3 (mar. 2022) – on line, pp. 741-750
Si pensa che l’uso iniziale di droghe quali il tabacco e l’alcol possa portare a un consumo più problematico successivo di droghe, è l’ipotesi del ‘passaggio’. Tuttavia le associazioni osservate possono essere dovute a un fattore condiviso di rischio sotterraneo, quali la caratteristica di impulsività. In questo studio è stato utilizzata la randomizzazione bidirezionale Mendeliana (Mendelian randomization = MR) per verificare l’ipotesi del “passaggio”. La ricerca ha evidenziato che l’iniziazione al fumo può portare a un aumento del consumo di alcol, al consumo e alla dipendenza da cannabis. Il consumo di cannabis può anche portare all’ iniziazione al fumo e la dipendenza da oppiacei al consumo di alcol. Tuttavia, dato che il consumo di alcol e tabacco tipicamente inizia prima dell’uso di altre droghe, questi risultati possono riflettere un fattore di rischio condiviso o un effetto bidirezionale per il consumo di cannabis e la dipendenza da oppiacei.
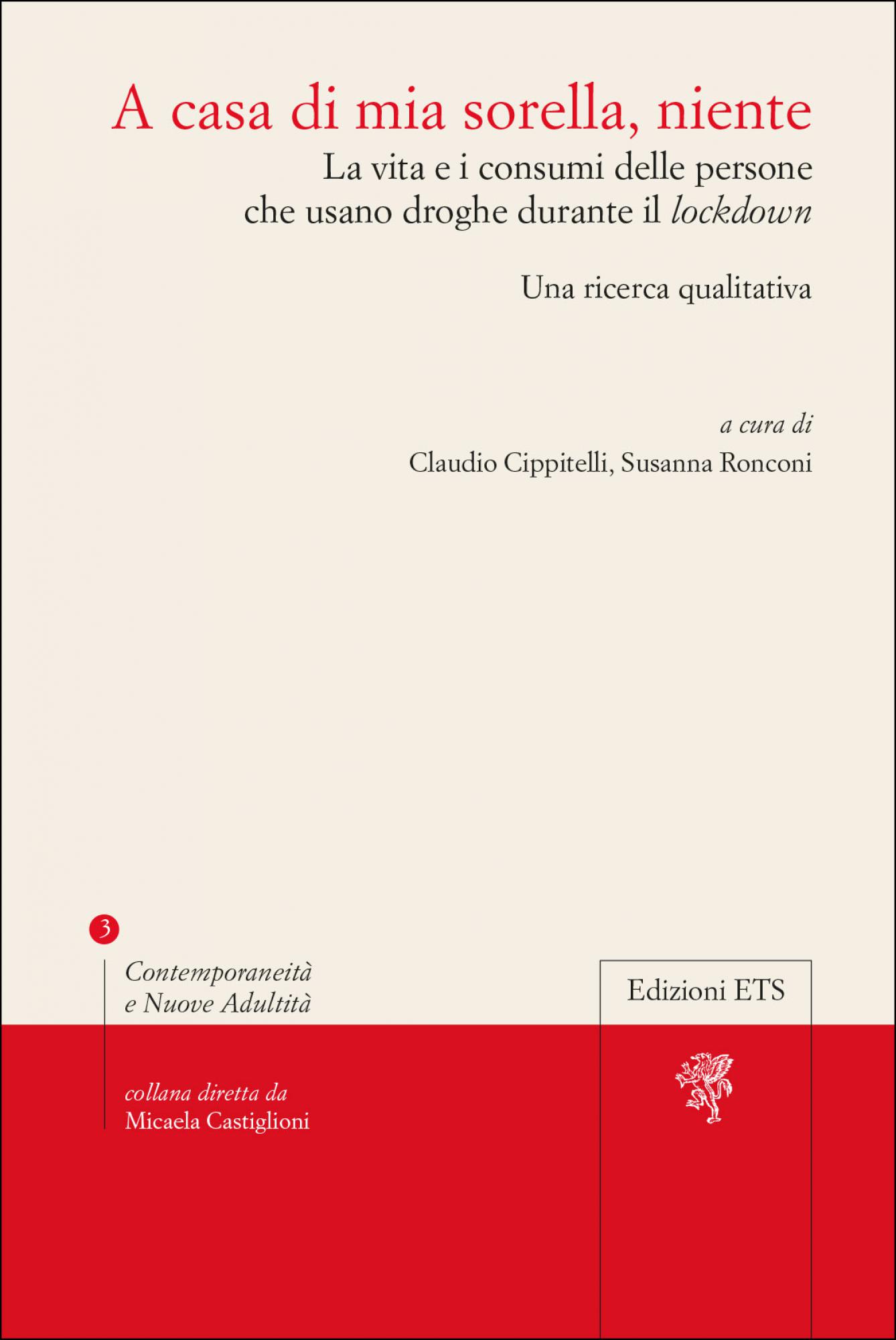 A cura di Claudio Cippitelli, Susanna Ronconi, A casa di mia sorella, niente. La vita e i consumi delle persone che usano droghe durante il lockdown. Una ricerca qualitativa, ETS, Pisa, 2022, 267 pp.
A cura di Claudio Cippitelli, Susanna Ronconi, A casa di mia sorella, niente. La vita e i consumi delle persone che usano droghe durante il lockdown. Una ricerca qualitativa, ETS, Pisa, 2022, 267 pp.
Come hanno affrontato la pandemia da covid-19 e il primo lockdown del marzo 2020 le persone che usano droghe? Come hanno gestito i propri consumi di sostanze e che strategie hanno adottato per far fronte a un cambiamento così disorientante? Queste le domande che hanno guidato la ricerca presentata nel libro, condotta secondo l’approccio centrato sul consumo controllato di droghe. Le risposte fornite da un gruppo di consumatori gettano luce sulle capacità, le competenze, le strategie di chi usa nel saper riorientare e adattare il proprio consumo in modo funzionale, anche in una situazione così estrema.
Collocazione Biblioteca: 20113
Emanuele Scafato … [et al.], Alcol e tassazione, necessità e urgenza delle più efficaci ma contrastate misure delle politiche di prevenzione per ridurre la mortalità per cancro e rischi per la salute causati dall’alcol in Europa e in Italia, in Nuova alcologia, n. 46 (2021) – on line, pp. 12-19
L’efficacia di alcune politiche nella riduzione del consumo e quindi nella prevenzione del cancro alcol-correlato è stata dimostrata in diversi studi approvati all’unanimità dalla comunità scientifica, ma, sebbene il nesso causale tra alcol e cancro sia noto da decenni, a oggi non sono state messe in atto azioni sufficienti per ridurre il peso di un fenomeno del tutto prevenibile. Fra queste politiche, l’aumento delle tasse sulle bevande alcoliche è una delle misure più efficaci, pur essendo quella meno applicata. Infatti 23 dei 53 stati membri dell’UE non applicano tasse sul vino. Gli autori hanno simulato diversi scenari, ipotizzando quali sarebbero stati i casi di cancro nel 2019 se dieci anni prima, nel 2009, ci fosse stato un aumento delle accise del 20%, 50% e 100% sulle bevande alcoliche (assumendo un tempo di latenza fra consumo e insorgenza del tumore di 10 anni). Nell’articolo vengono riportati e commentati i risultati delle loro indagini.
World Health Organization European Office for the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases, Digital marketing of alcohol. Challenges and policy options for better health in the WHO European Region, World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen, 2021, 100 pp.
La Regione Europea del WHO (= OMS) ha il livello più alto di consumo di alcolici tra gli adulti. Nel 2016, la media regionale per gli adulti (individui dai 15 anni in su) era di 9.8 litri di alcool puro a testa (8.0 litri di alcool registrato e 1.8 di alcol non registrato). Limitare il marketing dell’alcool è un “Best Buy” del WHO – una pratica efficiente a livello di costi per ridurre il consumo di alcool e i problemi ad esso attribuibili. D’altro canto, con la diffusione ubiqua di tablet e smartphone, le persone, giovani e non, sono sempre più esposte al marketing degli alcolici in tutti i propri spazi sociali. Questo rapporto attinge da rapporti precedenti del WHO su marketing e marketing digitale e dalle consultazioni con gli Stati Membri e la società civile per sottolineare la necessità di un’azione urgente per proteggere la salute pubblica e i diritti umani. Il rapporto analizza l’ecosistema digitale, in veloce cambiamento, e i metodi utilizzati per invadere gli spazi personali con le pubblicità di alcolici. Provvede un’istantanea dei contesti regolatori in una piccola selezione di Paesi nella regione europea del WHO, e anche a livello internazionale. Viene proposto un ventaglio di opzioni politiche, con una conclusione generale che enfatizza il bisogno urgente di un’azione coordinata da parte degli stati e delle istituzioni internazionali. È richiesto un approccio globale e comprensivo, con l’intento di proteggere bambini e giovani, le persone con (o a rischio di) disturbi legati all’abuso di sostanze e la popolazione generale attraverso la rimozione completa delle pubblicità di alcolici dagli spazi online.
Paolo Deluca … [et al.], Brief interventions to prevent excessive alcohol use in adolescents at low-risk presenting to Emergency Departments: Three-arm, randomised trial of effectiveness and cost-effectiveness, in The International Journal of Drug Policy, vol. 93, art. 103113 (lug. 2021) – on line, pp. 1-9
Il consumo di alcol e i relativi danni aumentano rapidamente dai 12 anni di età. Nel presente studio, i ricercatori hanno valutato se lo screening per l’alcol e un intervento tempestivo sono efficaci ed economicamente vantaggiosi nel ritardare il consumo pericoloso o abuso di alcol negli adolescenti a basso rischio o astinenti che si trovano in un Pronto Soccorso. Questo studio randomizzato in dieci centri, a tre bracci, a gruppi paralleli, in singolo cieco, pragmatico, individualmente randomizzato, ha sottoposto a screening per il consumo di alcol i frequentatori del Pronto Soccorso di età compresa tra i 14 ei 17 anni. Sono stati campionati a caso un terzo di quelli con un punteggio massimo di 2 su AUDIT-C che avevano accesso a Internet e, se di età inferiore a 16 anni, erano competenti Gillick o avevano un consenso informato di un genitore o un tutore. Sono stati assegnati casualmente fra: solo screening (intervento di controllo); una sessione di feedback personalizzato e breve consulenza in presenza (Personalised Feedback and Brief Advice = PFBA); e PFBA più un breve intervento elettronico (eBI) sullo smartphone o sul web. E’ stato effettuato un follow-up dopo 6 e 12 mesi. Nell’articolo sono riportati e commentati i risultati della ricerca.
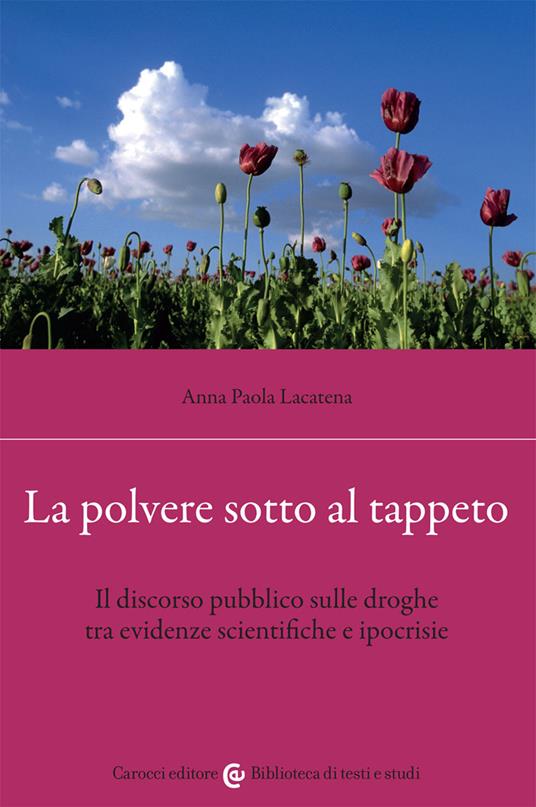 Anna Paola Lacatena, La polvere sotto al tappeto. Il discorso pubblico sulle droghe tra evidenze scientifiche e ipocrisie, Carocci, Roma, 2021, 198 pp.
Anna Paola Lacatena, La polvere sotto al tappeto. Il discorso pubblico sulle droghe tra evidenze scientifiche e ipocrisie, Carocci, Roma, 2021, 198 pp.
L’autrice, giornalista e sociologa, espone la propria visione nell’ambito del dibattito sulle droghe. In Italia, il confronto sul consumo di sostanze psicotrope tiene conto del sensazionalismo dei media, del moralismo della società, dell’immobilismo e della retorica della politica. Le evidenze scientifiche sono sacrificate alle ideologie, ai lobbismi, alla disumanizzazione dei consumatori e dei dipendenti patologici. I proibizionisti non ammettono il piacere e l’uso ricreativo delle droghe e gli antiproibizionisti escludono aprioristicamente la malattia, rischiando entrambi di estromettere il contesto, le differenze tra le sostanze, l’individualità e la storia personale. Le droghe e i loro utilizzatori non possono essere considerati in maniera univoca. Partendo dal presupposto che chi fa uso di droghe non è un criminale, il testo tiene in considerazione il piano sanitario e socioculturale, sulla scorta del modello portoghese e del contributo offerto da alcuni protagonisti del mondo della cultura.
Collocazione Biblioteca: 19851
Anh P. Ngo … [et al.], Alcohol excise taxes as a percentage of retail alcohol prices in 26 OECD countries, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 219, art. 108415 (feb. 2021) – on line, pp. 1-9
Molti paesi hanno implementato le accise sull’alcol. Tuttavia le misure delle accise come percentuale dei prezzi dell’alcol non sono state studiate sistematicamente. In questa ricerca sono stati presi in considerazione i dati sui prezzi al dettaglio delle bevande alcoliche vendute in supermercati e le accise in 26 paesi negli anni dal 2003 al 2018. Dallo studio si evince che l’onere fiscale sulle bevande alcoliche è basso nei paesi dell’ OCSE, indicando un ampio margine per aumenti delle accise, in particolare per la birra e il vino in quei Paesi.
Claudia Gandin … [et al.], Le politiche alcologiche di prevenzione: i principali aggiornamenti europei, in Nuova alcologia, n. 45 (2021) – on line, pp. 5-14
Nel corso del 2020 a livello europeo sono state pubblicate alcune revisioni di documenti strategici e programmatici di misure politiche di contrasto al consumo rischioso di alcol ed ai danni alcolcorrelati. L’impegno di supporto all’OMS, che l’ISS assicura attraverso l’Osservatorio Nazionale Alcol, comprende anche l’aggiornamento epidemiologico e la sorveglianza specifica SISMA (Sistema di Monitoraggio Alcol) sulla base di quanto previsto dalla Legge 125/2001. Gli argomenti di politica alcologica aggiornati di recente dall’OMS sono stati 3: l’etichettatura, il prezzo di vendita, la tassazione, e il marketing delle bevande alcoliche riassunte nell’articolo.
Birgitte Hoiberg-Nielsen, Immagini e mentalità nei confronti dell’alcol all’Europa del Nord (esempio della Danimarca), in Nuova alcologia, n. 45 (2021) – on line, pp. 28-36
Il seguente contributo ha lo scopo di mostrare come l’immagine storico-culturale dell’alcol si trovi in netto disaccordo con l’impatto forte dell’alcol sulla vita privata e sociale dei cittadini del Nord Europa, specialmente in Danimarca, dove il libero consumo dell’alcol viene comunemente percepito come un diritto civile. Questa percezione si sposa in modo fatale con un lobbysmo per l’alcol storicamente molto efficace, tant’è che ora risulta parte integra della cultura popolare del paese. La legislazione danese tutela questa libertà nel consumo dell’alcol, in contrasto agli altri paesi nordici e a scapito del suo obbligo di tutela della salute del cittadino in quanto bene sociale ed individuale, oltre che in quanto un diritto civile ben più fondamentale del diritto di bere.
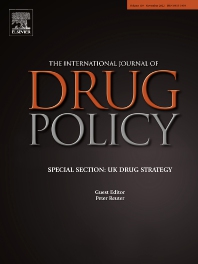 Joanna Reynolds … [et al.], ‘The opportunity to have their say’? Identifying mechanisms of community engagement in local alcohol decision-making, in The International Journal of Drug Policy, vol. 85, n. 102909 (nov. 2020) – on line, pp. 1-12
Joanna Reynolds … [et al.], ‘The opportunity to have their say’? Identifying mechanisms of community engagement in local alcohol decision-making, in The International Journal of Drug Policy, vol. 85, n. 102909 (nov. 2020) – on line, pp. 1-12
Il coinvolgimento della comunità nei processi decisionali per migliorare la salute pubblica è riconosciuto di grande importanza, ed è raccomandato nelle strategie globali contro l’alcol e nelle politiche nazionali sul controllo della sua disponibilità. Tuttavia c’è scarsa comprensione di come coinvolgere le comunità per influenzare il processo decisionale e aiutare a ridurre i danni collegati all’alcol. Si è cercato di individuare e capire i meccanismi di tale coinvolgimento nel processo decisionale riguardante l’ambiente locale del consumo alcolico in Inghilterra.
Sally Casswell, Jürgen Rehm, Reduction in global alcohol-attributable harm unlikely after setback at WHO Executive Board, in The Lancet, vol. 395, n. 10229 (mar. 2020) – on line, pp. 1020-1021
Si tratta di una consultazione informale tra i membri del Consiglio esecutivo dell’OMS nel febbraio 2020. L’obiettivo era di proporre la fattibilità dello sviluppo di uno strumento internazionale per il controllo dell’alcol. Infatti possiamo vedere un aumento del consumo di alcol (e dei danni attribuibili all’alcol) in molti paesi a basso reddito e reddito medio. Per abbassare i danni dell’alcol, l’Organizzazione mondiale della sanità avrà la necessità di sostenere i servizi sanitari nazionali e avrà necessità di creare uno strumento per coordinare quest’aiuto a livello internazionale. Per il momento gli strumenti attuali (tasse, prezzi, restrizioni alla commercializzazione di alcol) sembrano non bastare.
Elisa Martino, Teo Vignoli, Andrea Martini, Interventi di prevenzione alcologica con gruppi di richiedenti protezione internazionale: metodologia ed esiti di un’esperienza operativa, in Alcologia, n. 39 (2020) – on line, pp. 21-30
Gli interventi info-educativi di gruppo sono rivolti a richiedenti protezione internazionale ospitati nel distretto di Lugo, con l’obiettivo primario di offrire informazioni sulle caratteristiche, sui rischi e sui danni prodotti dal consumo a basso e ad alto rischio, nonché dalla dipendenza da alcol; l’obiettivo secondario è accedere a una popolazione che, quando sviluppa comportamenti di abuso alcolico, rimane nella cosiddetta fascia del “sommerso” e non accede ai servizi specialistici di cura. La metodologia adottata è di tipo narrativo e ricorre all’utilizzo di moderne tecnologie e ad attivazioni pratiche, finalizzate a facilitare la trasmissione dei contenuti, agevolando il superamento delle barriere culturali e linguistiche.
Sally Casswell, Jürgen Rehm, Reduction in global alcohol-attributable harm unlikely after setback at WHO Executive Board, in The Lancet, (mar. 2020) – on line, pp. 1020-1021
Si tratta di una consultazione informale tra i membri del Consiglio esecutivo dell’OMS nel febbraio 2020. L’obiettivo era di proporre la fattibilità dello sviluppo di uno strumento internazionale per il controllo dell’alcol. Infatti possiamo vedere un aumento del consumo di alcol (e dei danni attribuibili all’alcol) in molti paesi a basso reddito e reddito medio. Per abbassare i danni dell’alcol, l’Organizzazione mondiale della sanità avrà la necessità di sostenere i servizi sanitari nazionali e avrà necessità di creare uno strumento per coordinare quest’aiuto a livello internazionale. Per il momento gli strumenti attuali (tasse, prezzi, restrizioni alla commercializzazione di alcol) sembrano non bastare.
I giovani, l’alcol, il binge drinking
Chrianna Bharat, … [et al.], Development and evaluation of a risk algorithm predicting alcohol dependence after early onset of regular alcohol use, in Addiction, vol. 118, n. 5 (mag. 2023) – online, pp. 781-990
L’articolo presenta i risultati di una ricerca in cui ci si proponeva di creare un algoritmo predittivo per aiutare a individuare giovani a rischio di dipendenza da alcool (come definita dal DSM-IV) conseguente all’uso abituale di alcolici precedente alla maggior età. È stato sviluppato un modello di predizione per l’inizio della dipendenza dall’alcol entro i 25 anni usando un algoritmo di apprendimento automatico dell’insieme conosciuto come ‘Super Learner’. Le spiegazioni aggiuntive di Shapley (SHAP) hanno valutato l’importanza delle variabili. Dallo studio si evince che risulta possibile creare un algoritmo di rischio usando i dati raccolti all’inizio del consumo regolare di alcol per individuare i giovani a maggiore rischio di dipendenza entro la prima età adulta, ma è necessario un maggiore studio dei modelli e strumenti per una maggior affidabilità dei dati.
 Giovanni Addolorato … [et al.], Newsletter “Clinica dell’Alcolismo”, in Mission, a. 16, n. 58 (nov. 2022) – on line, pp. 19-38
Giovanni Addolorato … [et al.], Newsletter “Clinica dell’Alcolismo”, in Mission, a. 16, n. 58 (nov. 2022) – on line, pp. 19-38
Tra gli articoli pubblicati si segnala: “Stato nascente di un gruppo terapeutico per giovani in trattamento ambulatoriale per alcol: vignette cliniche di un evento inaugurale” di Silvia Formentin … [et al.].
Siobhan M. O’Dean … [et al.], Definition matters. Assessment of tolerance to the effects of alcohol in a prospective cohort study of emerging adults, in Addiction, vol. 117, n. 11 (nov. 2022) – on line, pp. 2955-2964
La tolleranza agli effetti dell’alcol è un elemento importante nella diagnosi dei disturbi da consumo alcolico (alcohol use disorders = AUD), tuttavia è in corso un dibattito sulla sua utilità nelle diagnosi AUD negli adolescenti e nei giovani adulti. Questo studio ha voluto perfezionare la valutazione della tolleranza nei giovani adulti verificando diverse definizioni di tolleranza e le loro associazioni con i risultati longitudinali sui disturbi AUD. Nel predire un disturbo persistente da consumo alcolico, gli indicatori basati su un consumo medio pesante sembrano essere un modo migliore per misurare la tolleranza rispetto alle definizioni di cambiamento auto-riferite.
Kasey G. Creswell, Yvonne M. Terry-Mc Elrath, Megan E. Patrick, Solitary alcohol use in adolescence predicts alcohol problems in adulthood: a 17-year longitudinal study in a large national sample of US high school students, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 238, (set. 2022) – on line, pp. 1-8
Identificare i fattori di rischio del disturbo da consumo di alcol (AUD) è importante per la sanità pubblica. Il contesto sociale del consumo alcolico -come il bere da soli- può essere un indicatore indipendente e forte di rischio precoce per i sintomi di AUD più avanti nella vita. Nello studio proposto i ricercatori hanno valutato se il consumo solitario di alcol nell’adolescenza (18 anni) e nella giovane età adulta (23/24 anni) é associato al consumo binge e fa prevedere in prospettiva sintomi di AUD a 35 anni e se le associazioni sono diverse a seconda del sesso. Nell’articolo sono riportati e commentati i risultati della ricerca.
Patrizia Balbinot, Gianni Testino, Alcol, fumo, cannabis, nuove sostanze psicoattive, farmaci non prescritti e altri parametri in una popolazione studentesca dell’area metropolitana genovese, in Nuova Alcologia, n. 49 (2022), pp. 72-85
Lo studio presentato intende valutare il consumo di alcol, fumo di sigaretta, cannabis, nuove sostanze psicoattive (NSP), farmaci non prescritti (NPD) in una popolazione studentesca del nord-ovest dell’Italia (area metropolitana di Genova). Sono stati coinvolti 3805 studenti tra i 9 e i 17 anni, che hanno seguito una serie di incontri di educazione al corretto stile di vita e ai quali è stato somministrato un questionario anonimo relativo allo stile di vita, al consumo delle suddette sostanze e all’inserimento in un percorso psicologico. Gli autori discutono i risultati, che ritengono utili ai decisori politici per attuare politiche di prevenzione e promozione della salute attraverso la didattica, da inserire stabilmente nei programmi scolastici e riconoscere nel percorso curriculare, già nella preadolescenza.
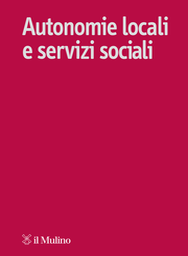 Enrico Petrilli, Sonia Stefanizzi, Il controllo della movida: la parola al popolo della notte torinese, in Autonomie locali e servizi sociali, n. 1 (apr. 2022), pp. 177-194
Enrico Petrilli, Sonia Stefanizzi, Il controllo della movida: la parola al popolo della notte torinese, in Autonomie locali e servizi sociali, n. 1 (apr. 2022), pp. 177-194
L’articolo indaga come i fruitori della cosiddetta movida (la vita notturna nei centri urbani) giudicano le principali strategie sviluppate dalle amministrazioni locali per controllarla e quali conseguenze esse hanno prodotto. In particolare, viene approfondito il caso della città di Torino, dove la movida è diventata una delle questioni più dibattute. L’indagine è stata svolta tramite interviste semi-strutturate a un campione di giovani frequentatori della movida tra i 19 e i 23 anni e a un campione di avventori adulti tra i 35 e i 50 anni.
Maria Raffaella Rossin, Lina Galvagno, I giovani e i riti di passaggio: il significato dell’alcol, in Alcologia, n. 48 (2022) – on line, pp. 89-96
L’articolo discute il significato del consumo di alcol nella nostra cultura, in particolare da parte dei giovani e come rito di passaggio. Le autrici riportano le riflessioni emerse nel corso del proprio lavoro clinico con i genitori alcoldipendenti, i loro partner e i figli in collaborazione con i Servizi territoriali e ospedalieri milanesi sulle difficoltà che i preadolescenti e gli adolescenti evidenziano nei riti di passaggio con l’utilizzo delle bevande alcoliche. Alcune false informazioni (i cosiddetti “miti da sfatare”) facenti parte del patrimonio socio-culturale, unite alla scarsa conoscenza degli effetti delle bevande alcoliche che caratterizza la maggior parte delle famiglie contribuiscono ad avvicinare i giovani all’utilizzo di alcol senza i necessari strumenti di protezione. La autrici identificano tre tipologie di contesti familiari e relazionali che possono caratterizzare il percorso degli adolescenti con l‘alcol, caratterizzate dalla qualità delle risorse interiori dei ragazzi e della rete familiare.
Franca Beccaria … [et al.], Tactics of Altered Consumption: Young People’s Drinking Choices in the Italian Movida, in Italian Sociological Review, vol. 12, n. 1 (2022) – on line, 23 pp.
La vita notturna urbana è spesso raffigurata come una categoria omogenea dominata dall’industria dell’intrattenimento e caratterizzata da pratiche rischiose di consumo alcolico. Assumendo una prospettiva più critica, che riconosce l’eterogeneità degli ambienti fisici e sociali come pure i modi in cui i frequentatori notturni esercitano la loro azione per manipolare e modellare i prodotti e gli spazi definiti dall’ordine economico consumistico, l’articolo ha lo scopo di: 1) esplorare gli ambienti fisici e sociali di due quartieri di Torino (Nord Italia) caratterizzati da un’intensa vita notturna; 2) capire le tattiche giovanili riguardo al consumo alcolico. Lo studio ha adottato un approccio con metodi misti comprendenti l’osservazione non partecipante (40 ore) e interviste di persona (22). Nell’articolo sono riportati e commentati risultati della ricerca.
A cura di Stefano Bertoletti … [et al.], Nightlife and the city 2021. Covid divertimento notturno e spazi urbani, CAT, Firenze, 2021, 12 pp.
La ricerca presentata ha l’obiettivo di restituire l’atteggiamento dei cittadini toscani verso l’epidemia di COVID-19, l’adesione o meno alle norme di comportamento prescritte per frenare il diffondersi del virus, lo stato della loro socialità nei due periodi di lockdown, i loro consumi di alcol e sostanze psicotrope (cannabis, cannabinoidi e psicofarmaci) . Inoltre, sono state raccolte indicazioni sulle percezioni del futuro dei cittadini intervistati e le nuove soluzioni che essi ritengono adeguate per rilanciare la socialità in sicurezza nei contesti del divertimento serale e notturno. Un campione di 1316 questionari online sono stati raccolti tra marzo e aprile 2021. Ne emerge che la maggioranza dei cittadini toscani ha mantenuto comportamenti responsabili e rispettosi delle norme di salute pubblica, senza consumi eccessivi di sostanze e di alcolici, esprimendo un giudizio di sostanziale adesione a quanto dettato dai governi nazionale e locale. Gli autori ritengono tale quadro utile agli amministratori dei diversi territori regionali.
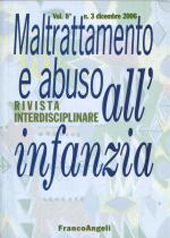 Francesca Liga … [et al.], Adolescenza e tendenza alle abbuffate di alcol: il controllo psicologico come antecedente dei comportamenti a rischio, in Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 23, n. 3 (nov. 2021), pp. 93-113
Francesca Liga … [et al.], Adolescenza e tendenza alle abbuffate di alcol: il controllo psicologico come antecedente dei comportamenti a rischio, in Maltrattamento e abuso all’infanzia, vol. 23, n. 3 (nov. 2021), pp. 93-113
Recenti studi hanno dimostrato come la tendenza alle abbuffate di alcol rappresenti un fattore di rischio per la salute dell’adolescente. L’obiettivo dello studio è quello di indagare la relazione tra alcune pratiche genitoriali, come il controllo psicologico e il supporto all’autonomia, e la tendenza alle abbuffate di alcol. 568 partecipanti hanno compilato alcuni self report relativi all’uso di alcol e alle percezione delle pratiche genitoriali. L’articolo riporta i risultati dell’indagine.
Joshua Gowin, … [et al.], Characteristics Associated With High-Intensity Binge Drinking in Alcohol Use Disorder, in Frontiers in Psychology, vol. 12, art. 750395 (2021) – on line, pp. 1-11
Il binge drinking ad alta intensità, definito come il consumo di 2-3 volte superiore al livello di un binge (4 o 5 drink per donne o uomini), aumenta i rischi di sovradosaggio e cancro correlato all’alcol rispetto a livelli più bassi di consumo alcolico. Questo studio ha esaminato la relazione tra il binge drinking ad alta intensità e tre fattori ipotizzati per contribuire al disturbo da consumo di alcol (AUD): salienza degli incentivi, emotività negativa e funzione esecutiva. Sono stati esaminati 429 adulti con AUD e 413 adulti di controllo. Il consumo di alcol è stato valutato utilizzando un’ intervista di followback a distanza di 90 giorni. I risultati suggeriscono che la rilevanza dell’incentivo può contribuire al binge drinking ad alta intensità sia nel gruppo di controllo che negli individui con AUD. L’emotività negativa era associata solo al binge drinking ad alta intensità negli individui con diagnosi di AUD, suggerendo che potrebbe esserne una conseguenza – piuttosto che una causa – del binge drinking ad alta intensità.
Carla Collicelli … [et al.], Aggregazioni giovanili e forme della movida a Milano: città sostenibile, quartieri e decentramento, ITB CNR, Osservatorio Permanente sui Giovani e l’Alcol, [Roma], 2021, 76 p.
Questo studio esplora tre cosiddette movide milanesi, tra le più frequentate e situate in aree centrali della città (Navigli, Colonne di San Lorenzo e Isola), attraverso una combinazione di approcci basati sull’analisi sia quantitativa che qualitativa. Nel primo caso, attraverso la somministrazione di un questionario ad hoc, viene esplorato il vissuto soggettivo dei frequentatori delle movide e il loro rapporto con i comportamenti e i consumi. Nel secondo caso, attraverso interviste qualitative, una serie di testimoni selezionati sono invitati a esprimersi sul fenomeno studiato e soprattutto sulle rispettive competenze e prospettive, nonché sulle opportunità e criticità del fenomeno in relazione alla vita cittadina e alle politiche per la città. Il cuore del lavoro attiene al rapporto tra condizione giovanile, offerta di tempo libero e consumi, e organizzazione della socialità nell’ambito di una delle realtà urbane più popolose, dense ed economicamente e culturalmente più avanzate del Paese. Ne emergono alcune criticità che possono contribuire a fornire indicazioni di tipo propositivo e progettuale utili per gli interventi futuri sul settore.
 Icro Maremmani … [et al.], Adolescenza e uso di sostanze: disturbi duali, scuola e famiglia, in MDD : Medicina delle Dipendenze, a. 11, n. 43 (set. 2021), pp. 1-55
Icro Maremmani … [et al.], Adolescenza e uso di sostanze: disturbi duali, scuola e famiglia, in MDD : Medicina delle Dipendenze, a. 11, n. 43 (set. 2021), pp. 1-55
L’approccio medico al paziente con disturbo duale (DD) è indubbiamente delicato a causa del contesto culturale in cui i pazienti si trovano inseriti e che coinvolge due componenti, quella psichiatrica e quella dell’addiction, che non posso essere separate. Alcuni dei contributi proposti nella rivista sono: “Dichiarazione congiunta sui disturbi duali: l’addiction e le altre malattie mentali” di Néstor Szerman [et al.]; “ll disturbo duale negli adolescenti: considerazioni diagnostiche e implicazioni cliniche” di Yifrah Kaminer;”“Una scuola per la vita”. Monitoraggio di un intervento di prevenzione multidisciplinare in quattro scuole napoletane” di Fabio Curcio … [et al.]; ” Associazione tra esperienze avverse infantili e comportamenti rischiosi per la salute come il fumo, l’uso di alcol e l’abuso di sostanze nell’adolescenza” di Marija Raleva, Liljana Ignjatova.
Tiziana Cassese, Cristina Mosso, Se le donne musulmane bevono birra, in Animazione Sociale, n. 4/345 (2021), pp. 62-65
L’Associazione Aliseo di Torino, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino, ha svolto nel 2019 un’indagine fra 72 associazioni che si occupano di migranti sull’abuso di alcol da parte della popolazione giovane migrante. Molte risposte indirizzavano all’aspetto socializzante e conformante rispetto al gruppo dei pari, cosa per nulla diversa rispetto alla popolazione giovanile italiana. L’indagine è stata replicata nell’autunno del 2020, confermando che l’uso di alcol è aumentato nel periodo pandemico e giustificato dagli utenti per la disperazione nel futuro. I dati raccolti sono utili per ripensare le risposte dei servizi dedicati.
Michele Contel … [et al.], Investigating Drinking Profiles among Italian High School Students (14-19 y.o.): a Latent Class Analysis, in Salute e società, a.19, n. 3 (2020), pp. 133-148
Il consumo di alcool tra i minori in Italia è un fenomeno diffuso e spesso associato ad un danno correlato relativamente basso. Il presente studio indaga come i consumatori differiscono dai non bevitori e come il consumo di alcol da parte dei minori si trasformi in un consumo occasionale o eccessivo in dipendenza di vari fattori contestuali, come famiglia, amici, età e iniziazione all’acool, abitudini, altro uso di sostanze e regole riguardanti il bere. Un campione di 9564 giovani tra i 14 e i 19 anni sono stati intervistati nel 2017 e 2018. I non bevitori e i bevitori da un anno sono stati analizzati secondo il metodo della regressione logistica per verificare il ruolo delle covariate sociali e demografiche. Ai bevitori da un anno è stato adattato un modello di regressione a classi latenti, usando di nuovo le covariate per indagare la probabilità per un individuo di essere assegnato a una classe. Nel testo proposto sono riportati e commentati i risultati dell’indagine.
Tiziana Cassese, Rosalba Rosato, Cristina Mosso, Consumo alcolico e aspettative. Un’ analisi esplorativa tra le determinanti motivazionali in un campione di giovani adulti, in Dal fare al dire, a. 30, n. 1 (2021), pp. 33-42
Il presente contributo esplora, attraverso un approccio psicosociale, la relazione tra le credenze e il consumo di alcol abituale, moderato e smodato in un campione di giovani adulti. Per comprendere le implicazioni psicologiche che sottendono alle modalità di consumo alcolico è stato somministrato on-line a 452 giovani italiani un questionario che consente di individuare profili diversi in relazione a tre tipi di approccio: indulgente; forte avvicinamento (ossessionato); evitamento. Vengono esposti e discussi i risultati della ricerca che, pur non essendo generalizzabili, indicano che il consumo di alcol riflette in forme diverse una ricerca di socialità e che le azioni preventive debbano diversificarsi non solo per target d’età, ma anche per genere.
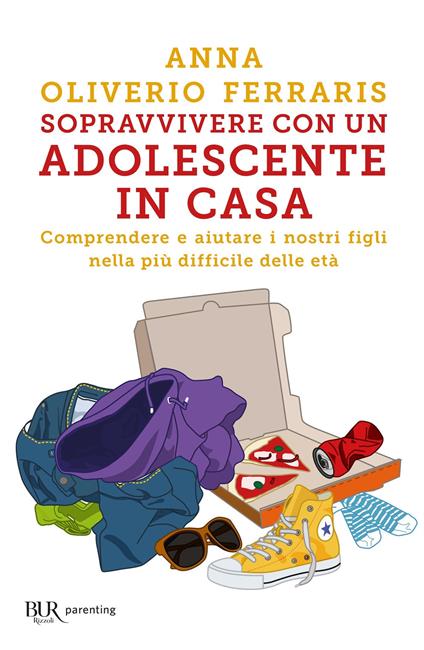 Anna Olivero Ferraris, Sopravvivere con un adolescente in casa. Comprendere e aiutare i nostri figli nella più difficile delle età, 2. ed., Rizzoli, Milano, 2021, 183 p.
Anna Olivero Ferraris, Sopravvivere con un adolescente in casa. Comprendere e aiutare i nostri figli nella più difficile delle età, 2. ed., Rizzoli, Milano, 2021, 183 p.
Il contesto in cui crescono gli adolescenti di oggi è molto diverso da quello delle generazioni precedenti, e per questo non è semplice capire come sentono, pensano e reagiscono i nostri figli nel momento forse più difficile della loro crescita, di fronte a stimoli e cambiamenti interni ed esterni che spesso agli adulti suonano incomprensibili. L’autrice, psicologa e psicoterapeuta, fornisce un quadro dei punti salienti che riguardano il passaggio all’età adulta e illustra le dinamiche adulti-ragazzi. Il corpo e la sessualità, la violenza e l’autorità, le droghe, il mondo virtuale e quello reale, la comunicazione e la trasmissione del sapere: il libro affronta le questioni centrali che coinvolgono gli adolescenti cercando di fornire istruzioni ai genitori che si trovano a gestire un rapporto quasi mai facile.
Collocazione Biblioteca: 19083
Ina Koning, Margaretha de Looze, Zeena Harakeh, Parental alcohol-specific rules effectively reduce adolescents’ tobacco and cannabis use. A longitudinal study, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 216, art. 108226 (nov. 2020) – on line, pp. 1-6
Questo studio longitudinale su 906 adolescenti olandesi (età media 13 anni) si è proposto di esaminare longitudinalmente gli effetti diretti e indiretti (attraverso il consumo di alcol) il modo in cui la definizione di regole specifiche per l’alcol da parte dei genitori influisce sul consumo di tabacco e cannabis degli adolescenti. Sulla base dell’ipotesi di “gateway” ci si aspettava che le regole dei genitori specifiche per l’alcol influissero anche sul consumo di tabacco e cannabis degli adolescenti. Attraverso questionari di auto-segnalazione sono state misurate in tre tempi diversi le regole percepite dagli adolescenti sul consumo di alcol, il consumo di sigarette, l’ uso di cannabis e la frequenza mensile del consumo di alcol. Lo studio attuale ha dimostrato che regole severe sul consumo alcolico possono non solo ridurre l’alcol, ma successivamente anche il consumo di altre sostanze quali tabacco e cannabis. Pertanto interventi mirati alla prevenzione del consumo alcolico, che sembra servire come ”gateway”, influenzano anche il coinvolgimento con altre sostanze.
A cura di Silvia Biagioni, Sabrina Molinaro, ESPAD #iorestoacasa 2020. I comportamenti a rischio durante il primo lockdown tra gli studenti dai 15 ai 19 anni, CNR, Pisa, 2021, 178 p.
Questo report contiene informazioni sull’esperienza e sulla percezione degli studenti 15-19enni italiani in relazione a una varietà di sostanze e consumi, come tabacco, alcol, droghe, prodotti farmaceutici, nuove sostanze psicoattive, ma anche social media, challenge, gaming e gioco d’azzardo, raccolte durante il periodo di isolamento in seguito alle misure restrittive imposte dal governo per fronteggiare l’emergenza pandemica.
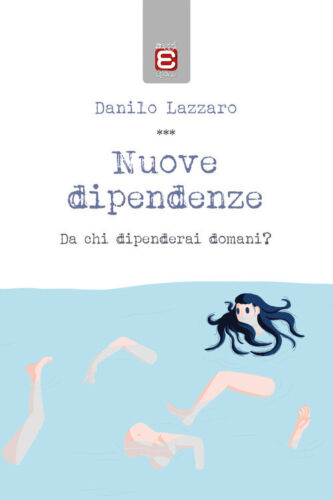 Danilo Lazzaro, Nuove dipendenze. Da chi dipenderai domani?, Epoké, Novi Ligure, 2020, 228 pp.
Danilo Lazzaro, Nuove dipendenze. Da chi dipenderai domani?, Epoké, Novi Ligure, 2020, 228 pp.
Binge drinking, drunkoressia, hikikomori, incel. Sono alcuni dei termini che compongono il vocabolario delle nuove dipendenze, quelle che spesso non hanno bisogno di sostanze e non ci restituiscono l’immagine stereotipata del tossico. Si nutrono di atteggiamenti, di dita che scrollano su bacheche virtuali. L’autore, docente e ricercatore all’Istituto di Scienze Forensi di Milano, ne descrive origini e rischi avvalendosi del contributo di esperti nei settori coinvolti
Collocazione Biblioteca: 19053
Claudia Gandin … [et al.], Alcol, giovani e sport: le attività nazionali del Progetto europeo FYFA “Focus on Youth Football and Alcohol, in Alcologia, n. 41 (2020) – online, pp. 27-42
FYFA – Focus on Youth Football and Alcohol – è un progetto europeo, tuttora in corso che coinvolge istituti di ricerca di sei paesi europei, inclusa l’Italia ed ha, tra gli scopi, quello di utilizzare i contesti di aggregazione sportiva per veicolare iniziative e sollecitare l’adozione di politiche atte a prevenire i danni alcol-correlati nei giovani. L’Istituto Superiore di Sanità ha coordinato le attività del Work Package 5 “Revisione delle politiche e delle pratiche nazionali in sei Stati Membri relative all’alcol, ai giovani, allo sport e al marketing” finalizzate ad individuare lo status quo delle politiche e delle pratiche per ridurre il consumo di alcol ed il consumo episodico eccessivo nei giovani nei contesti sportivi a livello nazionale anche attraverso l’opinione di esperti del settore.
L’alcol, le donne, la gravidanza
Giovanni Addolorato … [et al.], Newsletter “Clinica dell’Alcolismo”, in Mission, a. 16, n. 59 (feb. 2023) – on line, pp. 25-32
Nella newsletter di questo numero si segnala in particolare l’articolo di Julien Guiraud … [et al.]; “Un programma intensivo e breve rivolto alle donne con disturbo da uso di alcol (DUA): un’esperienza di integrazione residenziale-ambulatoriale e pubblico-privato sociale a Firenze” di Laura Calviani … [et al.]. A tal proposito si consulti anche, degli stessi autori e nella medesima testata l’articolo: Un programma intensivo e breve rivolto alle donne con Disturbo da Uso di Alcol (DUA): un’esperienza di integrazione residenziale-ambulatoriale e pubblico-privato sociale a Firenze, n. 48 (2022) – on line, pp. 44-53
Elis Haan … [et al.], Prenatal smoking, alcohol and caffeine exposure and offspring externalizing disorders. A systematic review and meta-analysis, in Addiction, vol. 117, n. 10 (ott. 2022) – on line, pp. 2602-2613
Svariati studi hanno indicato un’associazione fra il consumo materno prenatale di sostanze (alcol, tabacco e caffeina) e i disturbi esternalizzanti della prole (Disturbo dell’attenzione, disturbi dello spettro autistico e altri); tuttavia non è certo che questa relazione sia causale. Questa revisione sistematica intendeva stabilire: (1) se la letteratura appoggia il ruolo causale del consumo prenatale materno di sostanze riguardo a una diagnosi di disturbi esternalizzanti della prole e (2) se queste associazioni differiscono fra i disturbi esternalizzanti. Non sembrano esserci prove chiare a sostegno di una relazione causale fra il fumo materno prenatale e il disturbo di iperattività e deficit di attenzione nella prole (ADHD). I risultati con le esposizioni ad alcol e caffeina, il disturbo di condotta e il disturbo oppositivo provocatorio necessitano di ulteriori ricerche, usando progettazioni più sensibili alle questioni genetiche. Una ricerca analoga, ma centrata sull’ ADHD (disturbo da Deficit di attenzione e iperattività, si trova nell’articolo di Elis Haan … [et al.], Prenatal smoking, alcohol and caffeine exposure and maternal-reported attention deficit hyperactivity disorder symptoms in childhood. Triangulation of evidence using negative control and polygenic risk score analyses, vol. 117, n. 5 (mag. 2022) – on line, pp. 1458-1471
Ruth McGovern… [et al.], The Effectiveness of psychosocial interventions at reducing the frequency of alcohol and drug use in parents, Findings of a Cochrane Review and meta-analyses, in Addiction, vol. 117, n. 10 (ott. 2022) – on line, pp. 2571-2582
Il consumo di sostanze da parte dei genitori è una preoccupazione importante per la salute e la salvaguardia pubbliche. Vi sono stati diversi studi che hanno esaminato interventi mirati a questo fattore di rischio. In questo studio si è voluto stimare l’efficacia di interventi psicosociali nel ridurre il consumo di sostanze da parte dei genitori (di figli sotto i 21 anni). La ricerca ha rilevato che gli interventi mirati solo all’uso di sostanze o alle capacità genitoriali non sono stati efficaci nel ridurre la frequenza del consumo di alcol o droghe. Gli interventi psicosociali, pertanto, dovrebbero mirare sia alla genitorialità che al consumo di sostanze in un intervento integrato.
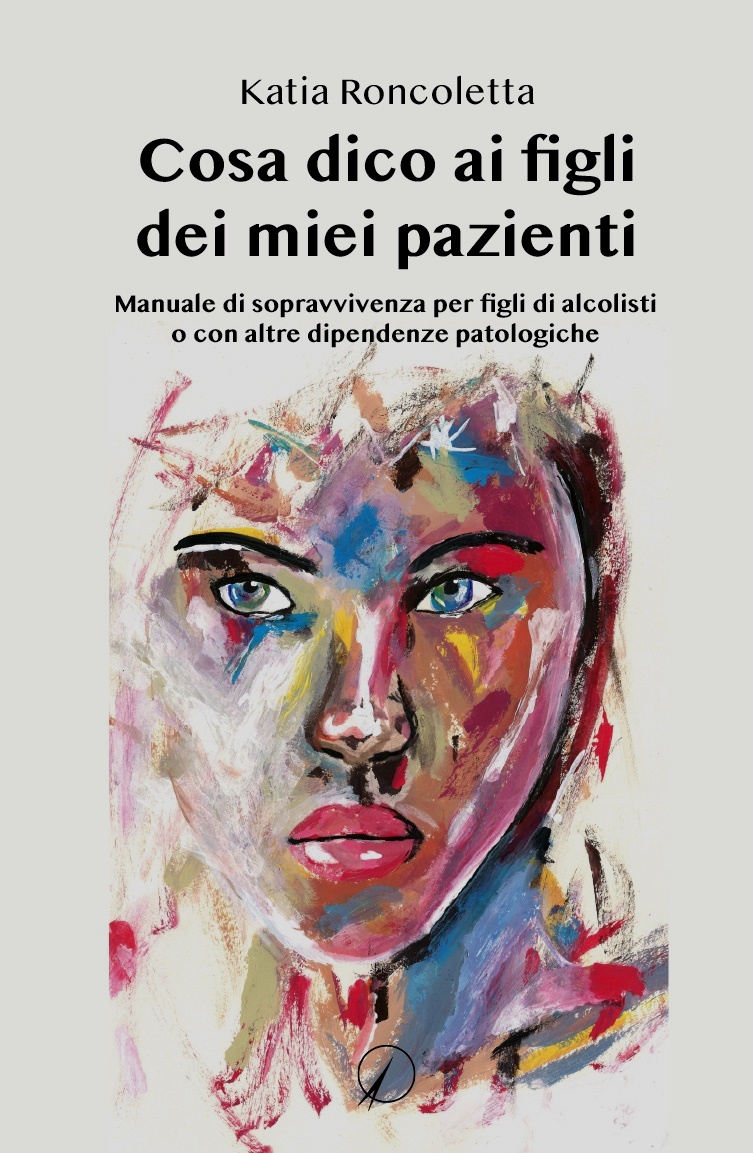 Katia Roncoletta, Cosa dico ai figli dei miei pazienti, Altromondo, Caldogno (VI), 2022, 117 pp.
Katia Roncoletta, Cosa dico ai figli dei miei pazienti, Altromondo, Caldogno (VI), 2022, 117 pp.
I media parlano spesso dei giovani affetti da dipendenze e dei loro genitori disperati che non sanno come aiutarli. In questo libro, all’opposto, si mette l’accento sui giovani figli di alcolisti e tossicodipendenti, che devono affrontare quotidianamente serie problematiche in famiglia a causa delle dipendenze degli adulti. Manuale di sopravvivenza che nasce dall’esperienza ventennale di una psicologa clinica ed è frutto della collaborazione di tanti giovani figli che hanno avuto il coraggio di parlare, raccontare le loro emozioni, la paure e i fatti vissuti. La responsabilità di questi ragazzi non è verso i genitori, ma è verso se stessi e i figli che verranno. Occorre spezzare la catena della dipendenza che spesso si tramanda di generazione in generazione, facendo cosi una vera prevenzione verso la futura discendenza.
In arrivo in Biblioteca
Sarah C. M. Roberts, Claudia Zaugg, Noelle Martinez, Health care provider decision-making around prenatal substance use reporting, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 237, (ago. 2022) – on line, pp. 1-13
Recenti ricerche hanno rilevato che i danni collegati al consumo di alcol e/o droga durante la gravidanza non sono limitati a quelli associati all’uso stesso; i danni risultano anche dalle politiche e dalle pratiche di assistenza sanitaria adottate in risposta, fra cui la segnalazione ai Servizi di tutela minorile (CPS). Questo studio ha cercato di comprendere i fattori che influenzano le pratiche di segnalazione degli operatori sanitari. I ricercatori hanno effettuato 37 interviste semi-strutturate con ostetrici/ginecologi ospedalieri, medici di famiglia e medici del pronto soccorso, focalizzate su esperienze di segnalazione di donne in gravidanza/parto con AOD alle autorità governative. Nell’articolo sono riportati e commentati i risultati dell’indagine.
Paolo Berretta … [et al.], Sindrome feto alcolica: una disabilità permanente e trasparente, poco conosciuta in Italia, in Alcologia, n. 48 (2022) – on line, pp. 25-34
L’articolo raccoglie alcuni dati sullo spettro dei Disordini Feto Alcolici (FASD) e la sindrome Feto Alcolica (FAS), che ne è l’estremo più grave, una serie di condizioni malformative che possono condurre a un ritardo mentale nei neonati e nei bambini esposti all’alcol durante la gestazione o l’allattamento. Spesso questi disturbi non vengono riconosciuti nei bambini e negli adolescenti colpiti, che ricevono altre diagnosi, come la sindrome di iperattività e deficit dell’attenzione, l’autismo, il disturbo da attaccamento o i disturbi della condotta, a causa della poca esperienza diagnostica in Italia su FASD e FAS. Gli autori ribadiscono la centralità della prevenzione, aumentando la consapevolezza del rischio connesso con il consumo delle bevande alcoliche nella popolazione in generale e, in particolare, tra le donne in età fertile.
Ginetta Fusi … [et al.], Madri e spose di alcolisti: amorevoli carceriere o avide salvatrici?, in Alcologia, n. 48 (2022) – on line, pp. 54-59
L’articolo descrive l’esperienza del Centro Alcologico UFS SERD C Firenze, che ha adottato un programma strutturato parallelo per la presa in carico dei familiari delle persone dipendenti dall’alcol. La presa in carico prevede l’accoglienza, l’ascolto, la valutazione di possibili comportamenti alternativi e l’eventuale invio ad approfondimenti specialistici. Lo scopo è svelare i bisogni o le emozioni individuali che vengono soppressi o soffocati dalla cura dell’alcolista. In particolare, l’articolo si focalizza su un’esperienza gruppale effettuata nel 2021, dove le sessioni erano polarizzate su storie tratte dalla letteratura contemporanea o mitologica. Per le donne familiari, riconoscersi nelle esperienze altrui ha rappresentato il primo passo per portare un cambiamento nella propria vita.
Joan S. Tucker … [et al.], Trajectories of alcohol use and problems during the COVID-19 pandemic: The role of social stressors and drinking motives for men and women, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 232, art. 109285 (mar. 2022) – on line, pp. 1-6
É stato documentato tra gli adulti statunitensi un aumento del consumo di alcol in coincidenza con l’inizio della pandemia di COVID-19, in particolare tra le donne. Questo studio esamina le tendenze del consumo di alcol e dei problemi alcolici in un periodo di 9 mesi durante la pandemia, la misura in cui queste tendenze sono causate dallo stress sociale e dalle motivazioni del bere e se i risultati differiscono tra donne e uomini. I dati analizzati provengono da tre sondaggi online su un campione rappresentativo a livello nazionale di adulti statunitensi di età compresa tra i 30 e gli 80 anni, condotti a maggio-luglio 2020, ottobre-novembre 2020 e marzo 2021. Il campione analitico è composto da 1118 persone che inizialmente hanno dichiarato di aver fatto uso di alcol nell’ultimo anno. Nell’articolo sono riportati e commentati i risultati dell’indagine.
 Istituto Superiore di sanità, Consumo di alcol in gravidanza: uno studio ISS, ISS, Roma, 2022, 2 p.
Istituto Superiore di sanità, Consumo di alcol in gravidanza: uno studio ISS, ISS, Roma, 2022, 2 p.
Il documento riassume i dati di uno studio che ha coinvolto madri e neonati in tutto il territorio nazionale, dove è stato misurato uno dei metaboliti dell’alcol etilico, l’etilglucuronide (EtG), nei capelli materni e nel meconio neonatale da coorti disgiunte di donne in gravidanza e bambini appena nati. I risultati indicano che solo lo 0,1% di donne italiane beve in modo sensibile durante la gravidanza e che una piccola percentuale di neonati, lo 0,6 %, è esposta all’alcol prenatale. Secondo gli autori, le politiche sulla salute hanno accresciuto nelle donne italiane la consapevolezza dei rischi associati al consumo di alcol durante la gravidanza.
Corina Giacomello, Children whose parents use drugs. Promising practices and recommendations, Council of Europe, Strasburgo, 2022, 96 pp.
Il documento affronta il tema delle famiglie dove i genitori fanno uso di sostanze o alcool in modo problematico e dei servizi di supporto al riguardo. Descrive un insieme di interventi presenti in diversi paesi e mirati alle famiglie e ai figli: servizi per le madri che usano sostanze; servizi per il trattamento della dipendenza che tengono conto delle responsabilità parentali, dei bisogni dei figli e di situazioni particolari; rifugi per donne vittime di violenza che usano sostanze. Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuovere la democrazia, i diritti umani, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali nei Paesi in Europa. A questo link inoltre si trovano altri documenti sull’argomento.
Anna Paola Lacatena, Il misterioso (e spesso vincente) caso di alcolisti anonimi e le donne, in Nuova alcologia, n. 44 (2021) – on line, pp. 52-64
Dagli ultimi dati ufficiali relativi alla popolazione in cura presso i Servizi per le Tossicodipendenze emerge che la percentuale di donne non supera il 14% dell’intera popolazione in carico. Questo non deve portare a credere che il consumo al femminile sia inferiore a quello maschile, anzi per quanto riguarda l’alcol e per diverse fasce d’età il gap va sempre più assottigliandosi. Analizzando i dati relativi alla presenza delle donne nei gruppi di Alcolisti Anonimi (A.A.) in Italia, la percentuale sale ad oltre il 30%. Questo contributo partendo dalle caratteristiche proprie di A.A. prova, fuori da ogni possibile esaustività, a formulare delle ipotesi soprattutto nell’ambito socio-culturale.
Luigi Filippo Bardell, Graziano Feliziani, Rosanna Ceglie, Donne migranti nella S.S.D. Ser.T. Asl5 spezzino. Alcuni aspetti epidemiologici, in Dal fare al dire, a. 30 n. 3 (2021), pp. 26-32
Il presente lavoro prende spunto dai dati della Relazione Annuale al Parlamento sullo stato delle Tossicodipendenza in Italia per approfondire alcuni aspetti epidemiologici dell’utenza del servizio negli ultimi dieci anni. Un’analisi più dettagliata viene effettuata su alcune variabili; in particolare viene evidenziata la presenza della percentuale di utenza di sesso femminile nel corso degli anni, sia in rapporto al totale dei pazienti in carico, sia in relazione ad alcune diagnosi (Disturbo da Uso di Alcol, Disturbo da Gioco d’Azzardo, Disturbo da Uso di Tabacco). Vengono inoltre presentati i dati sulla utenza straniera afferente al servizio in rapporto al sesso e alla nazionalità. I risultati sono commentati alla luce della letteratura recente, in particolare rispetto alla comorbilità tra diagnosi tossicologica e correlati psicopatologici. Questo monitoraggio permette di monitorare l’andamento di questi aspetti e dà quindi modo ai servizi di migliorare la comprensione di alcuni aspetti e prospettare soluzioni più mirate alle esigenze di particolari categorie di utenti.
 Adriane Wynn … [et al.], Identifying fetal alcohol spectrum disorder among South African children at aged 1 and 5 years, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 217, art. 108266 (dic. 2020) – on line, pp. 1-6
Adriane Wynn … [et al.], Identifying fetal alcohol spectrum disorder among South African children at aged 1 and 5 years, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 217, art. 108266 (dic. 2020) – on line, pp. 1-6
I disturbi dello spettro alcolico fetale (Fetal Alcohol Spectrum Disorders =FASD) sono una preoccupazione sanitaria globale. L’intervento precoce allevia i deficit, tuttavia una diagnosi tempestiva rimane difficile. Si è indagato se se i bambini possano essere sottoposti a screening e avere diagnosi di FASD a un anno e mezzo rispetto ai 5 anni dopo la nascita. E’ stata reclutata una coorte di popolazione di donne in gravidanza in 24 quartieri (n=1258) e 84,5% – 96% sono state valutate nuovamente a due settimane dopo la nascita , e a 6 mesi, 1 anno e mezzo, tre anni e cinque anni più tardi. Sono stati valutati i sintomi FASD a un anno e mezzo, rispetto ai 5 anni. Sono state esaminate anche le differenze materne nei bambini che hanno ricevuto uno screening FASD positivo ( n= 160) rispetto a quelli che ne hanno ricevuto uno negativo. Lo studio ha scoperto che i bambini possono essere sottoposti a screening e ricevere una diagnosi per FASD a un anno e mezzo e cinque anni. Poiché le caratteristiche FASD si sviluppano nel tempo, sono necessari screening ripetuti per individuare tutti i bambini affetti e lanciare interventi preventivi. I rinvii dei bambini a una visita medica di conferma della diagnosi e il collegamento dei bambini alle cure rimangono una sfida. L’integrazione con il sistema sanitario primario potrebbe alleviare alcune di queste difficoltà.
Anna Paola Lacatena, Donne e tossicodipendenza. Quando la patologia è di altro genere… , in Mission, n. 53 (apr. 2020), pp. 26-32
Dai dati della Relazione annuale sull’evoluzione del fenomeno della droga nell’Unione europea, pubblicata nel 2018 dall’OEDT (Agenzia europea sulle droghe di Lisbona),emerge che le donne sono soltanto il 20% dei pazienti che si sottopongono a un trattamento della tossicodipendenza. Le possibili ragioni sono varie, a partire da problemi di accessibilità ai servizi e di adeguatezza degli stessi. Per approfondire, il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Taranto ha prodotto due ricerche sulle pazienti donne in carico, di cui qui si presentano modalità e risultati.
Danya Mazen Qato … [et. al], Co-use of alcohol, tobacco, and licit and illicit controlled substances among pregnant and non-pregnant women in the United States. Findings from 2006 to 2014 National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) data, in Drug and alchool dependence, vol. 206, art. 107729 (gen. 2020) – on line, pp. 1-7
Il consumo, l’abuso e l’uso concomitante di alcol, cannabis, tabacco e altre sostanze controllate lecite e illecite è aumentato negli ultimi decenni negli USA, portando a tassi superiori di morbilità, overdose e mortalità nelle donne in età riproduttiva. Il policonsumo moltiplica gli effetti nocivi per la salute rispetto all’uso singolo di sostanze simili. Poco si sa sulla gamma completa di combinazioni di sostanze usate dalle donne in gravidanza e non in gravidanza. L’articolo descrive i modelli di uso concomitante di alcol, tabacco e sostanze controllate, La ricerca ha documentato che l’uso concomitante di diverse sostanze, in particolare tabacco, alcol e cannabis, persiste nelle donne in gravidanza negli Stati Uniti. Gli sforzi volti a migliorare la salute materna e del bambino dovrebbero affrontare la complessità del consumo di sostanze durante la gravidanza, compresi gli oppiacei e le altre sostanze stupefacenti.
Alcol e anziani
Wossenseged Birhane Jemberie … [et al.], Recurrent risk of hospitalization among older people with problematic alcohol use. A multiple failure-time analysis with a discontinuous risk model, in Addiction, vol. 117, n. 9 (sett. 2022) – on line, pp. 2415-2430
Le persone anziane con un consumo alcolico problematico variano rispetto al funzionamento sociale, all’ età di insorgenza del consumo problematico e all’uso di altre droghe. Lo studio, che si è svolto in Svezia tra marzo 2003 e novembre 2017, ha misurato i rischi differenziali dei ripetuti ricoveri ospedalieri per qualsiasi causa, per policonsumo e malattie psichiatriche nelle persone anziane (sopra i 50 anni) con consumo alcolico problematico. Dai risultati della ricerca si evince che gli utenti più anziani dei servizi per le dipendenze in Svezia hanno svariati rischi di ricoveri ospedalieri a causa del consumo di alcol, del policonsumo e dei disturbi psichiatrici. Le persone più anziane con consumo alcolico problematico che hanno molteplici esigenze e sono valutate nei servizi sociali possono trarre beneficio da interventi più precoci, purché si concentrino in maniera integrata sul consumo di sostanze e sulla salute mentale.
 Rosario Ortolà … [et al.], Alcohol consumption patterns and unhealthy aging among older lifetime drinkers from Spain, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 235, art. 109444 (giu. 2022) – on line, pp. 1-9
Rosario Ortolà … [et al.], Alcohol consumption patterns and unhealthy aging among older lifetime drinkers from Spain, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 235, art. 109444 (giu. 2022) – on line, pp. 1-9
Gli effetti protettivi sulla salute del consumo di alcolici leggeri sono oggetto di discussione a causa di potenziali bias di selezione, causalità inversa e confondimento. I ricercatori hanno confrontato le associazioni trasversali e prospettiche dei modelli di consumo di alcol con l’invecchiamento non sano tra i bevitori anziani, affrontando alcuni problemi metodologici. 2081 bevitori di età superiore ai 65 anni della coorte Seniors-ENRICA-2, seguiti per 2-4 anni, sono stati classificati come bevitori occasionali, a basso rischio, a rischio moderato e ad alto rischi. Non sono state trovate prove di un’associazione tra il consumo di alcol a basso rischio e invecchiamento sano, ma al contrario, l’uso ad alto rischio era correlato con uno stato di salute peggiore. Nell’articolo sono riportati e commentati i risultati dell’indagine.
Sara Wallhed Finn … [et al.], Pharmacotherapy for alcohol use disorders – Unequal provision across sociodemographic factors and co-morbid conditions, A chort study of the total population in Sweden, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 227, art. 108964 (ott. 2021) – on line, pp. 1-7
La terapia farmacologica per i disturbi causati dal consumo di alcol (AUD) è efficace. Tuttavia le conoscenze circa la sua utilizzazione e le caratteristiche dei pazienti associate alle prescrizioni sono scarse. Lo scopo di questa ricerca era indagare le prescrizioni di terapia farmacologica per l’AUD in Svezia nel tempo, le condizioni sociodemografiche, di domicilio e di comorbilità. Questo è uno studio nazionale di coorte comprendente 132.733 pazienti adulti con diagnosi di AUD (disturbo da consumo di alcol) fra il 2007 e il 2015. Le variabili dell’esposizione erano età, sesso, reddito, scolarizzazione, costellazione familiare, domicilio, origine, diagnosi di concomitante comorbilità psichiatrica e somatica. I risultati indicano che la terapia farmacologica per AUD è sottoutilizzata. La proporzione di soggetti con una prescrizione non è cambiata fra il 2007 e il 2015. L’erogazione del trattamento è diseguale nei diversi gruppi della società, dove specialmente l’età più anziana, il reddito e la scolarizzazione inferiori, e la diagnosi di comorbilità somatica sono associati a probabilità minori di prescrizione. Esiste la necessità di incrementare questo tipo di trattamento, in particolare per soggetti con situazioni di co-morbilità somatica.
Silke Behrendt … [et al.], Distinct health-related risk profiles among middle-aged and older adults with risky alcohol use from the Danish general population, in Drug and Alcohol Dependence, vol. 226, art. 108872 (set. 2021) – on line, pp. 1-9
Mancano conoscenze sui distinti profili di rischio per la salute nel gruppo sostanziale di adulti di mezza età e più anziani (tra i 55 e i 74 anni) con un consumo rischioso di alcol (AU). Tali profili potrebbero informare la pianificazione di interventi e prevenzione. Le finalità di questo studio erano:1) identificare distinti profili sanitari in base ai diversi tipi di disagio e limitazioni al funzionamento della salute e 2) valutare le associazioni fra questi profili e l’età, il sesso, e comportamenti rilevanti per la salute (es. il fumo). La ricerca mette in evidenza che gli adulti di mezza età e più anziani con consumo alcolico a rischio hanno profili sanitari distinti. Questo è importante per progettare forma e contenuto della prevenzione e degli interventi. Nonostante le loro distinte caratteristiche, quasi tutti i profili sanitari problematici (malattia mentale, dolore, stanchezza, disagio …) autorizzano una puntuale attenzione verso il consumo alcolico ad alto rischio e il probabile disturbo da consumo alcolico.
Antonio Andrea Sarassi, Maria Raffaella Rossin, L’alcolista anziano: un problema nascosto, in Alcologia, n. 39 (2020) – online, pp. 31-47
L’assunzione di sostanze alcoliche nella persona anziana è oggetto di scarsa attenzione da parte dei media e dei sanitari in tutti gli ambiti di cura. L’alcolismo negli anziani, “il problema nascosto”, in Italia si riscontra molto di frequente nei pazienti che si presentano in Pronto Soccorso. Gli alcolisti anziani si suddividono in early-onset drinkers, cioè alcolisti divenuti vecchi, che rappresentano la maggioranza, con un evidente peggioramento delle condizioni sanitarie, psicologiche, sociali e lavorative; in late-onset drinkers, cioè anziani divenuti alcolisti (alcolisti tardivi) e, in misura inferiore, in intermittent or binge drinkers. A ognuna di queste tipologie di bevitori è importante assegnare un percorso di trattamento specifico.
Sitografia
Alcolisti Anonimi
Associazione Aliseo
Cochrane library
Dipartimento per le politiche antidroga- Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dro.net
Epicentro – Il portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica
Epicentro – Alcool – Materiali per la comunicazione
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)
Ministero della salute – alcool e alcoldipendenza
National Institute on Drug Abuse (USA)
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism
Osservatorio nazionale alcol (ONA)
Osservatorio epidemiologico delle dipendenze – Regione Piemonte (OED)
Società Italiana di alcologia (SIA)
Substance Abuse and Mental Health Data Archive
Substance Abuse and Mental Health Services Administration
WHO European Region Alcohol use – Data and statistic
