Aspetti educativi e didattici
Si veda anche la bibliografia sulla Scuola
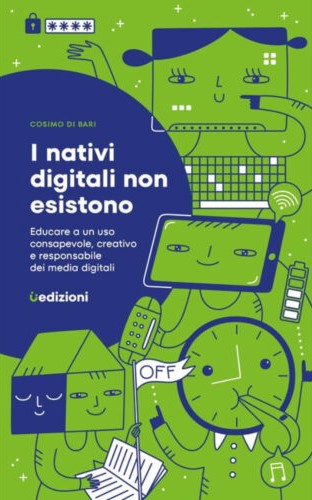 Cosimo Di Bari, I nativi digitali non esistono. Educare a un uso consapevole, creativo e responsabile dei media digitali, Uppa, Roma, 2023, 191 pp.
Cosimo Di Bari, I nativi digitali non esistono. Educare a un uso consapevole, creativo e responsabile dei media digitali, Uppa, Roma, 2023, 191 pp.
L’etichetta “nativi digitali”, coniata nel 2001, ha generato un falso mito che questo libro vuole sfatare: quello secondo cui le nuove generazioni, nate in un contesto caratterizzato dalla presenza degli schermi, sarebbero già alfabetizzate e tecnologicamente competenti. In realtà, a fare la differenza sono le modalità e le finalità con cui usiamo gli strumenti digitali. E’ indispensabile la Media Education, che offre ai genitori una possibile strada per costruire insieme ai figli una migliore consapevolezza. L’autore è ricercatore di Pedagogia generale presso l’Università di Firenze.
Collocazione Biblioteca: 18675
Mariglena Gjoni, Educare l’empatia nell’uso del digitale, in Orientamenti pedagogici, vol. 70, n. 4 (ott. – dic. 2023), pp. 73-81
Lo scopo dell’articolo è quello di analizzare il costrutto dell’empatia in correlazione all’uso del digitale. Gli individui non solo abitano lo spazio dei social network, ma attraverso il loro uso mettono in gioco se stessi e il sentimento di ciò che sono in relazione a sé, all’altro e al mondo. L’intento è mostrare un possibile percorso per educare l’empatia attraverso la promozione delle competenze digitali, tecniche e trasversali.
Angela Biscaldi … [et al.], In presenza. Il ruolo dei corpi nella relazione educativa e terapeutica, in Narrare i gruppi, vol. 18, n. speciale (giu. 2023) – on line, pp. 7-70
Il numero della rivista riporta gli interventi al seminario tenutosi a Milano il 12 dicembre 2022, organizzato dall’Università Statale di Milano. Un pomeriggio di confronto sul ruolo dei corpi (e della loro assenza) nelle relazioni educative, formative e terapeutiche – ruolo che abbiamo sempre dato per scontato e che il digitale ci chiede oggi di ripensare. È possibile apprendere (e insegnare ad apprendere), è possibile prendersi cura (ed essere curati) senza compresenza fisica? Come cambiano le relazioni, i processi di apprendimento, i ruoli e le responsabilità? Come cambia l’affettività? E ancora: che fine fanno i corpi nelle relazioni digitali?
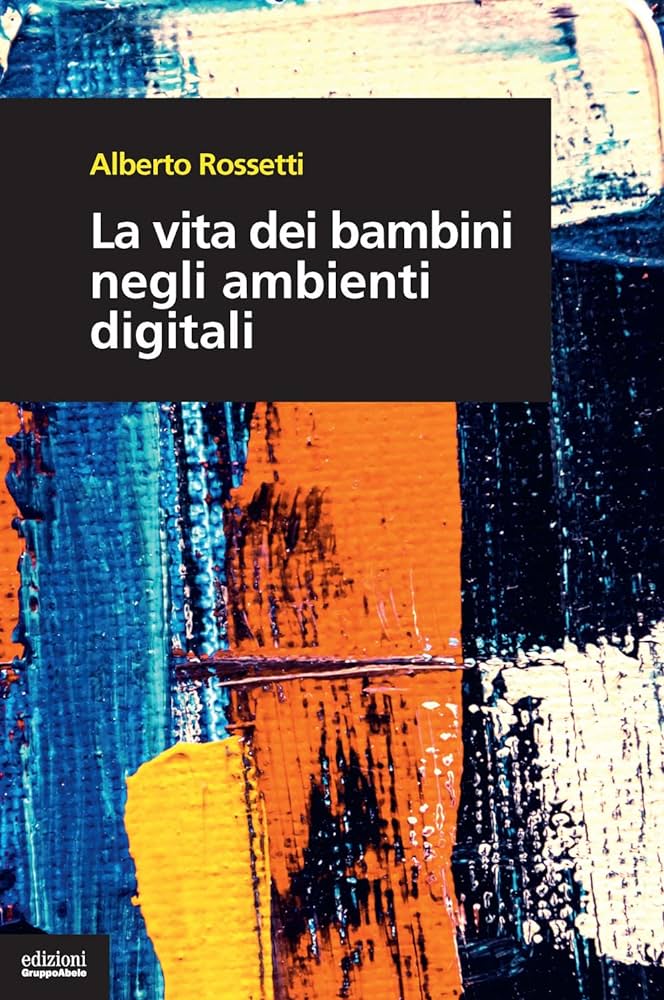 Alberto Rossetti, La vita dei bambini negli ambienti digitali, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2023, 159 pp.
Alberto Rossetti, La vita dei bambini negli ambienti digitali, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2023, 159 pp.
L’autore, psicologo e psicoterapeuta, sviluppa una riflessione sulla relazione tra bambini e dispositivi tecnologici, che non ha ragione di essere demonizzata. Le tecnologie e i dispositivi digitali fanno parte delle nostre vite e di quelle dei bambini: l’opportunità di conoscenza derivante dall’utilizzo della rete è un diritto al quale tutti i bambini e le bambine dovrebbero avere accesso. Secondo l’autore, a partire da questa premessa, occorre affrontare il tema cercando un equilibrio che superi i facili schieramenti di chi è “pro o contro” le tecnologie. Occorre indagare quali significati i più piccoli sono in grado di attribuirvi e con quali conseguenze sul mondo delle relazioni e sullo sviluppo, aiutandoli ad alfabetizzarsi in entrambi gli ambienti, digitale e analogico, senza creare contrapposizioni. Inoltre, l’autore mette in evidenza come i bambini siano sempre più spesso i protagonisti del racconto che i loro stessi genitori portano quotidianamente in scena sui social network e si domanda fino a che punto sia corretto che gli adulti condividano pubblicamente contenuti riferiti ai figli. Attraverso questa pratica, nota con il nome di sharenting, il bisogno di raccontare l’esperienza della genitorialità si piega alla logica delle visualizzazioni e del mercato, mentre i figli rischiano di diventare un contenuto come tanti, che scorre sulle bacheche di tutti noi, perfetti sconosciuti.
Collocazione Biblioteca: 19735
A cura di Mauro Bossi ; intervista a Marco Gui, Lo smartphone in famiglia: istruzioni per l’uso. L’esperienza dei Patti digitali, in Aggiornamenti Sociali, a. 73, n. 11 (nov. 2022), pp. 623-627
Nell’intervista al docente di Sociologia e direttore del Centro “Benessere digitale” Marco Gui, vengono affrontati temi sensibili quali il precoce ingresso nel mondo digitale e la necessità per le famiglie di accompagnare le esperienze dei figli. Il Centro “Benessere digitale” e tre associazioni attive nel campo dell’educazione consapevole ai media hanno fondato “Patti digitali” che vuole favorire l’incontro tra genitori, insegnanti e altre figure educative per accompagnare i minori nell’uso degli smartphone.
Francesco Lavanga, Maria Rita Mancaniello, La formazione dell’adolescente nella realtà estesa. Pedagogia dell’adolescenza nel tempo della realtà virtuale, dell’intelligenza artificiale e del metaverso, Libreriauniversitaria.it, Padova, 2022, 164 pp.
L’evoluzione digitale si sta intrecciando sempre di più con quella biologica, arrivando a influenzare i nostri linguaggi, le nostre emozioni e persino i nostri pensieri. Le trasformazioni del rapporto tra essere umano e macchina stanno innescando riflessioni scientifico-umanistiche utili per sviluppare nuovi paradigmi di interpretazione di una realtà estesa che sovrappone il mondo fisico e quello virtuale. La pedagogia dell’adolescenza, in particolare, ha il compito di fornire studi e ricerche specifiche per conoscere sempre meglio il cambiamento in corso e rispondere ai bisogni complessi dello sviluppo del soggetto. Gli autori sono uno pedagogista e l’altra docent di Pedagogia sociale presso l’Università di Firenze.
Collocazione Biblioteca: 20312
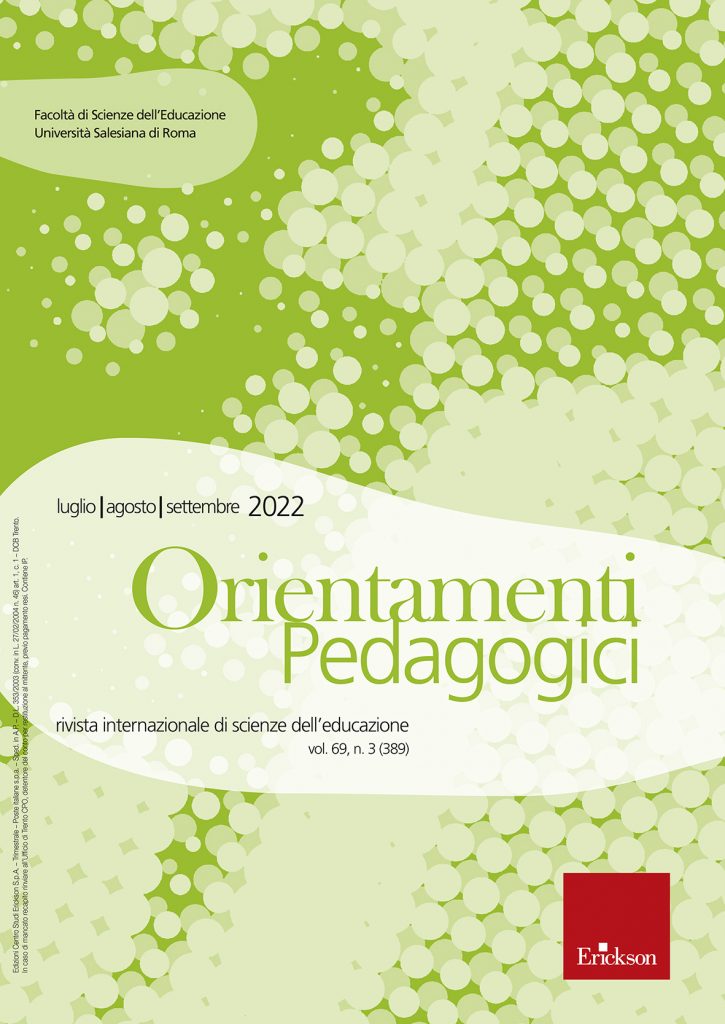 Maria Grazia Simone, Mente, cuore, mano nella prima infanzia. Dalla lezione pestalozziana ai media digitali, in Orientamenti pedagogici, vol. 69, n. 3, (lug.-set. 2022), pp. 27-38
Maria Grazia Simone, Mente, cuore, mano nella prima infanzia. Dalla lezione pestalozziana ai media digitali, in Orientamenti pedagogici, vol. 69, n. 3, (lug.-set. 2022), pp. 27-38
Il contributo intende offrire alcune piste di lavoro, utili a chi opera nei contesti educativi e didattici, pensate nell’ottica di un’educazione mediale che guidi il cuore e la mano del bambino nella fascia 0-6 anni tra le vaste opportunità di fruizione della tecnologia digitale, a vantaggio del conseguimento dei compiti di sviluppo legati al suo particolare momento evolutivo.
Matteo Lancini e Loredana Cirillo, Figli di Internet, Erickson, Trento, 2022, 140 pp.
Gli autori, psicologi e psicoterapeuti, docenti e specialisti nel campo della psicologia dell’adolescente, propongono una guida illustrata di auto aiuto, rivolta ai genitori e agli adulti che si interrogano su come gestire il rapporto tra adolescenti o preadolescenti con la rete, i social network e i dispositivi tecnologici. La rete, i social e i videogiochi fanno parte della loro quotidianità: il libro indica ai genitori la strada per comprendere come stabilire regole, proteggere i ragazzi dai pericoli della rete e educarli a utilizzare al meglio questi mezzi. Gli autori non danno consigli adatti a tutti i casi, ma tentano di guidare gli adulti verso la riflessione, stimolando domande utili alla comprensione dell’adolescente all’interno della complessa realtà in cui viviamo e in cui vivono i ragazzi. Il comportamento che un giovane mette in atto, anche nel rapporto con internet e con la tecnologia, rivela questioni più ampie, come gli ostacoli e i conflitti che sta affrontando in questa specifica fase evolutiva e gli adulti devono imparare a capire i significati delle sue scelte, ragioni e comportamenti.
Collocazione Biblioteca: 19697
A cura di Paola Cecchetti e Mariella Colosimo ; scritti di Marisa Andalò … [et al.], Voci dall’adolescenza. Studenti navigano. Un’esperienza dell’equipe psicopedagogica di Apeiron, Alpes, Roma, 2022, 147 pp.
Il libro presenta un intervento svolto dall’equipe psicopedagogica di un liceo romano, una ricerca azione su come gli studenti dell’Istituto siano soliti relazionarsi con le nuove tecnologie. Gli strumenti metodologici usati sono l’osservazione diretta, gli acrostici e lo psicodramma.
Collocazione Biblioteca: 19556
 A cura di Franco Floris, Se educare è stare nel travaglio della realtà. La “Vita come app” sta mettendo in crisi la desiderabilità del lavoro educativo?, in Animazione Sociale, n. 05/355 (2022), pp. 6-15
A cura di Franco Floris, Se educare è stare nel travaglio della realtà. La “Vita come app” sta mettendo in crisi la desiderabilità del lavoro educativo?, in Animazione Sociale, n. 05/355 (2022), pp. 6-15
Intervista ad Antonia Chiara Scardicchio, generale e sociale all’Università degli Studi Aldo Moro di Bari. Proseguendo la riflessione della rivista sull’introvabilità di figure educative, l’intervistata, voce autorevole della pedagogia italiana, invita a porsi una domanda radicale: se fosse un tipo particolare di professioni che non corrisponde più alle aspettative e non solo dei giovani? La chiave di lettura proposta colloca il dibattito sulla “crisi vocazionale di educatori” dentro il più ampio mutamento sociale e antropologico in corso.
Giorgia Pinelli, “Nulla di più arduo che amarsi”. Eros, affetti, educazione al tempo dei social, Marcianum Press, Venezia, 2021, 378 pp.
L’autrice, docente di discipline psicologiche, filosofia e storia, in questo volume muove dalla convinzione che sia possibile (e urgente) ripensare un’educazione all’amore, ripartendo dalle domande fondamentali. Chi è l’uomo? Cos’è l’amore, cos’è il desiderio? Qual è il vero volto di Eros? Che cosa significa educare? Tali interrogativi sono affrontati in un itinerario che prende avvio dalla viva voce dei giovani e attraversa gli impliciti antropologico-pedagogici oggi prevalenti nell’educazione affettiva a scuola, assieme alle immagini e ai miti di Eros/Amore che popolano il nostro immaginario.
Collocazione Biblioteca: 19661
Rosaria Salamone, Pericoli del web per i giovani e gli adolescenti. Linee guida per un corretto uso della rete, Alpes Italia, Roma, 2022, 78 pp.
Il testo affronta i pericoli che i giovani (e meno giovani) corrono nell’utilizzare la rete e gli odierni strumenti tecnologici senza un’adeguata consapevolezza. L’autrice si interroga quindi su come intervenire per marginalizzare questi problemi e traghettare la società verso una consapevole alfabetizzazione digitale. L’Educazione Civica Digitale è dunque auspicabile laddove ci sia una collaborazione tra le Istituzioni, la scuola e la famiglia. Per farlo, però, i genitori devono essere messi nelle condizioni di avere gli strumenti adatti per acquisire una “consapevolezza digitale”.
Collocazione Biblioteca: 20351
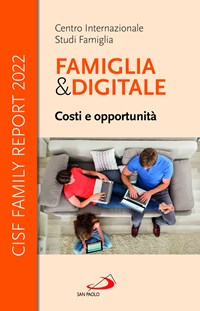 Centro Internazionale Studi Famiglia ; Contributi di Francesco Belletti … [et al.], Famiglia e digitale. Costi e opportunità, CISF Family Report 2022, San Paolo, Roma, 2022, 204 pp.
Centro Internazionale Studi Famiglia ; Contributi di Francesco Belletti … [et al.], Famiglia e digitale. Costi e opportunità, CISF Family Report 2022, San Paolo, Roma, 2022, 204 pp.
Il digitale e le Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ITC) sembrano aver conquistato, anche grazie alla pandemia, uno spazio ampio e consolidato all’interno della vita quotidiana e delle relazioni delle famiglie italiane, in particolare di quelle con figli minori. Anche le risorse economiche dedicate ai “consumi digitali- risultano molto sostenute, a prescindere dalle alterne vicende dei redditi familiari, perché si tratta ormai di “beni necessari-. Ma questo scenario è solo una delle numerose sfide che le famiglie devono oggi affrontare e a cui devono provare ad adattarsi, non solo nel nostro Paese. Viviamo una “supersocietà”, globalizzata e ipertecnologica, individualistica e “postfamiliare”, che alimenta un processo generale di crescente instabilità e complessità, che ogni attore sociale — e soprattutto ogni famiglia — deve saper affrontare e interpretare. Il testo, dopo aver affrontato la relazione tra status socio-economico familiare e uso delle tecnologie, mette in evidenza le vulnerabilità relazionali ed economiche della famiglia prodotte dalla pandemia.
Collocazione Biblioteca: 20430
A cura di Emilia Leopardi Barra, Francesco Trecate, Oltre la formazione. Un tour nella gamification, Armando, Roma, 2021, 171 pp.
La gamification è un esempio di come – attraverso la tecnologia guidata dalla pedagogia – il gioco possa divenire “formativo” irrompendo anche in contesti solitamente poco ospitali verso le dimensioni ludiche. L’evoluzione avvenuta nel digitale e le metodologie della progettazione formativa permettono oggi alle organizzazioni di qualificare la propria azione di crescita delle risorse umane, ponendo al centro le differenze individuali e sostenendo la motivazione all’apprendimento permanente. Il volume presenta alcuni fondamenti della gamification, e successivamente dimostra alcuni casi esemplari di applicazione in contesti di formazione di imprese assicurative, bancarie e manifatturiere, nonché sull’orientamento. Al fondo è presente una sitografia.
Collocazione Biblioteca: 20308
Igor Guida, Serena Bignamini … [et al.], Coding, robotica educativa e I.A. Per i cittadini attivi di domani, in Pedagogika.it, a. 25, n.4 (ott. – dic. 2021), pp. 8-75
Negli ultimi anni il mondo della scuola e dei servizi educativi è stato invaso da termini e acronimi legati a nuove discipline, nuovi strumenti tecnologici non di facile comprensione per i non addetti ai lavori. Il dossier inizia con un glossario introduttivo agli articoli che parlano di “coding”, “robotica educativa”, intelligenza artificiale. Gli strumenti di innovazione tecnologica saranno sempre più presenti nelle scuole pertanto è importante che genitori, insegnanti, educatori siano in grado di sviluppare competenze specifiche nei bambini e ragazzi per far si che da grandi siano cittadini attivi e liberi.
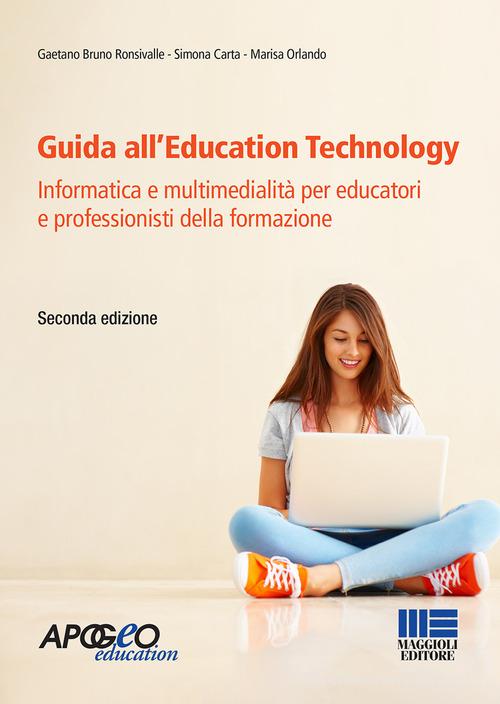 Gaetano Bruno Ronsivalle, Simona Carta, Marisa Orlando, Guida all’Education Technology. Informatica e multimedialità per educatori e professionisti della formazione, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2021, 359 pp.
Gaetano Bruno Ronsivalle, Simona Carta, Marisa Orlando, Guida all’Education Technology. Informatica e multimedialità per educatori e professionisti della formazione, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2021, 359 pp.
Il libro vuole essere una guida per educatori, docenti, professionisti della formazione ed esperti di scienze umane che desiderano esplorare i punti di contatto tra le tecnologie informatiche e multimediali e il mondo della didattica. Vengono esaminate le ultime evoluzioni dei dispositivi hardware, Internet e la cybersecurity, gli applicativi social del Web, la Data Science, le nuove frontiere della robotica e della IA, i principi della comunicazione multimediale, le tecniche di Presentation Design, le nuove tecnologie del Digital Learning. Gli autori sono docenti di Tecnologie informatiche e di Media Education presso l’Università di Verona.
Collocazione Biblioteca: 19893
Giuseppe Morante, Relazioni umane. Ri-educandosi, dopo il covid-19, nei rapporti «sociali» e «interpersonali», If Press, Roma, 2021, 223 pp.
L’autore, un pedagogista salesiano, si chiede se gli educatori di oggi e di domani saranno capaci di prepararsi sempre più e sempre meglio a relazionarsi nel nuovo contesto digitale nel quale vivono i giovani. Il testo tratta di come gli educatori dei giovani conoscono, riflettono, si collocano e approfondiscono la realtà dei social-network fino al punto da diventare competenti per interagire con i giovani che incontrano e quali sono gli spazi educativi formali che si offrono in famiglia, nelle scuole, nelle parrocchie e negli oratori. Quella digitale è una dimensione umana di tale importanza che non si può trascurare, come se non fosse qualcosa di vitale, fondamentale nell’evangelizzazione e nell’educazione oggi. E poiché è così vitale e fondamentale, deve essere presa in seria considerazione nella formazione delle nuove generazioni di educatori, dal momento che si tratta di un campo in cui i giovani, “nativi digitali”, sono chiamati a essere il nuovo umanesimo del domani.
Collocazione Biblioteca: 19130
A cura di Renata Metastasio, La media education nella prima infanzia (0-6). Percorsi, pratiche e prospettive, Franco Angeli, Milano, 2021, 131 pp.
I bambini del terzo millennio sono esposti sempre più precocemente ad un processo di socializzazione ai media digitali, favorito anche dal progressivo affermarsi della tecnologia touch e, recentemente, dalla forte accelerazione innescata dalla fase pandemica che ha posto tutti – adulti e bambini – nella necessità di affrontare nuove sfide nella modalità d’uso dei dispositivi digitali. In questo scenario complesso famiglia e scuola costituiscono il luogo primario di scoperta, esperienza, apprendimento e, anche, di costruzione di modelli di consumo mediale. Il volume si rivolge a educatori e genitori, con l’obiettivo di accompagnarli in un percorso di “buone pratiche” utili a favorire nel bambino, fin da piccolo, un processo di progressiva autonomia, consapevolezza e auto-regolamentazione.
Collocazione Biblioteca: 19792
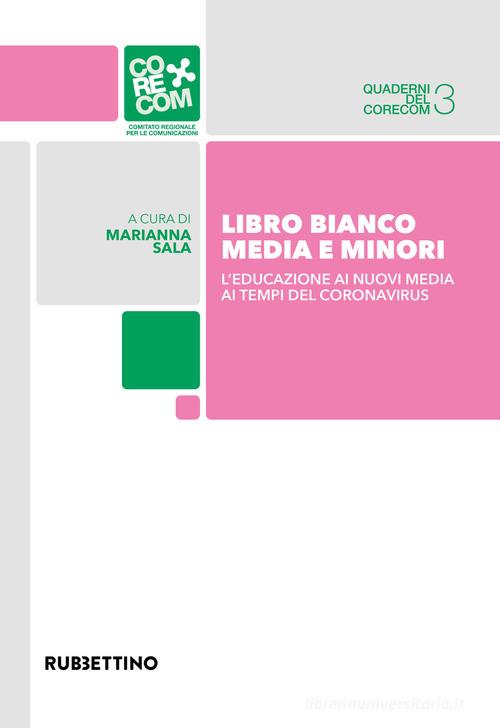 A cura di Marianna Sala, Libro bianco media e minori. L’educazione ai nuovi media ai tempi del coronavirus, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2021, 398 pp.
A cura di Marianna Sala, Libro bianco media e minori. L’educazione ai nuovi media ai tempi del coronavirus, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2021, 398 pp.
Il libro raccoglie i contributi di studiosi, professionisti ed educatori che tentano di analizzare le buone e le cattive pratiche nell’uso del digitale a scuola, coniugando riflessioni e dati raccolti nelle scuole secondarie lombarde nell’arco del 2020, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 che ha imposto stili di vita del tutto peculiari. Ne emerge una presa di consapevolezza dei ritardi strutturali e delle inerzie presenti nella scuola, ma anche la conferma della nostra dipendenza sempre più evidente dalle tecnologie, da sole però insufficienti ad avviare processi di innovazione o a garantire la tenuta delle dinamiche di formazione, socializzazione e partecipazione. Il volume è rivolto a chiunque si occupi di media e minori, come strumento conoscitivo e operativo, e ai soggetti decisori delle istituzioni perché possano trarne ispirazione per iniziative legislative ed amministrative che diffondano un uso consapevole della tecnologia.
Collocazione Biblioteca: 18871
Andrea Balzola, Edu-action. 70 tesi su come e perché cambiare i modelli educativi nell’era digitale, Meltemi, Milano, 2021, 234 pp.
Questo volume offre una sintesi, articolata in 70 brevi paragrafi-tesi, sui principali temi del pensiero e delle pratiche educative “divergenti ” e innovative, generate da sperimentazioni metodologiche sul campo, in cui la tecnologia debba essere concepita e rielaborata come “tecnicultura”, cioè la tecnologia dovrebbe dipendere dalla cultura e non viceversa. La postfazione è di Giovanni Ragone.
Collocazione Biblioteca: 19275
Claudia Zanchetta … [et al.], Tecnologie e sociale, in Lavoro sociale, n. 4 (ago. 2021), vol. 21, pp. 17-27
Il focus proposto comprende due contributi. Il primo è “Social (net)work” di Claudia Zanchetta, in cui l’autrice sottolinea come i social abbiano ridisegnato il modo di relazionarsi e di rimanere in contatto con le persone e le comunità a livello globale. Il fenomeno ha portato operatori sociali ad utilizzare i social, come Facebook, per la tutela di bambini e ragazzi, dando vita ad un acceso dibattito sulla eticità della pratica. Il secondo contributo è “L’uso dei social nelle comunità dei minori” di Vincenzo Salerno, Giosuè Casasola e Vincenzo Riccio, che fanno un’attenta riflessione su come l’utilizzo degli smartphone e dei tablet influenzi l’evoluzione dei ragazzi, specialmente quelli che versano in condizioni di maggiore fragilità, e come le forme di controllo possono essere l’occasione per rendere più salda la relazione educativa nelle strutture protette.
