Vittime di reato
Aggiornata a novembre 2023
I materiali, elencati in ordine decrescente per anno di pubblicazione, sono disponibili presso la Biblioteca del Gruppo Abele, negli orari e nelle modalità previste dal regolamento della Biblioteca.
Si consiglia di consultare anche le bibliografie specifiche su violenza di genere, tratta degli esseri umani e prostituzione, minori, bullismo e mafie. L’elenco proposto non esaurisce quanto posseduto in biblioteca sul tema in oggetto. Ulteriori ricerche sono possibili sul nostro catalogo bibliografico.
I percorsi tematici proposti sono i seguenti:
- Studi e ricerche sulle vittime di reato
- Torture e violazioni dei diritti umani
- Aspetti psicologici e linee di intervento
- Gli autori di reato e la giustizia riparativa
Studi e ricerche sulle vittime di reato
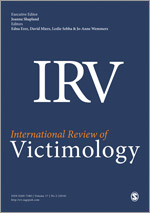 Antoinette Huber, ‘A shadow of me old self’: The impact of image-based sexual abuse in a digital society, in International Review of Victimology, vol. 29, n. 2 (mag. 2023) – on line, pp. 199-216
Antoinette Huber, ‘A shadow of me old self’: The impact of image-based sexual abuse in a digital society, in International Review of Victimology, vol. 29, n. 2 (mag. 2023) – on line, pp. 199-216
L’articolo versa nuova luce sull’impatto dell’abuso sessuale sulla donna basato sulle immagini (IBSA). Basandosi su 17 interviste in profondità, analizza l’impatto emozionale, fisico e sociale di questa vittimizzazione online e studia come l’IBSA impatti nella vita quotidiana delle donne. L’articolo offre anche più ampie considerazioni su come la tecnologia abbia facilitato un cambiamento nelle forme di violenza sessuale.
Sofia Fiore, La credibilità della donna nel processo per stupro: la vittima perfetta, in Studi sulla questione criminale, a. 17, n. 3 (2022), pp. 27-49
L’articolo indaga gli effetti della riproduzione dei “rape myths” (un complesso di credenze che incoraggiano l’aggressività sessuale maschile e supportano la violenza contro le donne) nel processo penale attraverso l’analisi di una sentenza assolutoria della Corte di Appello di Ancona in un caso di violenza sessuale. Nella motivazione della sentenza sono stati riprodotti diversi tra i più importanti miti sullo stupro che paiono essere stati determinanti nella ricostruzione dei fatti.
A cura di Francesca Di Muzio, Giorgio Vaccaro, Cosmologia della violenza familiare. Dinamiche, strumenti di contrasto e strategie di prevenzione, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2022, 202 pp.
Il volume intende affrontare in modo “interdisciplinare” i diversi atteggiarsi della violenza intrafamiliare e nelle relazioni di intimità, non solo attraverso un’analisi psico-giuridica-criminologica del fenomeno e delle dinamiche ad essa sottese, ma anche con la disamina delle varie fattispecie di reato in cui può concretizzarsi il fenomeno della violenza. L’entrata in vigore del Codice rosso (l. n.69/2019) ha introdotto nuove tipologie di reato e rafforzato gli strumenti processuali a tutela delle vittime, sia esse vittime dirette sia esse vittime indirette, come i minori che assistono alle violenze, imprimendo un’accelerazione al procedimento penale sin dalla fase delle indagini preliminari. La parte finale del volume è dedicata agli esempi concreti sia in ambito civile che penale delle misure di sostegno alle vittime di violenza domestica, con particolare riguardo alle forme di indennizzo per le vittime di reato e per gli orfani di femminicidio e all’assistenza prestata dai centri antiviolenza e dalle case rifugio.
In arrivo in Biblioteca
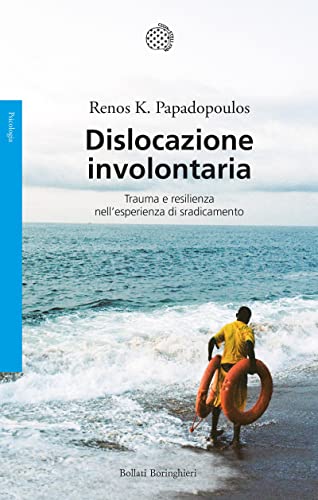 Renos K. Papadopoulos, Dislocazione involontaria. Trauma e resilienza nell’esperienza di sradicamento, Bollati Boringhieri, Torino, 2022, 400 pp.
Renos K. Papadopoulos, Dislocazione involontaria. Trauma e resilienza nell’esperienza di sradicamento, Bollati Boringhieri, Torino, 2022, 400 pp.
Con un approccio multidisciplinare e orientato alla pratica, il saggio offre una riflessione profonda e innovativa sui molti aspetti legati alla migrazione forzata, che l’autore chiama «dislocazione involontaria». Grazie alla sua lunga esperienza con i rifugiati, presenta casi di pratica clinica e analisi epistemologiche che mettono a nudo le trappole del pensiero terapeutico e dell’immaginario sociale legate allo sradicamento. Le diverse prospettive adottate dalla psicoanalisi, dalla filosofia e dall’etimologia non solo permettono di identificare soluzioni a sostegno della persona dislocata, ma espandono anche gli orizzonti di significato relativi a concetti onnicomprensivi e fuorvianti come «trauma» e «vittima», che finiscono per patologizzare, anziché sostenere un percorso di crescita e di cambiamento. Nel saggio vengono proposti strumenti inediti per inquadrare il fenomeno in modo corrispondente alla sua sfaccettata complessità.
Collocazione Biblioteca: 19674
Gillian Dell, Andrew McDevitt, Exporting Corruption 2022: Assessing Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention, Transparency International, Berlino, 2022, 134 pp.
Il rapporto valuta lo stato della corruzione internazionale in 43 dei 44 firmatari della Convenzione anticorruzione dell’OCSE, nonché in Cina, Hong Kong SAR, India e Singapore. Identifica le inadeguatezze dei quadri giuridici e dei sistemi di applicazione, nonché i progressi compiuti per porvi rimedio. Inoltre, punta i riflettori sulla questione cruciale del risarcimento delle vittime e individua aree di miglioramento per quanto riguarda la trasparenza dei dati relativi all’applicazione della legge.
Nina Törnqvist, Drizzling sympathy: Ideal victims and flows of sympathy in Swedish courts, in International Review of Victimology, vol. 28, n. 3 (set. 2022) – on line, pp. 263-285
Collegando le prospettive sociologiche della compassione con il concetto di ‘vittime ideali’, questo articolo esamina come la compassione modelli e informi il pensiero e le pratiche riguardo allo stato di vittima nei tribunali svedesi. Nella sua accezione più vasta, la compassione può essere intesa come comprensione e cura della sofferenza di un’altra persona e in molti contesti vittimizzazione e compassione sono strettamente intrecciati. Tuttavia, poiché gli ideali di obiettività e neutralità prevalgono in tribunale, le norme emotive sono ristrette e la compassione incontra sospetto. Attingendo a un lavoro etnografico sul campo effettuato nei tribunali svedesi, l’autrice sostiene che mentre i sentimenti di compassione fanno per la maggior parte da sfondo, essi sono ancora una parte centrale dei procedimenti e delle delibere giudiziarie.
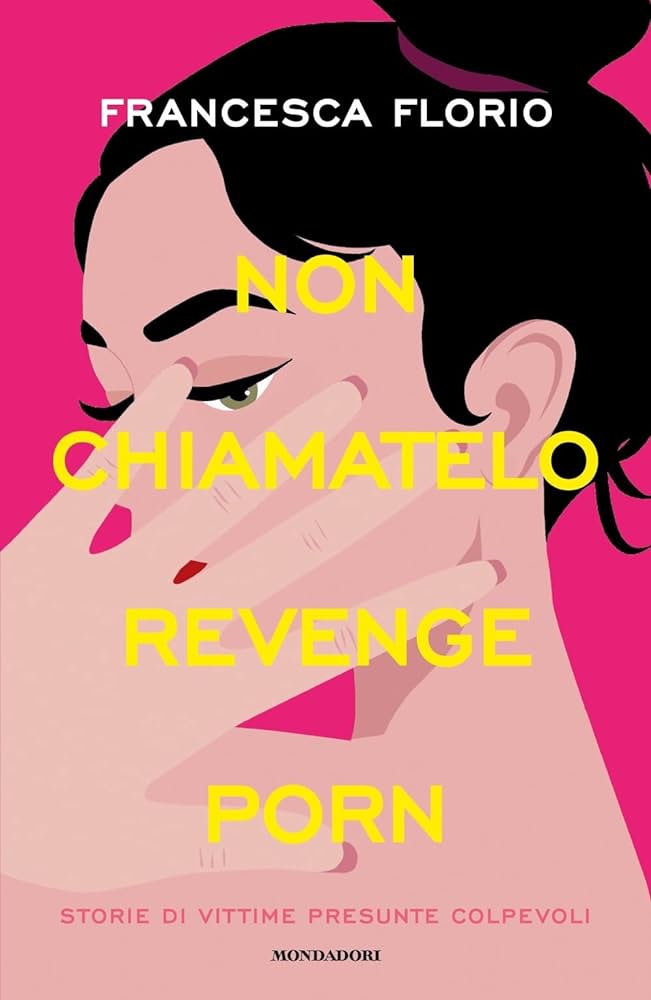 Francesca Florio, Non chiamatelo Revenge Porn. Storie di vittime presunte colpevoli, Mondadori, Milano, 2022, 189 pp.
Francesca Florio, Non chiamatelo Revenge Porn. Storie di vittime presunte colpevoli, Mondadori, Milano, 2022, 189 pp.
“Revenge porn” (traducibile con “porno per vendetta”) è l’espressione con cui viene comunemente indicata la diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti da parte di un individuo – spesso un ex partner – allo scopo di denigrare la persona che compare nelle immagini, perlopiù donne e ragazze. Questi contenuti sono una forma vera e propria di abuso sessuale. Il testo racconta le storie vere di donne e ragazze che hanno visto tradire la fiducia che avevano riposto in persone sbagliate. Oltre a queste storie di vite violate, l’autrice, grazie alla sua competenza in materia di diritto, fornisce strumenti e consigli legali per aiutare a prevenire il fenomeno e a proteggere le vittime future di questa ennesima forma di violenza di genere.
Collocazione Biblioteca: 19880
Caterina Peroni, From another place: prospettive femministe sugli effetti della pandemia sulla violenza di genere, in Studi sulla questione criminale, a. 17, n. 1 (2022), pp. 55-73
L’articolo, prendendo come spunto l’articolo “Criminological futures and gendered violence(s): lessons from the global pandemic for criminology” di Sandra Walklate (Journal of Criminology, 2021), discute degli effetti della pandemia sulle violenze di genere attraverso una lettura criminologica femminista che indichi prospettive concrete da cui far emergere come prevenire quella che l’autrice definisce la “pandemia ombra”, l’aumento vertiginoso della violenza di genere dovuto al cortocircuito culturale della casa come posto sicuro dalla pandemia che diventa prigione per la vittima tagliandone le vie di fuga dal suo aguzzino. Nell’ultima parte dell’articolo sono inoltre raccolte riflessioni di operatrici dei centri antiviolenza, per sottolineare la necessità dell’approccio proposto.
Eva Mulder, Alice Kirsten Bosma, Filling in the (gendered) gaps: How observers frame claims of sexual assault, in International Review of Victimology, n. 2 (mag. 2022) – on line, pp. 215-234
Gli autori hanno indagato come le persone giudichino la veridicità delle denunce di violenza sessuale e come successivamente inquadrino le loro interpretazioni di queste denunce utilizzando “conoscenze generali” sotto forma di copioni sessuali, miti sullo stupro e stereotipi di genere. I partecipanti (n = 161) hanno letto una denuncia di violenza sessuale da parte di un uomo o di una donna e sono stati invitati a descrivere più dettagliatamente ciò che pensavano fosse accaduto. I dati sono stati analizzati utilizzando una combinazione di analisi quantitativa e qualitativa. Nell’articolo sono riportati e commentati i risultati dell’indagine.
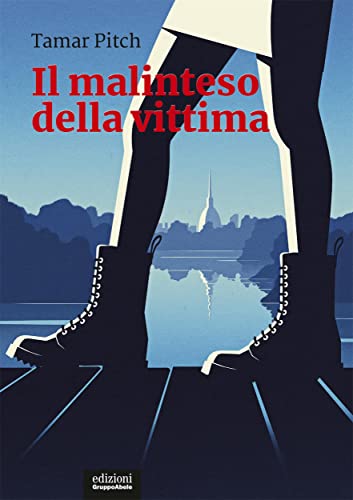 Tamar Pitch, Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022, 111 pp.
Tamar Pitch, Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2022, 111 pp.
Secondo l’autrice, già docente di filosofia del diritto e di sociologia del diritto, il termine “sicurezza” si è spogliato, ormai da parecchi anni, delle caratteristiche sociali cui era legato (lavoro, salute, diritti). Oggi ci si sente al sicuro con condizioni che ci proteggono individualmente dal rischio di diventare “vittime” di comportamenti dannosi. Da qui l’assunto che tutte e tutti siamo vittime potenziali; quindi fenomeni sociali complessi vengono governati con il codice penale e, di fatto, si criminalizza la povertà, la marginalità sociale, l’immigrazione. Ma com’è successo tutto questo? E soprattutto, com’è successo che a questa deriva securitaria aderiscano movimenti politici – tra i quali quello femminista – il cui obiettivo è la libertà dallo sfruttamento, dall’oppressione, dalla violenza dei gruppi di cui si fanno portavoce?
Collocazione Biblioteca: 19819
A cura di Maurizio Esposito, Lucio Meglio, Sicurezza sociale e gioco d’azzardo, in Sicurezza e scienze sociali, a. 10, n. 1 (gen.-apr. 2022), pp. 7-134
In questo numero della rivista il gioco d’azzardo viene approfondito e osservato attraverso il prisma delle sensibilità, degli approcci e delle visioni differenziate di autori, ricercatori ed esperti del settore. Lo scopo è quello di mostrare i vari volti di uno stesso fenomeno, le sfaccettature di una dipendenza comportamentale che influisce sulla vita degli adulti e dei più giovani e che ha trovato nel web un canale di chiaro e preoccupante sviluppo con innesti e ramificazioni in altri fenomeni di dipendenza, oltre alla lettura che ne viene data dai nuovi media.
Judy Eaton, Jenniffer Olenewa, Cole Norton, Judging extreme forgivers: How victims are perceived when they forgive the unforgivable, in International Review of Victimology, vol. 28, n. 1 (gen. 2022) – on line, vol. 28, pp. 1-19
Quando un individuo commette una trasgressione o un atto aggressivo nei confronti di un altro, spesso terze parti hanno aspettative su come la vittima dovrebbe rispondere, anche quando non hanno alcun coinvolgimento personale nell’evento. Questa ricerca esamina come reagiscono gli osservatori terzi quando le vittime perdonano reati apparentemente “imperdonabili”. Lo studio 1 ha mostrato che, sebbene le terze parti non fossero direttamente critiche nei confronti di una vittima che perdona, non erano d’accordo con la decisione di perdonare. Lo studio 2 ha replicato questi risultati ed esplorato in modo più approfondito i sentimenti del terzo legati alla giustizia. I risultati suggeriscono che, sebbene le terze parti siano riluttanti a criticare direttamente i perdonatori “estremi”, non sostengono la loro decisione di perdonare.
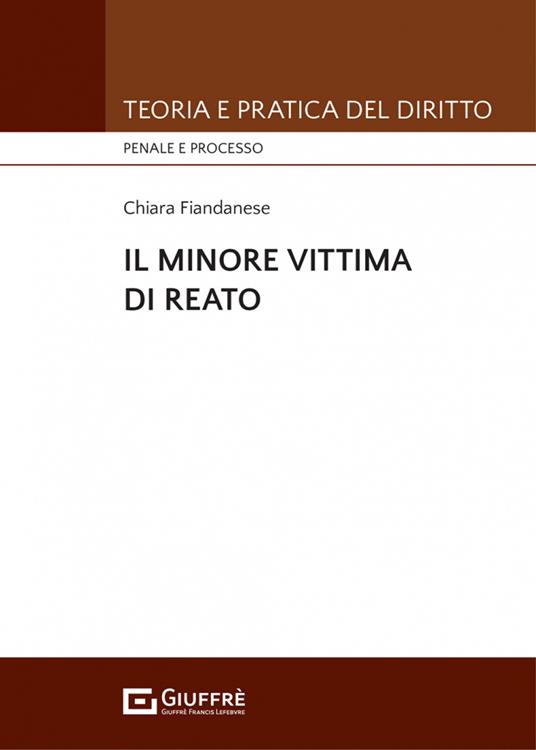 Chiara Fiandanese, Il minore vittima di reato, Giuffrè, Milano, 2022, 437 pp.
Chiara Fiandanese, Il minore vittima di reato, Giuffrè, Milano, 2022, 437 pp.
L’autrice, avvocato penalista, affronta le diverse tematiche relative al minore come persona offesa dal reato o come persona coinvolta in un processo penale. In particolare esamina tutte le fattispecie nelle quali il minore è soggetto offeso da comportamenti che costituiscono reati o illeciti: sia quando tali reati o illeciti sono commessi nei confronti del minore sia quando il minore è destinatario della norma incriminatrice. Inoltre, esamina le fattispecie in cui la minore età è circostanza aggravante di delitti che possono essere commessi nei confronti di chiunque. Approfondisce i problemi di natura processuale causati dalla presenza di un minore nel processo, considerando il coinvolgimento emotivo del minore come parte offesa o testimone, per salvaguardarne lo sviluppo e la crescita psichica. L’opera espone tutti i problemi che riguardano i minori coinvolti nel procedimento penale, illustra la normativa di riferimento, richiama ed esamina la giurisprudenza più recente.
Collocazione Biblioteca: 19745
Maria Teresa Maragò, Mobbing coniugale e alienazione parentale, Una ricerca tra vittime e operatori, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a.51, n. 4 (autunno 2021), pp. 28-31
Oltre alla violenza fisica di cui ci raccontano le cronache dei mass media, esiste un altro tipo di violenza che non lascia lividi sul corpo ma origina ferite profonde ed invisibili che si radicano nella comunicazione patologica, soprattutto intra familiare. Si parla allora di mobbing coniugale e sindrome di alienazione parentale. Dallo studio emerge che la comunicazione patologica fa più vittime di quanto si creda e può diventare una potente arma per distruggere indistintamente sia dall’età che dal genere.
Alessandro Lo Presti, Alfonso Landolfi, Gestire il mobbing nelle organizzazioni, il Mulino, Bologna, 2021, 205 pp.
Autonomia economica, possibilità di esprimere le proprie conoscenze e competenze, di acquisire status, di essere parte attiva della società e di intessere relazioni sono aspetti che si possono realizzare grazie al lavoro e che contribuiscono al nostro benessere. Nel lavoro e nelle organizzazioni esistono tuttavia condizioni che producono, al contrario, esiti negativi, sia per le persone sia per le organizzazioni stesse. Tra i fattori che riguardano il deterioramento delle relazioni e del clima psicosociale troviamo il mobbing. In questo volume gli autori, oltre a descrivere questo complesso e articolato fenomeno, propongono innovativi progetti di intervento e di gestione basati sull’approccio dello sviluppo organizzativo e validati empiricamente. Uno strumento indispensabile per affrontare quello che possiamo considerare oggigiorno una delle più importanti fonti di stress e di disagio lavorativo e al tempo stesso origine e causa di disfunzioni e problemi nella performance, nella gestione dei conflitti e nel benessere organizzativo.
Collocazione Biblioteca: 19391
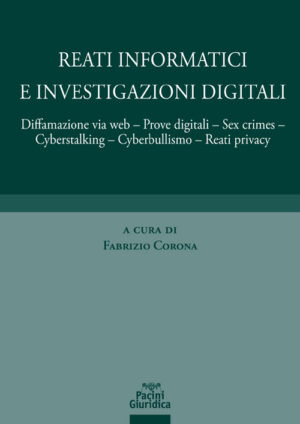 A cura di Fabrizio Corona, Reati informatici e investigazioni digitali. Diffamazione via web, prove digitali, sex crimes, cyberstalking, cyberbullismo, reati privacy, Pacini Giuridica, Pisa, 2021, 247 pp.
A cura di Fabrizio Corona, Reati informatici e investigazioni digitali. Diffamazione via web, prove digitali, sex crimes, cyberstalking, cyberbullismo, reati privacy, Pacini Giuridica, Pisa, 2021, 247 pp.
Il progressivo diffondersi degli strumenti e delle tecnologie digitali ha prodotto l’inevitabile aumento della criminalità informatica, impegnando il Legislatore nell’individuazione di nuove figure criminose, il cui insieme ha dato vita a una nuova categoria di reati: quella dei computer crimes o reati informatici. Questa situazione ha comportato la nascita di una nuova disciplina giuridica che realizza l’incontro del diritto con l’informatica: la computer forensics, finalizzata all’individuazione delle prove nei supporti informatici. Il volume, pertanto, fornisce una descrizione dei reati informatici, il tutto corredato da una minuziosa descrizione delle tecniche di acquisizione, individuazione e analisi dei reati informatici. L’opera analizza le più recenti ipotesi di reati informatici quali: la diffamazione nell’era dei social network, i sex crimes nell’era digitale, il cyberstalking, il cyberbullismo, i reati informatici ex d.lgs 231/2001 e i reati in materia di protezione dei dati personali. Il curatore è docente universitario e consulente nel campo.
Collocazione Biblioteca: 19022
Vicky Heap, Exploring the effects of long-term anti-social behaviour victimisation, in International Review of Victimology, n. 2 (mag. 2021) – on line, pp. 227-242
Nonostante l’interesse vittimologico per gli impatti dei diversi tipi di vittimizzazione criminale, c’è poco lavoro empirico che esamini gli effetti del comportamento criminale a lungo termine sulle vittime. Questo articolo inizia a ristabilire l’equilibrio riportando i risultati di un progetto di ricerca qualitativa in Inghilterra che ha studiato gli effetti della vittimizzazione del comportamento antisociale a lungo termine. Le interviste semi-strutturate hanno esplorato i resoconti delle vittime del comportamento antisociale a lungo termine che hanno subito e gli effetti che ne derivano sulle loro vite. La ricerca ha scoperto che le vittime sperimentano una serie di effetti sulla salute mentale e fisica, nonché cambiamenti comportamentali e ha fornito la prima visione approfondita dell’impatto di questo tipo di vittimizzazione. I risultati suggeriscono che i danni cumulativi associati al comportamento antisociale devono essere meglio riconosciuti, compresi e affrontati, con un maggiore sostegno messo a disposizione delle vittime.
Didier Fassin, Richard Rechtman ; traduzione e cura di Luigigiovanni Quarta, L’impero del trauma. Nascita della condizione di vittima, Meltemi, Milano ; Udine, 2020, 439 pp.
Dagli attentati ai terremoti, dagli incidenti aerei ai sequestri, dai massacri ai suicidi, ogni avvenimento violento invoca la presenza di psichiatri e psicologi che intervengono in nome della traccia psichica del dramma: il trauma. A lungo questa nozione è servita a squalificare soldati e operai della cui sofferenza si metteva in dubbio l’autenticità. Oggi, grazie al trauma, le vittime trovano un riconoscimento sociale. Il libro delinea il percorso che dai lavori di Charcot, Janet e Freud giunge all’invenzione del disturbo post-traumatico da stress negli Stati Uniti, fino all’attuale era di riabilitazione.
Collocazione Biblioteca: 19752
 Serena Gianfaldoni, Workplace violence. Quando la violenza è esercitata sul lavoro, Pacini, Pisa, 2020, 139 pp.
Serena Gianfaldoni, Workplace violence. Quando la violenza è esercitata sul lavoro, Pacini, Pisa, 2020, 139 pp.
Il libro affronta il tema della violenza nel contesto lavorativo, nelle sue diverse forme. Per ogni forma di violenza citata, sono presentate una descrizione del fenomeno, una bibliografia di approfondimento, una scheda giuridica, il riferimento a un caso reale, una citazione e un’elaborazione grafica originale. Le forme di violenza considerate sono le seguenti: mobbing, bossing, side mobbing, low mobbing, molestia e ricatto sessuale, stalking, ostacoli alla progressione di carriera, discriminazioni verso le donne, difficile conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, violenza economica e mancato pagamento della prestazione lavorativa, maternità ostacolata, violenza verbale, violenza indiretta, violenza da parte dell’utenza, discriminazioni e violenze legate all’appartenenza.
Collocazione Biblioteca: 18913
Giacomo Gualtieri … [et al.], “Online romantic scam” (Le truffe sentimentali via internet). Dinamiche relazionali, profilo psicologico delle vittime e degli autori: una scoping review, in Rassegna Italiana di Criminologia, a. 49, n. 2 (2020), pp. 110-119
Le tecnologie di comunicazione digitali consentono di superare barriere fisiche, psicologiche e sociali nella ricerca e costruzione di legami affettivi. Il fenomeno delle truffe sentimentali online (“Online Romance Scam”) è una moderna forma di frode diffusasi nelle società occidentali parallelamente alla nascita di social media e app per incontri. L’autore sviluppa una relazione sentimentale con la vittima per 6-8 mesi, costruendo un legame affettivo profondo attraverso un profilo Internet fittizio, con l’obiettivo di estorcere risorse economiche attraverso strategie manipolatorie. Due sono le peculiarità: da una parte il doppio trauma legato alla perdita di denaro e della relazione al momento della scoperta, dall’altra la vergogna della vittima, aspetto che potrebbe far sottostimare il numero di casi. Il presente lavoro descrive una scoping review delle evidenze quantitative e qualitative sulle caratteristiche di questo fenomeno con particolare riferimento agli aspetti epidemiologici, alle dinamiche relazionali che si instaurano tra i due attori, al profilo di personalità delle vittime e degli autori. Comprendere le caratteristiche psicologiche delle vittime e degli autori di un fenomeno tanto emergente quanto ancora in larga parte sommerso, può consentire l’identificazione di profili di personalità a rischio e lo sviluppo di strategie di sensibilizzazione e prevenzione.
Simonetta Vernocchi, Stalking, Un fenomeno sommerso, Lupetti, Milano, 2020, 232 pp.
Lo stalking è un fenomeno sommerso che difficilmente viene denunciato, soprattutto se si verifica in ambito familiare. I centri d’ascolto, le interviste anonime, i data-base dei servizi di emergenza-urgenza ci offrono un quadro più complesso rispetto ai dati delle fonti ufficiali. Parlare di stalking è parlare di controllo, anzi di ipercontrollo, di gelosia, di possesso e non ultimo di violenza. La violenza domestica è spesso preceduta da anni di stalking, sopportato e tollerato dalle vittime. Nella prima parte il testo analizza i dati della letteratura, nella seconda il comportamento iper-controllante alla luce delle recenti classificazioni, la psicodinamica dell’ipercontrollo, della gelosia, del possesso e dell’evoluzione violenta dello stalker. Infine, il testo si occupa della psicodinamica della vittima, per cercare di capire come mai alcune relazioni familiari, amicali, sentimentali veramente tossiche si protraggono per anni nonostante la sofferenza di chi ne resta invischiato.
Collocazione Biblioteca: 18929
Ivan Urlic, Miriam Berger, Avi Berman ; a cura di Franco Del Corno, Vittime, vendetta e perdono. Trattamento del trauma individuale e collettivo, Edra, Milano, 2019, 334 pp.
Gli esiti traumatici del rapporto vittima-carnefice e la costruzione di percorsi che, attraverso la dimensione laica del perdono, consentano alla vittima di recuperare un accettabile equilibrio delle emozioni e dei comportamenti costituiscono il filo rosso di questo volume, che coniuga teoria e pratica clinica, in un ambito che sfida continuamente la capacità degli operatori di essere d’aiuto in modo efficace. Vengono presi in considerazione in particolare i traumi collettivi, nei quali i ruoli di vittima e di carnefice sono svolti da intere popolazioni o da parti di esse, tenendo presente anche l’aspetto della trasmissione intergenerazionale del trauma. Si evidenzia come il desiderio di vendetta, pur rappresentando un passaggio ineliminabile e legittimo del percorso di elaborazione del trauma, metta a rischio il ritorno a una condizione psichica adeguata. In continuità con l’eziopatogenesi di queste condizioni traumatiche, il gruppo psicodinamico è proposto come strumento terapeutico privilegiato e a tal fine vengono presentati casi clinici che ne descrivono il funzionamento ed esemplificano l’efficacia dell’approccio degli autori.
Collocazione Biblioteca: 19109
Torture e violazioni dei diritti umani
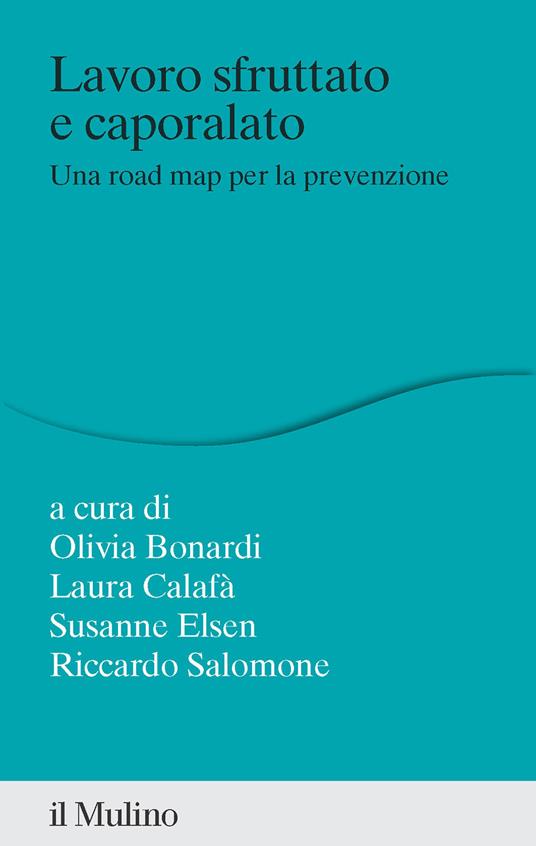 A cura di Laura Calafà, Olivia Bonardi, Susanne Elsen, Lavoro sfruttato e caporalato. Una road map per la prevenzione, Il Mulino, Bologna, 2023, 288 pp
A cura di Laura Calafà, Olivia Bonardi, Susanne Elsen, Lavoro sfruttato e caporalato. Una road map per la prevenzione, Il Mulino, Bologna, 2023, 288 pp
È possibile prevenire lo sfruttamento lavorativo e il caporalato? Il volume, frutto del lavoro pluriennale di quattro unità di ricerca di altrettante università italiane, presenta un’innovativa road map per la prevenzione di questi complessi fenomeni, usualmente oggetto di un’attenzione (politica, legislativa e scientifica) soltanto repressiva. Il libro, oltre a presentare un complesso progetto di ricerca-azione, traccia linee di intervento dirette verso quattro dimensioni fondamentali: emersione dei fenomeni, inclusione delle persone immigrate, intermediazione del lavoro, autoregolazione responsabile. I diversi capitoli approfondiscono queste dimensioni, ponendo in evidenza il ruolo del pubblico e del privato – attori, governance, risorse – nella regolamentazione del lavoro. Nel caso concreto si parla del lavoro in agricoltura, ma la riflessione scientifica contenuta nel libro è estensibile a molti altri settori a rischio.
In arrivo in Biblioteca
Save the Children Italia, Piccoli schiavi invisibili – XIII edizione 2023. Dentro lo sfruttamento: un’indagine sui figli dei braccianti a Latina e Ragusa, Save the Children Italia, Roma, 2023, 81 pp.
Il rapporto denuncia le condizioni dei minori, vittime o a rischio di tratta e sfruttamento nel nostro Paese. Si concentra sui bambini, bambine e adolescenti che crescono in aree dove la condizione di sfruttamento dei genitori li rende vittime, sin dalla nascita, della violazione dei loro diritti basilari in maniera sistematica, esponendoli anche al rischio di essere sfruttati ed esposti ad abusi. La ricerca è stata condotta nella provincia di Latina nel Lazio, e nella Fascia Trasformata di Ragusa in Sicilia. Sono riportate testimonianze dirette di chi ha subito o subisce lo sfruttamento, insieme a quelle di rappresentanti delle istituzioni e delle realtà della società civile, dei sindacati, dei pediatri, dei medici di base e degli insegnanti, impegnati in prima linea.
A cura di Michele Miravalle, Antonio Scandurra, È vietata la tortura. XIX Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, Antigone, Roma, 2023, 502 pp.
Il rapporto di Antigone, che ogni anno fa il punto sullo stato delle carceri italiane, lancia un allarme sul sovraffollamento, un problema ormai endemico del sistema penitenziario, certificato anche dai tribunali di sorveglianza che, solo nel 2022, hanno accolto 4.514 ricorsi di altrettante persone detenute. I diversi capitoli del Rapporto affrontano i seguenti argomenti: stranieri, donne e bambini, minori, 41 bis e Alta sicurezza, suicidi e autolesionismo, isolamento ed eventi critici, lavoro e formazione, istruzione, criminalità. Il focus centrale è invece dedicato alla tortura, esaminando la recente introduzione del reato e i processi in corso. Successivi approfondimenti sono invece centrati su: affettività in carcere, salute mentale, le politiche sulle droghe, i diritti LGBTQI+ in carcere.
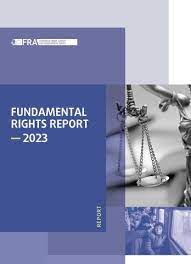 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Fundamental Rights Report 2023. Report, European Union Agency for Fundamental Rights, Luxembourg, 2023, 277 pp.
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Fundamental Rights Report 2023. Report, European Union Agency for Fundamental Rights, Luxembourg, 2023, 277 pp.
Il documento presenta i progressi e gli arretramenti nel campo della difesa dei diritti fondamentali nell’Unione europea nell’anno 2022. Il focus di quest’anno riguarda le implicazioni per l’Unione Europea della guerra in Ucraina, descrivendo la gestione dell’improvviso e massiccio ingresso di persone in fuga dalla guerra e la necessità di misure a lungo termine per coloro che intendono restare nell’UE. Gli altri capitoli del rapporto esplorano i principali sviluppi, identificando sia le conquiste, sia le aree di attenzione, riguardanti: la Carta europea dei diritti fondamentali; l’uguaglianza e la non discriminazione; il razzismo e la relativa intolleranza; l’inclusione dei Rom; l’asilo, i confini e le migrazioni, la società dell’informazione e la protezione dei dati; i diritti dei minori; l’accesso alla giustizia, i diritti delle vittime e l’indipendenza della giustizia; l’implementazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Il documento riguarda non solo i 27 stati membri dell’Unione, ma anche l’Albania, la Macedonia del nord e la Serbia. Infine, le opinioni del FRA, disponibili separatamente nelle diverse lingue europee, suggeriscono alle istituzioni europee e ai governi nazionali una serie di azioni tempestive e pratiche di comprovata efficacia.
Giada Girelli, Marcela Jofré, Ajeng Larasati, The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2022, Harm Reduction International, Londra, 2023, 54 pp.
Questo rapporto dell’HRI si concentra sull’uso della pena di morte in casi di uso di droghe, aggiornato al 2022. Viene registrato un forte aumento rispetto all’anno precedente, in parte dovuto alla ripresa delle esecuzioni per possesso di droga in Arabia Saudita e a Singapore, e della repressione in Iran. Si contano ancora 35 paesi in cui ancora vige la pena di morte per crimini legati alla droga, e nonostante proteste più forti a riguardo (in particolare a Singapore) il trend sembra essere per un aumento di questi numeri. Si nota anche che la risposta delle istituzioni internazionali è stata debole.
World Organisation Against Torture (OMCT), Who in their right mind wants to put up with this? Resilience strategies for a sustainable human rights movement, OMCT, Ginevra, 2022, 56 pp.
I gruppi che lavorano per la tutela dei i diritti umani hanno sviluppato, in tutto il mondo, strategie efficaci per sostenere il loro personale nel far fronte ad alti livelli di stress e paura e alle conseguenze dell’essere testimoni di abusi e traumi. Gli attivisti di queste organizzazioni sopportano violenze, intimidazioni, persecuzioni legali e condizioni di lavoro difficili, caratterizzate da tensione e urgenza. Molti di loro finiscono per lottare contro depressione, traumi, burnout e altri disturbi mentali. Alcune delle loro esperienze sono pubblicate nella guida proposta, che raccoglie anche le migliori pratiche utilizzate tra 23 organizzazioni membri e partner della Rete SOS-Tortura dell’OMCT.
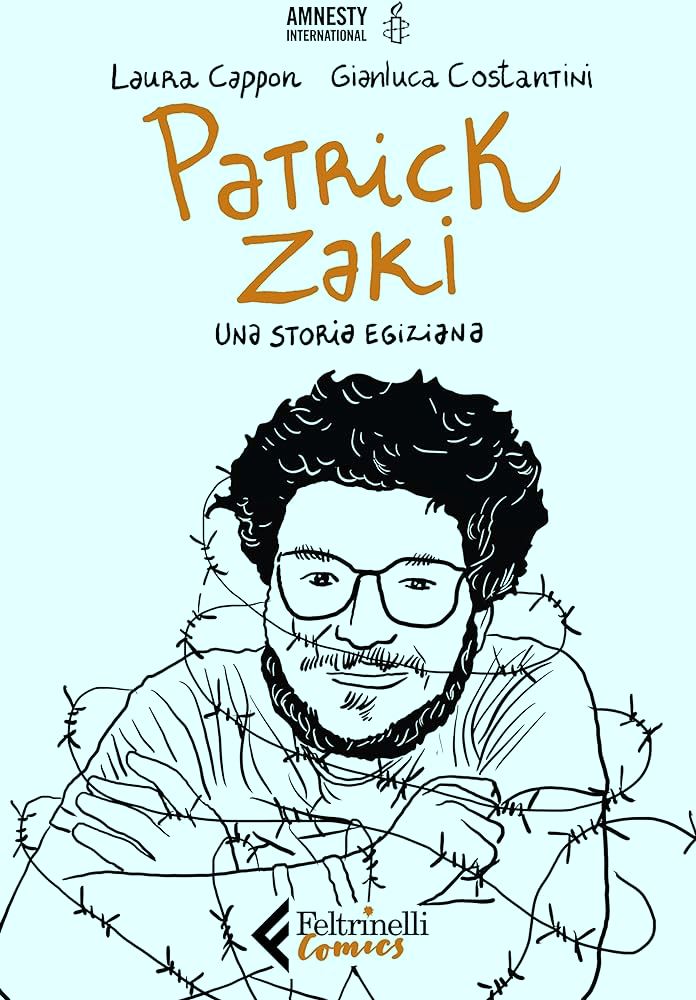 Laura Cappon, Gianluca Costantini, Patrick Zaki. Una storia egiziana, Feltrinelli, Roma, 2022, 128 pp.
Laura Cappon, Gianluca Costantini, Patrick Zaki. Una storia egiziana, Feltrinelli, Roma, 2022, 128 pp.
La giornalista che fin dall’inizio ha seguito il caso di Patrick Zaki e il disegnatore che ne ha realizzato l’immagine più iconica scelgono il fumetto per ricostruire una vicenda drammatica, eppure piena di speranza, che ha destato attenzione a livello internazionale e mobilitato le coscienze contro la violazione dei diritti umani. Il racconto comincia il 7 febbraio 2020, giorno in cui Patrick Zaki, studente egiziano iscritto a un master in Studi di genere all’Università di Bologna e collaboratore di EIPR, l’Egyptian Initiative for Personal Rights, viene fermato all’aeroporto del Cairo, mentre sta tornando a casa. Cinque sono i capi d’accusa: minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione, diffusione di notizie false, propaganda per il terrorismo. Le prove sono dieci post su Facebook, ritenuti non autentici dai suoi avvocati, che inciterebbero alla rivolta. Patrick è rimasto in detenzione preventiva per 22 mesi. Nel settembre del 2021 è stato rinviato a giudizio con l’accusa di diffusione di notizie false e per aver seminato il terrore fra la popolazione con un articolo sulla situazione della minoranza cristiana in Egitto. A dicembre il giudice ha deciso la sua scarcerazione ma non lo ha assolto.
Collocazione Biblioteca: 19109
Alessandro Albano, Daniela de Robert, Mauro Palma, Nelle mani altrui, Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Roma, 2022, 374 pp.
Mantenere viva la memoria attraverso il recupero e la diffusione di discorsi e scritti che hanno rappresentato tappe decisive nell’affermazione dei diritti umani è l’obiettivo della collana Da dove del Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale. Questo quarto volume è sulla tortura, reato entrato nel Codice penale italiano solo nel 2017. Suddiviso in tre parti – Presenza, Persistenza e Prevenzione –, nella prima il libro ripropone alcuni testi del secolo scorso che hanno disvelato la Presenza della tortura in Europa; nella seconda prende atto della Persistenza del problema in Italia, negli Stati Uniti, in Egitto e in Libia, con documenti giudiziari e contributi di protagonisti e studiosi; nella terza dà conto della Prevenzione come arma messa in campo in ambito nazionale e sovranazionale per impedire, mediante l’azione di appositi Organismi di vigilanza, che la tortura si verifichi e proponendo una analisi e un bilancio della legge sulla tortura in Italia a cinque anni dalla sua approvazione.
Sergio Seminara, Sui confini tra i delitti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro, Sistema Penale, Milano, 2022, 35 pp.
Il reato di sfruttamento del lavoro presenta elementi comuni con l’incriminazione di riduzione in servitù, che a sua volta risulta contigua all’incriminazione di riduzione in schiavitù. L’analisi dei concetti di schiavitù, servitù e sfruttamento del lavoro rivela tuttavia taluni motivi di incongruenza che, allargando la visuale al diritto internazionale, si accrescono a causa dell’assenza, nel nostro ordinamento, di una norma penale sul lavoro forzato.
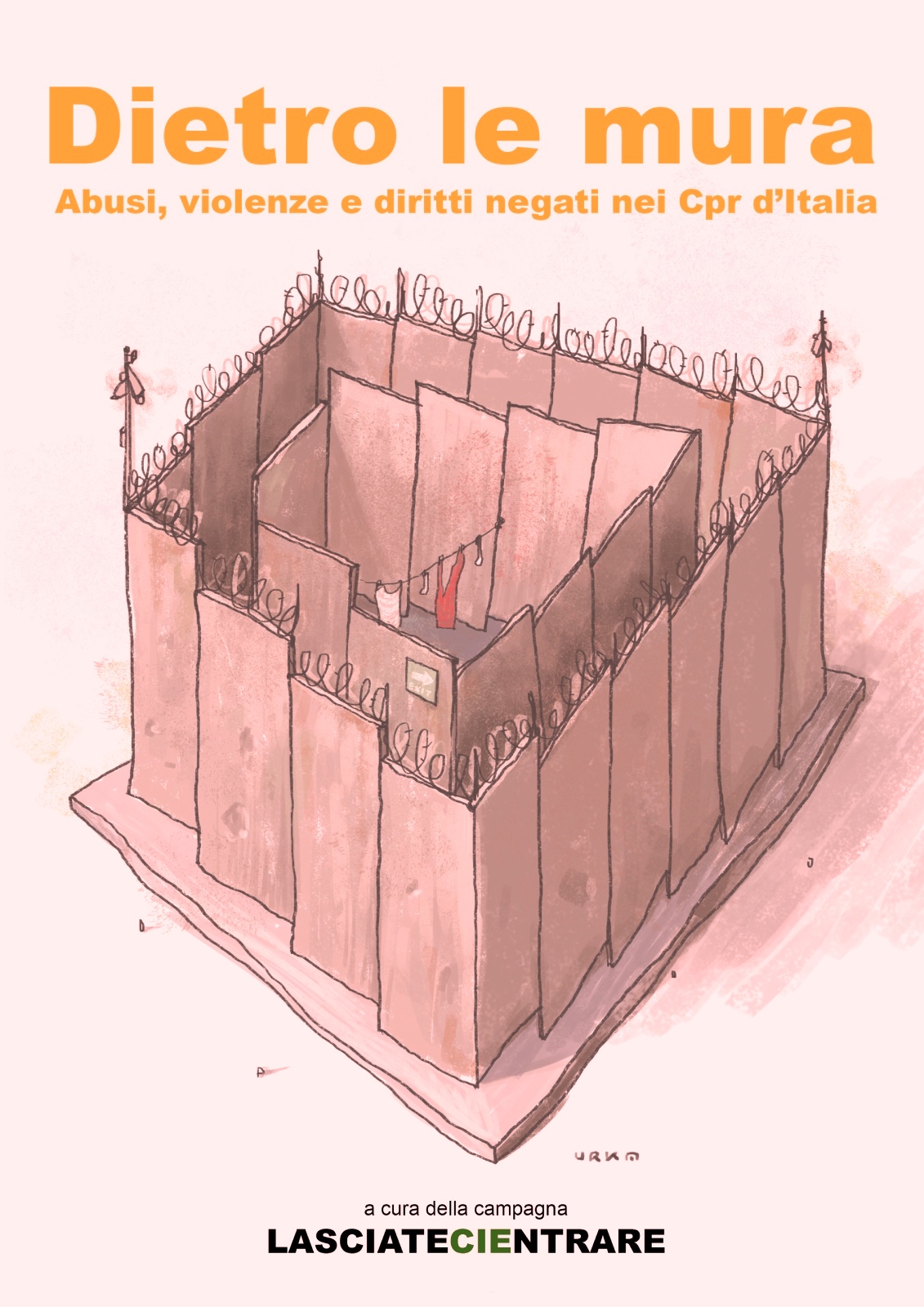 A cura della campagna LasciateCIEntrare ; Yasmine Accardo … [et al.], Dietro le mura. Abusi, violenze e diritti negati nei Cpr d’Italia, LasciateCIEntrare, [S.l.], 2022, 267 pp.
A cura della campagna LasciateCIEntrare ; Yasmine Accardo … [et al.], Dietro le mura. Abusi, violenze e diritti negati nei Cpr d’Italia, LasciateCIEntrare, [S.l.], 2022, 267 pp.
Il Dossier racconta, nella prima parte, i casi drammatici seguiti dalle attiviste e dagli attivisti nei Cpr di tutta Italia, che hanno causato la morte di tanti migranti con la sola colpa di aver raggiunto l’Europa alla ricerca di una vita migliore. La seconda parte è dedicata all’approfondimento giuridico della detenzione amministrativa, che, secondo gli autori, colpevolizza il migrante e favorisce i gestori di questi centri, dove attivisti, giornalisti e parlamentari non possono entrare liberamente per informare l’opinione pubblica di quanto avviene al loro interno. Nell’appendice, tabelle comparative e dati statistici aiutano a comprendere il fenomeno migratorio e la repressione ad esso collegata, al di là della narrazione costruita per favorire paure ed insicurezza care ad una certa politica. Completano il volume interviste a psichiatri e operatori che raccontano il loro vissuto all’interno di queste strutture.
Chima Agazue, “My Daughter Was Sacrificed by My Mother”. Women’s Involvement in Ritually Motivated Violence and Murder in Contemporary Africa, in Dignity, n. 5 (2021) – on line, vol. 6, pp. 1-28
I crimini motivati dal rituale sono crimini gravi che continuano ad affliggere l’Africa contemporanea. Sebbene prendano forme diverse, la maggior parte di essi comporta atti brutali di violenza e omicidio. Tradizionalmente gli autori di questi crimini efferati erano uomini, ma ultimamente sono stati agiti anche da donne. Pertanto, i ricercatori in criminologia e psicologia criminale hanno rivolto una crescente attenzione al coinvolgimento delle donne. L’industria della magia africana infatti attrae sia uomini che donne come clienti, stregoni e ritualisti. Come gli stregoni maschi, le donne allo stesso modo ingaggiano cacciatori di corpi umani e rapitori per trovare vittime. Le donne lavorano indipendentemente o come complici dei maschi che rapiscono, attaccano o uccidono coloro che sono presi di mira a scopi rituali. Mentre il coinvolgimento delle donne in diversi tipi di crimini violenti e omicidi è ben documentato, la partecipazione delle donne a violenze e omicidi motivati da rituali è stata eccessivamente trascurata nella letteratura accademica. Questo articolo mira a colmare questo divario. L’autore è un ricercatore universitario inglese.
Medici per i Diritti Umani (MEDU) e Agenzia ONU per i rifugiati (UNHCR), Margini. Rapporto sulle condizioni socio-sanitarie di migranti e rifugiati negli insediamenti informali della città di Roma, MEDU, UNHCR, Roma, 2022, 60 pp.
Nella città di Roma oltre 14mila individui vivono sulla strada o in situazioni abitative di grave precarietà. La pandemia da Covid-19 ha contribuito ad accrescere il numero di queste persone e ad aggravarne le condizioni di vita. Questo rapporto, realizzato da Medici per i Diritti Umani (MEDU) in collaborazione con l’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR), si pone l’obiettivo di raccontare in modo lucido e accurato – attraverso dati, immagini e testimonianze dirette – le condizioni socio-sanitarie di migranti, richiedenti asilo e rifugiati che vivono in alcuni dei più grandi insediamenti informali della capitale d’Italia, tra edifici occupati ed aree intorno alle grandi stazioni ferroviarie. Sulla base della realtà fotografata dagli operatori e dei volontari di MEDU, il rapporto propone un’analisi delle numerose e gravi criticità rilevate ma anche di alcune buone pratiche emerse nel corso della pandemia, formulando raccomandazioni alle istituzioni locali e nazionali, nel tentativo di contribuire a riportare tra le priorità della politica la salute e i diritti di una popolazione vulnerabile confinata ai margini socio-esistenziali, prima ancora che geografici, delle nostre città. Sull’azione di MEDU nel mondo si veda anche il loro Rapporto annuale Gennaio 2020 – Giugno – 2021 e il Report sul Consultorio Persefone. Donne migranti vittime di tratta, violenze e torture.
MEDU Medici per i diritti umani, La fabbrica della tortura. Rapporto sulle gravi violazioni dei diritti umani dei migranti e dei rifugiati in Libia (2014-2020) : marzo 2020, Medici per i diritti umani, Roma, 2020, 52 pp.
Il rapporto si basa su oltre tremila testimonianze dirette di migranti e rifugiati transitati dalla Libia, raccolte dagli operatori di Medici per i Diritti Umani (MEDU) nell’arco di sei anni dal 2014 al 2020. Analizza questo periodo sotto tre punti di vista: 1) i flussi migratori che giungono in Italia dalle coste libiche; 2) il sistema di abusi e di sfruttamento che si consuma in Libia ai danni di migranti e rifugiati; 3) le conseguenze psico-fisiche delle violenze subite. Viene inoltre approfondito il confronto tra due fasi: i tre anni che precedono l’accordo Italia-Libia sui migranti (febbraio 2014 – gennaio 2017) e i tre anni successivi al medesimo accordo (febbraio 2017 – gennaio 2020). Disponibili anche le conclusioni e la mappa.
Aspetti psicologici e linee di intervento
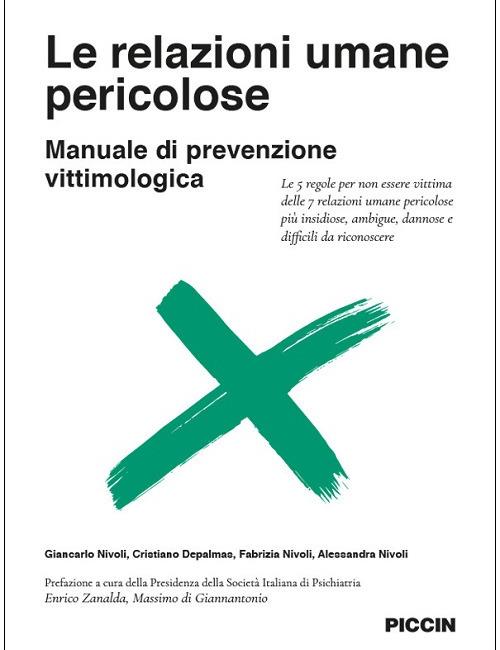 Giancarlo Nivoli, Cristiano Depalmas, Fabrizia Nivoli, Le relazioni umane pericolose. Manuale di prevenzione vittimologica. Le 5 regole per non essere vittima delle 7 relazioni umane pericolose più insidiose, ambigue, dannose e difficili da riconoscere, Piccin, Padova 2022, 141 pp.
Giancarlo Nivoli, Cristiano Depalmas, Fabrizia Nivoli, Le relazioni umane pericolose. Manuale di prevenzione vittimologica. Le 5 regole per non essere vittima delle 7 relazioni umane pericolose più insidiose, ambigue, dannose e difficili da riconoscere, Piccin, Padova 2022, 141 pp.
Molte relazioni pericolose hanno una caratteristica comune: si presentano spesso in modo insidioso e inizialmente appaiono anche piacevoli e gratificanti. In questo libro utile e attuale, gli autori (Giancarlo Nivoli, Cristiano Depalmas, Fabrizia Nivoli e Alessandra Nivoli) aiutano i lettori a riconoscere subito gli indizi di una relazione pericolosa e offrono delle strategie di intervento preventivo e di assistenza psico-socio-giudiziaria, sia alle vittime che agli aggressori. Il libro si sofferma in particolare su un campione che comprende la manipolazione dissociale, la violenza psicologica, le relazioni virtuali dannose, il bullismo, le molestie nel privato e sul luogo di lavoro e la perversione narcisista, che possono tutte costituire la base sulla quale si possono poi sviluppare relazioni che in casi estremi portano all’omicidio, alle guerre, ai crimini contro l’umanità. Prefazione a cura della Presidenza della Società italiana di psichiatria (Enrico Zanalda, Massimo di Giannantonio).
In arrivo in Biblioteca
Natalie Sclippa, Figli violenti, uscirne si può. Intervista ad Adriana Casagrande, in lavialibera, n. 16 (2022), pp. 18-21
Adriana Casagrande, psicologa e psicoterapeuta che da tanti anni si occupa di dipendenze al Gruppo Abele, racconta nell’intervista come negli ultimi anni sia aumentato il numero di richieste di aiuto da parte di genitori che subiscono maltrattamenti e atti di violenza da parte dei figli. E’ nato così il progetto del Gruppo Abele “Querce di Mamre” con l’obiettivo di accompagnare le famiglie in difficoltà e aiutarle a ritrovare equilibrio e serenità.
Enhancing Stakeholder Awareness and Resources for Hate Crime Victim Support (EstAR), Quality Specialist Support Services for Hate Crime Victims. Training Course, OSCE, Vienna, 2022, 133 pp.
Il corso di formazione sulla qualità dei servizi di supporto specialistico per le vittime di crimini motivati dall’odio è stato sviluppato nell’ambito del progetto Enhancing Stakeholder Awareness and Resources for Hate Crime Victim Support (EStAR) e attuato dall’Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR) dell’OSCE, in collaborazione con l’Associazione dei Centri di consulenza per le vittime della violenza di destra, razzista e antisemita in Germania (VBRG). I crimini d’odio sono una manifestazione di discriminazione e intolleranza con un profondo impatto sulle vittime, sulle comunità e sulle società. Le vittime necessitano di servizi specializzati che le aiutino a riprendersi da queste violenze, per consentire loro di partecipare efficacemente al processo giudiziario penale e di riacquistare un senso di autonomia. Questo supporto personalizzato comprende aiuto pratico, sostegno emotivo e psicosociale, consulenza su questioni legali e finanziarie e lavoro di comunità. Su questo progetto si vedano anche i seguenti documenti del Enhancing Stakeholder Awareness and Resources for Hate Crime Victim Support (EstAR), Hate crime victim support. Policy brief, OSCE/ODHIR, [S.l.], 2022, 49 pp.; Structural Arrangements for Hate Crime Victim Support. Policy Brief, Vienna, OSCE, 2022, 46 pp.; Practices of civil society and government collaboration for effective hate crime victim support. Compendium, [S.l.], OSCE, 2022, 41 pp.; Policy Brief: Specialist Support for Hate Crime Victims, Vienna, OSCE, 2022, 29 pp.
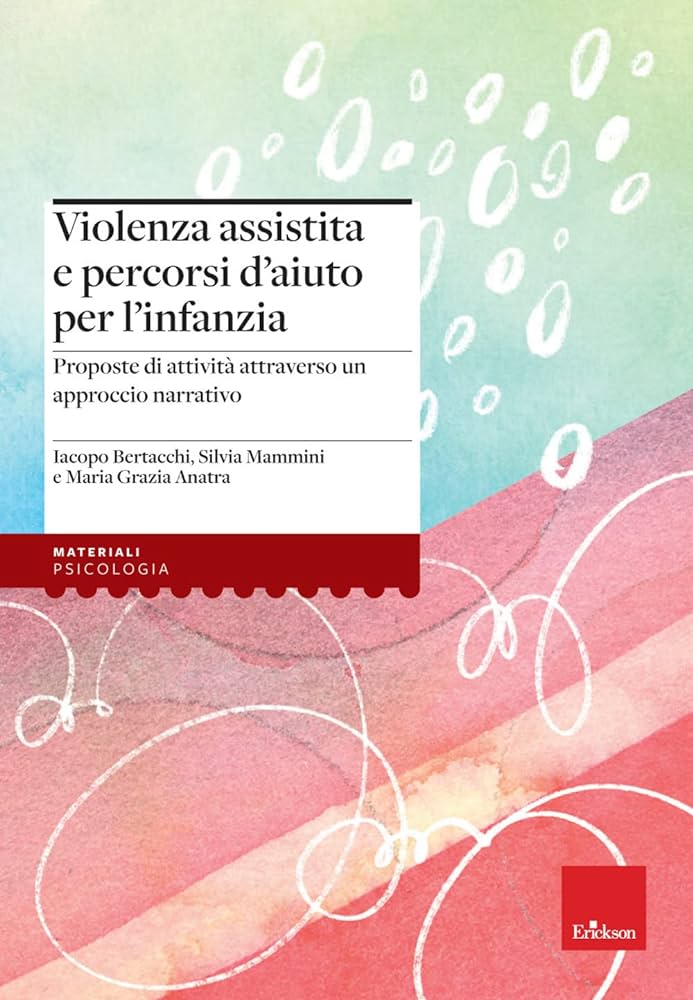 Iacopo Bertacchi, Silvia Mammini, Maria Grazia Anatra, Violenza assistita e percorsi d’aiuto per l’infanzia. Proposte di attività attraverso un approccio narrativo, Erickson, Trento, 2022, 149 pp.
Iacopo Bertacchi, Silvia Mammini, Maria Grazia Anatra, Violenza assistita e percorsi d’aiuto per l’infanzia. Proposte di attività attraverso un approccio narrativo, Erickson, Trento, 2022, 149 pp.
ll libro fornisce proposte d’intervento nei casi di violenza assistita, da utilizzare nella pratica quotidiana di chi opera nei percorsi di tutela minori, nei centri antiviolenza o in ambito clinico/terapeutico. Il volume si compone di un manuale e un albo illustrato. I clinici, psicologi o psicoterapeuti potranno utilizzare il racconto presente nell’albo e le attività proposte nel manuale per svolgere un percorso, in setting individuale o di gruppo, con bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni che hanno vissuto in contesti di violenza domestica allo scopo di aiutarli a prendere contatto con i propri vissuti emotivi, a rielaborare le proprie esperienze in un contesto protetto per costruire un senso di sé più integrato e positivo. Il volume si rivolge anche agli insegnanti interessati ad approfondire la conoscenza della violenza assistita e a sviluppare una maggiore sensibilità e capacità di lettura rispetto alla sua complessità.
Collocazione Biblioteca: 19739
National Referral Mechanisms. Joining efforts to protect the rights of trafficked persons. A practical handbook – Second edition, Varsavia, OSCE, 2022, 385 pp.
I meccanismi nazionali di riferimento (National Referral Mechanisms=NRM) sono meccanismi istituzionali che permettono agli Stati di identificare, proteggere e assistere le vittime della tratta, attraverso il coinvolgimento dell’autorità pubblica e della società civile. Questo documento costituisce una guida che i paesi aderenti all’OSCE possono adattare e applicare ai propri sistemi nazionali, per assicurarsi che i propri NMR siano appropriati. Fornisce una panoramica dei metodi di lavoro, delle procedure e dei servizi che sono richiesti attraverso quattro pilastri fondamentali: identificazione e protezione; supporto individuale e accesso ai servizi; inclusione sociale; giustizia e risarcimento. Questa seconda edizione pone un accento particolare sul traffico dei minori e sulla salute. Sul tema si consulti anche le raccomandazioni contenute nel documento dell’ Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Model Guidance on Sensitive and Respectful Treatment of Hate Crime Victims in the Criminal Justice System, Vienna, OSCE, 2021, 61 pp. e la guida alla valutazione dei bisogni individuali (Individual Needs Assessment – INA) delle vittime dei crimini d’odio: Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Model Guidance on Individual Needs Assessments of Hate Crime Victims, Vienna, OSCE , 2021, 51 pp.
Alfredo De Risio, Matteo Pio Ferrara, Lorenzo Cristilli, InContro l’adulto maltrattante. Percorsi conoscitivi e prospettive di cambiamento, Alpes Italia, Roma, 2022, 132 pp.
Il volume nasce da un’esigenza importante, quella di spostare l’attenzione dalla violenza come problema delle donne alla violenza come questione maschile, prendendo in considerazione quindi il soggetto che esercita la violenza stessa. Le Raccomandazioni del Consiglio D’Europa (2002) 5, invitano gli Stati membri a pianificare interventi rivolti a uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive, intesi come misura aggiuntiva alla sentenza di condanna, volta a prevenire futura violenza. L’Italia, in questo percorso virtuoso, sconta un ritardo scientifico, culturale e legislativo nelle azioni di intervento psicologico e riabilitativo ad indirizzo dell’uomo abusante. Da tale consapevolezza è derivata la volontà degli Autori di scrivere un testo il più possibile sintetico e “pratico”, di facile consultazione, centrato sui problemi concreti dell’intervento ad indirizzo di partner violenti, nella consapevolezza che è solo nello sviluppo di una rete competente, di azioni e di servizi, che si possono superare le tante difficoltà insite nel problema.
In arrivo in biblioteca
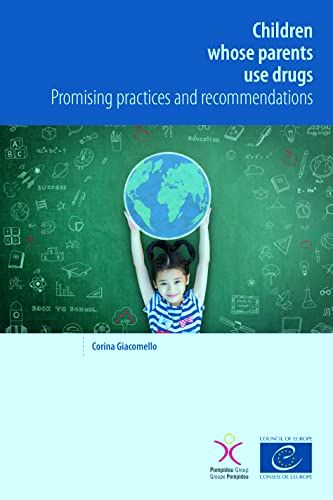 Corina Giacomello, Children whose parents use drugs. Promising practices and recommendations, Council of Europe, Strasburgo, 2022, 96 pp.
Corina Giacomello, Children whose parents use drugs. Promising practices and recommendations, Council of Europe, Strasburgo, 2022, 96 pp.
Il documento affronta il tema delle famiglie dove i genitori fanno uso di sostanze o alcool in modo problematico e dei servizi di supporto al riguardo. Descrive un insieme di interventi presenti in diversi paesi e mirati alle famiglie e ai figli: servizi per le madri che usano sostanze; servizi per il trattamento della dipendenza che tengono conto delle responsabilità parentali, dei bisogni dei figli e di situazioni particolari; rifugi per donne vittime di violenza che usano sostanze. Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale che ha lo scopo di promuovere la democrazia, i diritti umani, l’identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali nei Paesi in Europa. Altri documenti sull’argomento si trovano a questo link.
G. Ruggeri, S. Pignataro, A. Argemandy Naghad, Lo stalking nella relazione di coppia. Rassegna delle ricerche empiriche e valutazione delle possibilità di prevenzione, Diritto Più, Castel San Giorgio (SA), 2022, 121 pp.
Nel volume vengono rilevate le tipologie di stalker, i comportamenti, le motivazioni e i tipi di vittima. In particolare viene approfondito l’argomento con analisi sugli effetti psicologici e sociali delle vittime. Oltre a rilevare alcune teorie psicodinamiche sullo stile di attaccamento dello stalker il libro offre una comparazione del fenomeno in Italia e in Europa e propone strategie di intervento.
Collocazione Biblioteca: 19728
Derald Wing Sue, Lisa Beth Spanierman, Le microaggressioni. La natura invisibile della discriminazione, Raffaello Cortina, Milano, 2022, 297 pp.
Il testo presenta il concetto di “microaggressioni”, ne classifica le tipologie e offre soluzioni per individuarle e affrontarle a livello individuale, di gruppo e di comunità ed esplora le motivazioni di chi le agisce e di chi le subisce. Razzismo, sessismo, eterosessismo e altre forme sottili di aggressione possono essere relativamente invisibili, ma comunque dannose per l’autostima e la qualità della vita di chi appartiene a categorie stigmatizzate. Le microaggressioni vengono studiate in diversi contesti, quali scuola e aziende, e ogni capitolo si conclude con la sezione “Direzioni future” che fornisce linee guida e interventi. Gli autori sono docenti di Counseling in università statunitensi.
Collocazione Biblioteca: 19878
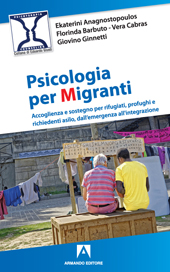 Ekaterini Anagnostopoulos … [et al.], Psicologia per Migranti. Accoglienza e sostegno per rifugiati, profughi e richiedenti asilo, dall’emergenza all’integrazione, Armando, Roma, 2021, 187 pp.
Ekaterini Anagnostopoulos … [et al.], Psicologia per Migranti. Accoglienza e sostegno per rifugiati, profughi e richiedenti asilo, dall’emergenza all’integrazione, Armando, Roma, 2021, 187 pp.
La presenza in Italia di persone che richiedono protezione, fuggendo da situazioni di guerra, è diventata ormai abbastanza consistente e ha stimolato risposte su numerosi piani, compreso quello del supporto psicologico. Il libro, attingendo all’analisi teorica ed all’esperienza operativa, presenta il modello pluralistico integrato che trae fondamento dalla psicologia umanistica e fenomenologico-esistenziale, oltre ad avvalersi dei contributi della psicologia dell’emergenza e della psicologia di comunità. Gli autori sono psicologi e psicoterapeuti. Si consulti anche il testo di Silvia Torresin, Anime altre. Psicoterapia e migrazione, Mimesis, Milano ; Udine, 2021, 88 pp. (coll. Bibl. 18908).
Collocazione Biblioteca: 19931
Ordine degli Psicologi del Lazio ; a cura di Vera Cuzzocrea, Melania Scali, Elisa Spizzichino, Le Vittime nel processo penale. Dall’ascolto alla valutazione psicologico-giuridica: aspetti descrittivi, strumenti operativi e buone prassi, Franco Angeli, Milano, 2021, 134 pp.
L’Ordine degli Psicologi del Lazio da anni contribuisce al dibattito tecnico-scientifico sulle buone prassi in sede processuale, in particolare penale, anche in considerazione del contributo specialistico fornito dagli psicologi sia nella raccolta della prova testimoniale sia nella valutazione di questa. Il volume intende quindi essere un’occasione per esaminare la gestione delle vittime in condizione di vulnerabilità nelle varie fasi dell’iter giudiziario e per riflettere sulle buone prassi da adottare. Ciò alla luce delle diverse innovazioni della ricerca scientifica sul campo, delle disposizioni europee e dei diversi cambiamenti normativi e procedurali introdotti in Italia negli ultimi anni.
Collocazione Biblioteca: 19106
A cura di Roberta Luberti e Caterina Grappolini, Violenza assistita, separazioni traumatiche, maltrattamenti multipli. Percorsi di protezione e di cura con bambini e adulti. Nuova ed. agg., Erickson, Trento, 2021, 482 pp.
Separazioni conflittuali gravi, violenza domestica e assistita, perdite familiari traumatiche sono eventi complessi e difficilmente elaborabili senza il supporto di un intervento psicoterapeutico mirato. Il libro affronta questo genere di fenomeni partendo proprio dalla loro definizione concettuale, per poi disegnare una «mappa» della diffusione della cultura sulla cura del trauma in Italia, con un’attenzione specifica alla presa in carico delle vittime, sia adulti che minori. Vengono inoltre presentati percorsi riparativi, focalizzati prevalentemente sugli effetti post-traumatici, a breve e a lungo termine, e sulla prevenzione del ciclo intergenerazionale della violenza. Il volume illustra i possibili percorsi terapeutici, soffermandosi sulla comprovata efficacia dell’approccio EMDR.
Collocazione Biblioteca: 18870
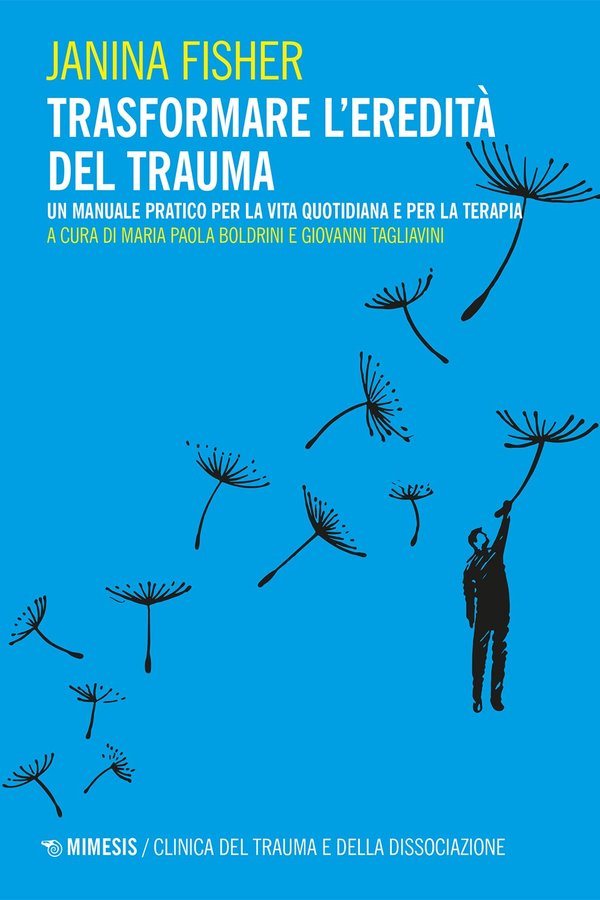 Janina Fisher ; a cura di Maria Paola Boldrini e Giovanni Tagliarini, Trasformare l’eredità del trauma. Manuale pratico per la vita quotidiana e per la terapia, Mimesis, Milano ; Udine, 2021, 173 pp.
Janina Fisher ; a cura di Maria Paola Boldrini e Giovanni Tagliarini, Trasformare l’eredità del trauma. Manuale pratico per la vita quotidiana e per la terapia, Mimesis, Milano ; Udine, 2021, 173 pp.
Questo manuale è stato ispirato dalle idee di due dei pionieri più influenti in campo psicotraumatologico: Judith Herman e Bessel van der Kolk. Oltre a loro, un decisivo contributo è arrivato dai survivor, persone che hanno vissuto esperienze traumatiche di vario tipo e in varie epoche della loro vita. In questo contesto scientifico e clinico, è diventato storicamente sempre più importante informare ed educare le persone sui loro sintomi e reazioni. Secondo Janina Fisher, dovremmo cercare di spiegare, in modo comprensibile per ogni survivor, anche altri concetti complessi, proprio perché la ricerca ha dimostrato che la memoria di lavoro e la capacità di espressione verbale vengono compromesse dalle reazioni post-traumatiche. Al fine di semplificare queste informazioni e renderle accessibili ai pazienti in psicoterapia, Janina Fisher ha scoperto, attraverso l’esperienza clinica e lo studio della letteratura di ricerca, l’importanza di lavorare con gli strumenti immediati della psicoeducazione, come, per esempio, semplici diagrammi, in modo che vi siano meno parole da elaborare. Il libro è di fatto supporto tecnico per i clinici e per i pazienti in ogni percorso terapeutico “trauma informed”. Sul tema si consulti anche il testo di Antonella Montano e Roberta Borzì, Manuale di intervento sul trauma. Comprendere, valutare e curare il PTSD semplice e complesso, Erickson, Trento, 2019, 353 pp. (Coll. Bibl: 18475).
Collocazione Biblioteca: 19238
A cura di Giada Maslovaric, EMDR di gruppo. Insieme verso il BenEssere. Protocolli di intervento, ApertaMenteWeb, Roma, 2020, 414 pp.
La curatrice, psicologa, psicoterapeuta, coordinatrice degli interventi clinici per l’Associazione EMDR Italia (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari) durante disastri naturali ed emergenze, presenta l’applicazione di gruppo di questa terapia, utile per il trattamento di disturbi causati da eventi stressanti o traumatici. Nella prima parte del volume vengono descritte le fondamenta del protocollo di gruppo, con riflessioni e schede di lavoro per orientare il clinico, a cui si rivolge. La seconda parte è dedicata alle declinazioni dell’EMDR di gruppo nelle diverse fasce d’età, mentre la terza approfondisce l’utilizzo della terapia nel gruppo famiglia su traumi specifici. La quarta parte è dedicata ai contesti emergenziali, con i contributi di diversi autori che hanno partecipato agli interventi di supporto, ad esempio, per gli operatori sanitari in occasione della pandemia di Covid-19, nei centri di accoglienza per migranti, ai minori orfani siriani. Infine, la quinta parte esplora alcune potenzialità di applicazione della terapia con gruppi omogenei di pazienti, ad esempio oncologici, carcerati, colleghi di una persona suicida, o persone con dipendenze patologiche.
Collocazione Biblioteca: 18707
Michel Dorais, Succede anche ai ragazzi. L’abuso sessuale al maschile, Armando, Roma, 2020, 264 pp.
Le testimonianze contenute nel libro ripercorrono le domande esistenziali che affliggono le vittime maschili di aggressioni sessuali e illustrano in che modo essi riescano a liberarsi dal fantasma di tali aggressioni, suggerendo alcune strategie di assistenza e prevenzione. Si tratta di uno dei pochi testi sul tema che sia in grado di comprendere e di aiutare al meglio le vittime maschili di violenza sessuale. L’autore è sociologo della sessualità, docente e ricercatore in Canada.
Collocazione Biblioteca: 19566
Gli autori di reato e la giustizia riparativa
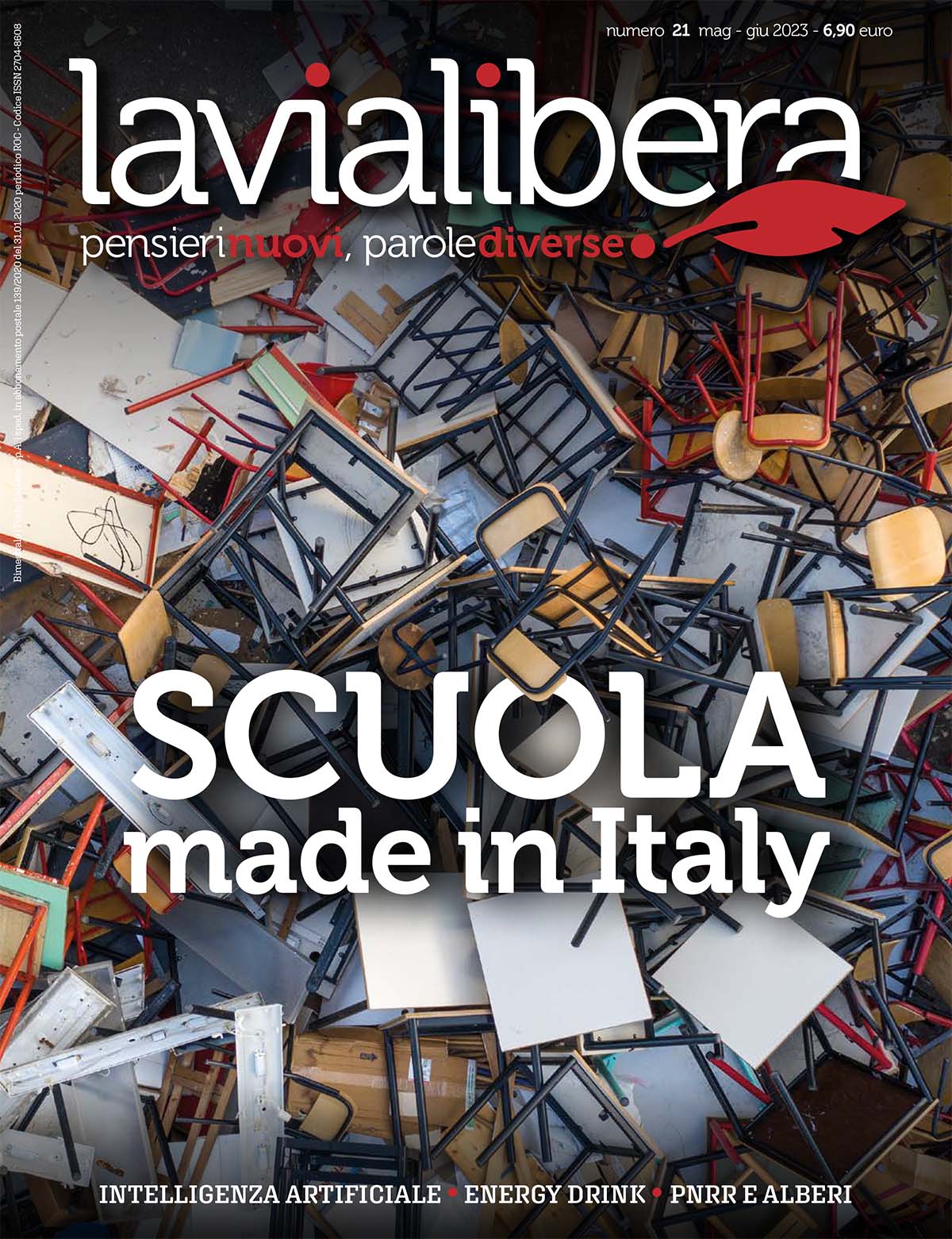 Dani Amza, Giuseppe Sami, Amin, Non siamo i reati che abbiamo commesso, in lavialibera, n. 21 (mag. – giu. 2023), pp. 68-69
Dani Amza, Giuseppe Sami, Amin, Non siamo i reati che abbiamo commesso, in lavialibera, n. 21 (mag. – giu. 2023), pp. 68-69
Un gruppo di giovani tra i 18 e 25 anni, detenuti nel carcere di Torino, ha scritto una lettera alla città denunciando il modo con cui i media parlano di baby gang. I ragazzi dicono che non rispettando la loro privacy, pubblicando quindi nomi e cognomi, etichettandoli, di fatto viene negato loro il diritto di potersi ricostruire una vita nella legalità. Oggi questi ragazzi dicono di avere paura di uscire dal carcere per andare in un mondo che tende a giudicare anziché dare opportunità. Inoltre, dicono, l’esclusione sociale inizia con l’articolo di giornale e continua col tempo vuoto “dalla branda al carrello” mentre il tempo della pena dovrebbe permettere di acquisire nuove consapevolezze.
Dorotea Lo Bianco, La coprogettazione sociale per lo sviluppo di una giustizia di comunità, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 53, n. 1 (2023), pp. 26-29
L’intento dell’articolo è quello di costruire insieme una definizione di “coprogettazione”, delimitando un quadro concettuale che possa contenere le rispettive declinazioni nell’ambito dei servizi sociali e, soprattutto, tentare di trasporre tale strumento nell’ambito del trattamento intramurario ed extramurario orientato al paradigma della giustizia riparativa.
A cura di Isabella Mastropasqua, Ninfa Buccellato, 2° Rapporto nazionale sulla giustizia riparativa in area penale, Gangemi, Roma, 2022, 591 pp.
Il “2° Rapporto sulla Giustizia riparativa in area penale”, curato dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, è un lavoro che intende rappresentare e condividere la centralità, oltre che la significativa evoluzione, che si auspica in progressiva crescita, dei programmi di giustizia riparativa tra le attività del Dipartimento. Un cammino che può considerarsi ufficialmente avviato grazie al processo di riforma che dal 2017 ha fissato, tra gli obiettivi dipartimentali, la giustizia riparativa e la prevenzione della devianza: ambiti di studio ed intervento fortemente interconnessi, rispondenti alle indicazioni normative sovranazionali, anche in materia di “probation” e di tutela delle vittime, orientati al miglioramento della qualità dei programmi di reinserimento e delle relazioni sociali anche in funzione di sviluppo di sicurezza sociale. L’istituzione di uno specifico Ufficio dipartimentale dedicato ha favorito il rafforzamento di attività istituzionali orientate all’implementazione di un modello di giustizia penale in grado di configurare scenari complementari ed innovativi: la commissione del reato inteso non solo come violazione di un precetto in una prospettiva statica, ma quale lacerazione di un equilibrio sociale tra “individui” e tra “individuo e comunità”.
Collocazione Biblioteca: 86R02
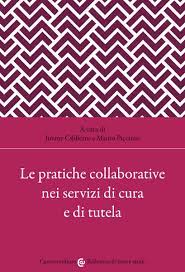 A cura di Jimmy Ciliberto, Mauro Piccinin, Le pratiche collaborative nei servizi di cura e di tutela, Carocci, Roma, 2022,175 pp.
A cura di Jimmy Ciliberto, Mauro Piccinin, Le pratiche collaborative nei servizi di cura e di tutela, Carocci, Roma, 2022,175 pp.
Il volume descrive una serie di pratiche – Dialogo aperto, Giustizia riparativa, Tutela minorile collaborativa, Riunioni di famiglia – la cui efficacia e versatilità sono state riconosciute, a livello internazionale, nel lavoro di cura e tutela delle famiglie vulnerabili. Gli approcci e gli strumenti presentati nel testo «forniscono un quadro operativo di intervento, ma anche una prospettiva epistemologica che capovolge il modo stesso di concepire l’intervento e i personaggi che lo popolano». Il libro è dunque un contributo rivolto a psicologi, assistenti sociali, educatori e docenti, sia in formazione sia già inseriti nei servizi sociali, sanitari, educativi, scolastici in particolare. Gli autori sono psicologi e psicoterapeuti.
Collocazione Biblioteca: 19759
Patrizia Patrizi, Le sfide aperte dall’integrazione delle tutele e dal cambiamento dei soggetti, in Minorigiustizia, n. 4 (2022), pp. 17-93
La monografia di questo numero propone diversi articoli sul contrasto alla tendenza in atto nella nostra giurisdizione, compresa quella minorile, a frammentare la propria azione in singoli atti e procedimenti su cui attestare indicatori di efficienza, a scapito di una visione unitaria e delle stesse possibilità di trasformazione dei destinatari di questa azione. I contributi raccolti sono i seguenti: 1) “La giustizia riparativa: per disfare ingiustizia” di Patrizia Patrizi; 2) “Il carcere minorile tra superamento e riforma” di Susanna Marietti; 3) “Strutture comunitarie per adolescenti con sofferenza psichica. Preziose opportunità e pericolose scelte di politica socio sanitaria” di Claudio Bencivenga; 4) “Le misure amministrative alla prova della Riforma Cartabia: “post fata resurgo” di Andrea Conti: 5) “Le misure rieducative nell’ambito del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: alcune prime osservazioni” di Raffaele Bianchetti; 6) “Una riflessione sull’attualità della competenza amministrativa” di Aldo Alberti et al.; 7) “Minorenni traviati, irregolari, sfuggenti: la freccia dei tempi e le incognite del presente nei procedimenti amministrativi” di Alessandro Rudelli.
Riccardo Battistoni, La persona offesa tra esigenze deflattive e bisogno di tutela, in Studi sulla questione criminale, a. 16, n. 3 (2021), pp. 35-66
La forma di tutela della persona offesa oggi si fonda sulla giustizia riparativa e, conseguentemente, sulla mediazione. Il sistema penale non nasce come luogo deputato alla protezione e alla tutela della vittima , ma di recente si è acceso un dibattito in ordine alla compatibilità della “Restorative Justice” col sistema penale. L’articolo propone un caso effettivo.
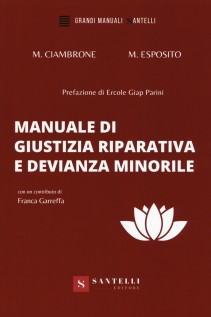 Maria Cristina Ciambrone, Maria Esposito, Manuale di giustizia riparativa e devianza minorile. Tra interpretazione e prevenzione, Santelli, Cosenza, 2021, 140 pp.
Maria Cristina Ciambrone, Maria Esposito, Manuale di giustizia riparativa e devianza minorile. Tra interpretazione e prevenzione, Santelli, Cosenza, 2021, 140 pp.
Il testo presenta una disamina sulla devianza in relazione all’età evolutiva, permettendo ai destinatari (soggetti con formazione giuridica, psicologica, sociale e pedagogica) di sviluppare un’analisi psicologica e sociologica del fenomeno e del conseguente, dove accade, passaggio ad atti di criminalità. Una forma di prevenzione alle varie forme di devianza che si sviluppano fra i minori è la mediazione penale, che si sta divulgando capillarmente come strategia di riparazione alle conseguenze che i crimini, perpetrati in età evolutiva, possono generare nella vittima, ma anche nell’autore del reato. La prima parte è dedicata alla mediazione penale ed alla giustizia riparativa con casi reali di laboratori tenuti con soggetti detenuti e non. La seconda parte ha per oggetto la devianza minorile, analizzata non solo da un punto di vista psicologico, ma anche sociale e con un particolare accento posto sulle dipendenze in età evolutiva, spesso segno e sintomo di forme di devianza nascenti.
Collocazione Biblioteca: 19740
Francesco Chiavarini, Elisa Rossignoli, Giustizia che fa bene, in Scarp de’ tenis, a. 26, n. 254 (ott. 2021), pp. 32-37
Uno dei punti più interessanti del disegno di legge sulla riforma del processo penale promosso dalla Ministra Cartabia è quello che incentiva il ricorso alle pene alternative e disciplina in modo organico la cosiddetta giustizia riparativa. L’obiettivo è quello di promuovere percorsi tra chi ha commesso il reato, le vittime e la comunità. Nell’articolo viene presentata l’esperienza di Casa Abramo a Lecco.
Silvia Clementi, Marzia Tosi, La giustizia riparativa nel lavoro di gruppo: analisi di un progetto con gli imputati in messa alla prova all’Uepe di Mantova, in Studi sulla questione criminale, a. 16, n. 1 (2021), pp. 49-82
L’articolo presenta i risultati della valutazione di un progetto di responsabilizzazione e giustizia riparativa rivolto a persone in messa alla prova, imputate in un procedimento penale per guida sotto l’effetto di alcool o sostanze. Caratteristiche del progetto sono l’approccio relazionale al lavoro sociale, il coinvolgimento di diversi attori del territorio, l’adozione di un modello di giustizia di comunità. I dati qualitativi e quantitativi raccolti mostrano gli aspetti positivi del progetto, secondo gli autori meritevole di continuazione.
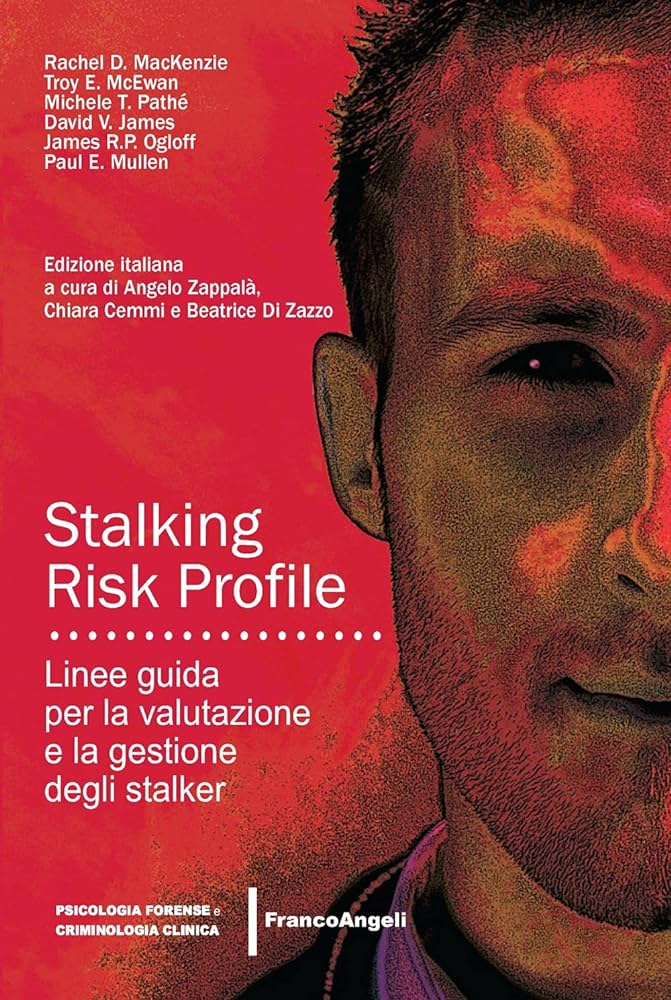 Rachel D. MacKenzie … [et al.] ; edizione italiana a cura di Angelo Zappalà … [et al.], Stalking Risk Profile. Linee guida per la valutazione e la gestione degli stalker, Franco Angeli, Milano, 2021, 260 pp.
Rachel D. MacKenzie … [et al.] ; edizione italiana a cura di Angelo Zappalà … [et al.], Stalking Risk Profile. Linee guida per la valutazione e la gestione degli stalker, Franco Angeli, Milano, 2021, 260 pp.
Il volume è un manuale operativo, rivolto a medici, psicologi, magistrati, avvocati assistenti sociali e operatori delle forze dell’ordine, per la valutazione dei casi di stalking e la gestione del rischio. Oltre alla traduzione del testo sviluppato dal gruppo di ricerca australiano di Paul Mullen, contiene una parte sul contesto italiano dal titolo “Il fenomeno dello stalking in Italia. Uno sguardo attuale sulla tutela offerta dall’ordinamento giuridico e dal contributo delle scienze psicologiche” di Chiara Cemmi … [et al.]. Scopo dello strumento è fornire linee guida che possano supportare i professionisti nella formulazione di giudizi rispetto al rischio di potenziali agiti violenti, al rischio di recidiva e ai riflessi psicosociali sulla vittima e sul persecutore.
Collocazione Biblioteca: 19012
Carmen Iadevaia, Riflessioni sull’ambiente in RSA: quando la relazione d’aiuto diventa violenta, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 50, n.1 (inverno 2020), pp. 13-17
L’articolo indaga i meccanismi che trasformano un operatore socio-sanitario in una persona capace di atti violenti nei confronti degli assistiti, riflettendo però anche sul fenomeno inverso: gli assistiti aggressivi e violenti verso gli operatori. Vengono inoltre esaminati alcuni fattori ambientali che nelle RSA possono essere fattori predisponenti alla violenza, quali il modello organizzativo, il contesto, la comunicazione efficace. Mentre l’organizzazione motivante che mette la persona al centro dell’intervento può essere efficace nel prevenire atti di violenza.
Adolfo Ceretti, Oriana Binik, Fare ricerca su “genere e crimine” oggi. Stereotipi, dibattiti, prospettive, in Rassegna Italiana di Sociologia, A. 61, n. 3 (lug.-set. 2020), pp. 437-462
Il dibattito sul concetto di “genere”, entrato nel discorso pubblico negli ultimi anni, dando origine a battaglie per la parità, ma anche a forti polemiche e preoccupazioni, si complica ulteriormente quando si espande sino al campo criminologico, creando manifestazioni di allarme sociale. In questa cornice, gli autori si propongono di: verificare se i fenomeni oggetto di allarme sociale hanno subito un effettivo incremento; svolgere una breve rassegna della letteratura sulla dicotomia “virgin and vamps”, che connota il discorso pubblico quando intende rappresentare le donne autrici di reato, ma anche le vittime; evidenziare la rilevanza di questa dicotomia anche a livello accademico; individuare alcune linee di ricerca idonee ad arricchire tale dibattito, considerando il genere sia come “struttura” sia come “interazione”.
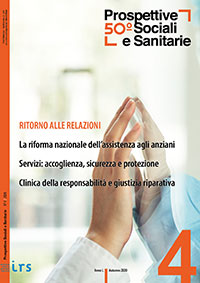 Elisa Martino, Clinica della responsabilità e giustizia riparativa, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 50, n. 4 (autunno 2020), pp. 29-33
Elisa Martino, Clinica della responsabilità e giustizia riparativa, in Prospettive Sociali e Sanitarie, a. 50, n. 4 (autunno 2020), pp. 29-33
L’articolo esplora il tema della responsabilità, muovendo dalle basi neurobiologiche che ne costituiscono il substrato cerebrale, per poi affrontarlo sul piano pratico sia come gestione dell’utente sia come strumento di lavoro per l’équipe curante. Vengono poi introdotte le pratiche della giustizia riparativa, esplorandone alcune potenzialità applicative. Infine vengono esposte alcune strategie psicosociali, basate sulla gestione e sulla rielaborazione degli agiti impulsivi dei pazienti.
Ugo Sabatello, Simona Stefanile, Persecutor and victim in the juvenile sexual crimes, in Rassegna Italiana di Criminologia, a. 49, n. 3 (2020), pp. 202-211
Nella letteratura esistente sui Juvenile Sexual Offenders (JSO), vi è una totale eclissi delle vittime e soprattutto della relazione tra la vittima e il perpetratore. Il lavoro sui JSO è finalizzato a migliorare la comprensione del fenomeno, cercando di individuare quelle variabili utili a diminuirne l’eterogeneità. Le vittime, invece, sono considerate solo ed esclusivamente in funzione dell’autore di reato o meglio come una delle possibili variabili che possono migliorare la classificazione, al pari delle caratteristiche di personalità, della storia criminale ecc.. Lo scopo di questo articolo è quello di prendere in considerazione il legame misconosciuto tra vittima e perpetratore attraverso tre direttrici: il perpetratore come vittima; il perpetratore nel sistema giuridico; la relazione del perpetratore con particolari tipi di vittime.
Stefano Natoli, Dei relitti e delle pene. Giustizia, giustizialismo, giustiziati. La questione carceraria fra indifferenza e disinformazione, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2020, 182 pp.
Secondo l’autore, giornalista e volontario presso la Casa di reclusione di Milano-Opera, oggi di carcere si parla poco e male, non tanto per raccontarne le condizioni effettive, quanto per far leva sulle paure (anche legittime) di quella parte dell’opinione pubblica malata di agnosìa e incline a un populismo giustizialista che in nome della sicurezza chiede che i cattivi vengano presi e “buttati in galera”. Il sistema carcerario costa ogni anno tre miliardi di euro e produce solo in minima parte il risultato che le assegna la Costituzione: “reinserire, a fine pena, i detenuti nella comunità”. Attualmente nelle carceri ne sono rinchiusi oltre 61mila (al febbraio 2020), 15mila in più rispetto alla capienza effettiva: un sovraffollamento disumano e indegno di un Paese civile. Una buona parte potrebbe beneficiare di misure alternative alla detenzione, che trovano però ancora scarsa applicazione. La causa del problema è a monte dell’esecuzione penale, in un sistema giudiziario carcero-centrico che va smontato pezzo a pezzo e rimontato con strumenti innovativi come la giustizia riparativa.
Collocazione Biblioteca: 19198
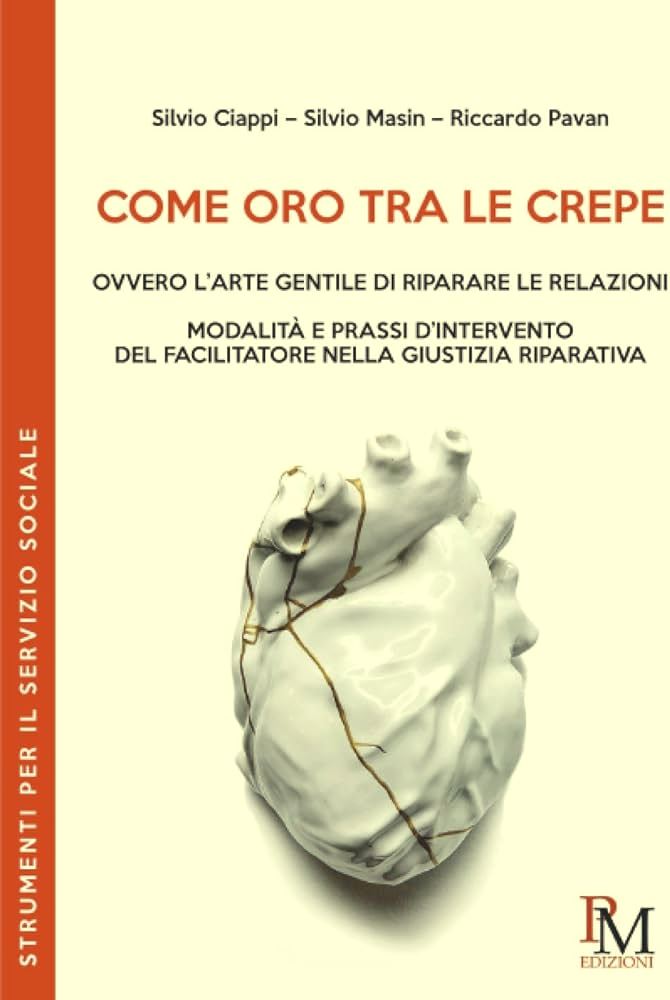 Silvio Ciappi, Silvio Masin, Riccardo Pavan, Come oro tra le crepe. Ovvero l’arte gentile di riparare le relazioni. Modalità e prassi d’intervento del facilitatore nella giustizia riparativa, PM, Varazze (SV), 2020, 154 pp.
Silvio Ciappi, Silvio Masin, Riccardo Pavan, Come oro tra le crepe. Ovvero l’arte gentile di riparare le relazioni. Modalità e prassi d’intervento del facilitatore nella giustizia riparativa, PM, Varazze (SV), 2020, 154 pp.
Il libro vuole essere un supporto metodologico alla realizzazione di percorsi e servizi di giustizia riparativa. Gli autori, a partire dalla loro esperienza concreta, muovendosi all’interno del più recente dibattito nazionale e internazionale sul tema, forniscono strategie e modelli applicativi attraverso l’introduzione delle figura del facilitatore. L’obiettivo del volume è quello di delineare un percorso di armonizzazione degli approcci in ambito riparativo attraverso un excursus tra i contributi teorici spendibili nelle pratiche di gestione dei conflitti non solo strettamente giudiziari e offrire la prospettiva di uno sguardo più ampio sulle pratiche di giustizia sociale.
Collocazione Biblioteca: 19972
Chiara Sgarbi … [et al.], Analisi retrospettiva di una serie di stalker violenti, in Rassegna Italiana di Criminologia, a. 49, n. 2 (2020), pp. 90-98.
Lo stalking è spesso accompagnato da atti violenti che talvolta possono essere gravi o addirittura letali. Il presente studio prende le mosse dai dati raccolti nel 2010 per il progetto “Stalking and Risk of Violence”, sintetizzato in un database comprendente 59 casi di stalking esitati in violenza grave. Su questo campione sono state condotte un’analisi descrittiva e un’analisi di regressione logistica univariata e multivariata alla ricerca di fattori associati all’esito violento. I risultati dell’analisi univariata rivelano che le condotte di stalking complicate da violenza grave sono accompagnate da abuso di sostanze, comportamenti di minaccia, basso livello di istruzione e precedenti condanne penali dello stalker. Dall’analisi multivariata, invece, emerge una significativa associazione tra il precedente contatto dello stalker con i centri di salute mentale e l’abuso di sostanze, la condotta di appostamento e l’esito degli atti persecutori in omicidio. Ulteriori ricerche prospettiche sono necessarie per confermare questi risultati e applicarli nei programmi di prevenzione.
